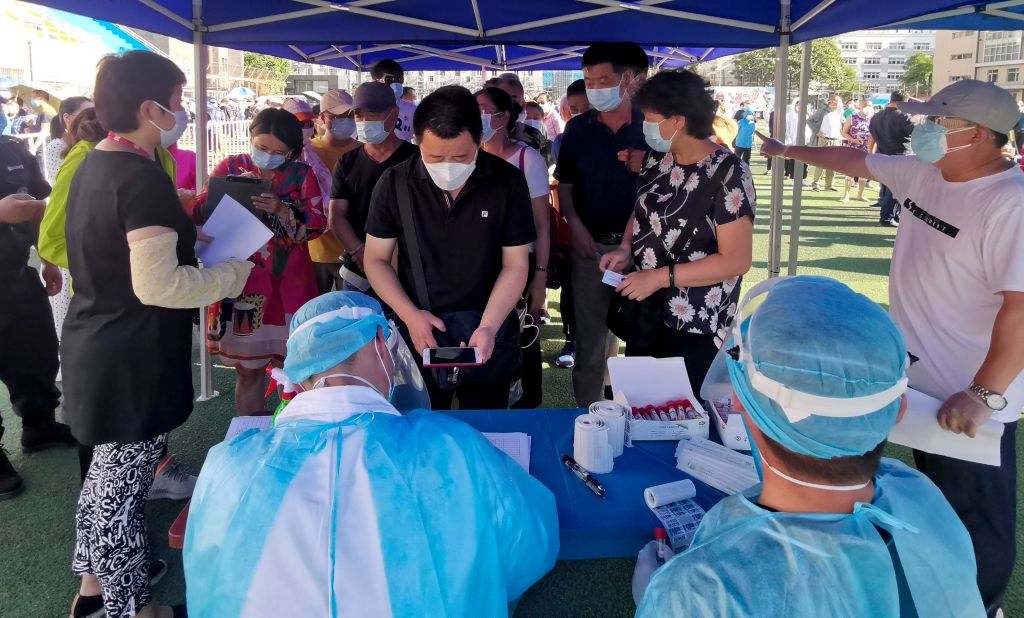Applausi dai balconi, striscioni fuori dalle finestre dei reparti, attestati di stima e gratitudine da parte di istituzioni e semplici cittadini: gli operatori sanitari impegnati nella gestione dell’epidemia di Covid19 si meritano questo e molto di più. Alcuni di loro, però, rischiano di essere più vulnerabili ed esposti al virus di altri colleghi. Oltretutto sono proprio quelli con cui veniamo a contatto più di frequente: i medici di base e quelli della guardia medica. Quelli che, al primo accenno di sintomi o di malessere conclamato, sarebbero in teoria incaricati di visitarci, rassicurarci o indirizzarci immediatamente all’ospedale, operando un triage preziosissimo che evita l’intasamento dei pronto soccorso. In teoria, appunto, perché la situazione è molto più complicata (e a tratti molto più pericolosa) di così. Non a caso ad oggi risulta che, tra i dottori deceduti in seguito all’epidemia di Covid19, 12 su 24 sono medici di base.
Il dottor Michele Marzocchi ha 35 anni, vive e lavora a Milano, è un medico di base e ha aperto uno studio insieme ad altri tre giovani colleghi. Ama molto il suo lavoro: “Dopo la laurea, quello per la scuola di specializzazione in medicina generale è stato l’unico test d’ingresso che ho voluto tentare” spiega. “Trovavo limitante il fatto di dedicarmi per tutta la vita a un unico settore della medicina, e volevo avere un rapporto più stretto e personale con il paziente”. Negli anni ha fatto rete con una serie di medici di base giovani e di nuova generazione, che hanno il suo stesso tipo di approccio e mentalità. Proprio confrontandosi tra loro, fin dall’inizio dell’inverno hanno cominciato a notare un picco anomalo di polmoniti di origine virale e strane sindromi influenzali. In Italia, però, di Coronavirus non si parlava granché. “Ci sono stati così tanti allarmi di possibili pandemie, negli anni, che ormai negli ambienti medici e scientifici eravamo quasi abituati a sottovalutarle” racconta. “Non esistevano precedenti su questa scala. Mentre in Cina infuriava l’epidemia, da noi l’ATS si concentrava come di norma su altre priorità, tipo la campagna vaccinale antinfluenzale”. L’ATS sarebbe l’Agenzia di Tutela della Salute, quella che fino al 2015 si chiamava ASL, incaricata di erogare sul territorio tutti i servizi della sanità di base, ma anche di preoccuparsi di igiene e prevenzione.
Dopo il caso del paziente 1 di Codogno è stato subito chiaro a tutto il sistema sanitario lombardo che la situazione era molto seria, e anche le istituzioni si sono attivate. “In quei giorni l’ATS ha cominciato a inviarci i protocolli per fare il triage dei pazienti” racconta il dottor Marzocchi. “Le indicazioni erano a tratti contraddittorie: in generale, però, in presenza di febbre o altri sintomi sospetti ci chiedevano di fare triage telefonico, di non visitare in studio o di non avvicinarci troppo ai pazienti”. Ovviamente è quasi impossibile applicare queste direttive, anche volendo. “Mettiamo che una persona abbia la febbre non a causa del Coronavirus, ma perché ha una broncopolmonite di altra natura, una pielonefrite, un’appendicite acuta: se ti rifiuti di visitarla, o ti limiti a raccogliere i suoi sintomi per telefono, rischi che ti sfugga qualcosa e insorgano complicanze gravi, magari anche fatali” obbietta Marzocchi. “Chi mai avrebbe il coraggio di lasciarla a se stessa?”. I professionisti coscienziosi, insomma, hanno continuato a visitare i loro pazienti. E lo hanno fatto quasi sempre senza mascherina o altri dispositivi di protezione personale.
Già, perché è qui che sta il vero problema. Secondo molti medici di base, infatti, il motivo di questi protocolli si spiegherebbe con il fatto che l’Agenzia di Tutela della Salute non era probabilmente in grado di fornire dispositivi di protezione a tutti. “Negli ospedali sono obbligati ad averne sempre un certo quantitativo in magazzino, anche perché per prassi devono essere sempre pronti alle emergenze” spiega Marzocchi. Per qualche motivo, però, non sono mai giunti tra le mani dei medici di base: “Il suggerimento era di acquistarli autonomamente, ma erano già quasi introvabili”. A un certo punto, dopo un paio di settimane dall’inizio dell’emergenza, qualcosa è arrivato, ma in quantità del tutto inadeguate alla situazione: la prima volta (4 marzo) i presidi di medicina generale milanesi si sono visti recapitare otto mascherine chirurgiche a testa, al secondo giro (20 marzo) venti, più un camice di protezione, una scatola di guanti e una boccetta di disinfettante per le mani. Si trattava di semplici mascherine senza filtro, in teoria non adatte a un contatto così ravvicinato con una persona infetta, e soprattutto erano dispositivi usa e getta: bastavano sì e no per una giornata in ambulatorio. “Per dare una misura della differenza tra noi e i nostri colleghi in ospedale, nei reparti per il Covid19 usano tuta, calzari, maschera con filtro FFP3, cuffia, schermo facciale o mascherina per gli occhi, tre paia di guanti uno sull’altro e calzari stagni” spiega. “Certo, nel nostro caso forse sarebbe eccessivo, però esistono delle sane vie di mezzo”. Storia simile anche per la guardia medica: nonostante l’iniziale fornitura fosse più consistente, i dispositivi di protezione a loro in dotazione sono ormai agli sgoccioli, costringendo gli operatori a selezionare con criteri molto restrittivi quali pazienti visitare a domicilio, per non esaurire le poche scorte rimaste.
Come era statisticamente prevedibile diversi pazienti, tra quelli del dottor Marzocchi, sono risultati positivi al Coronavirus. Uno di loro, visitato in assenza di dispositivi, ha contratto una forma particolarmente grave ed è stato ricoverato in rianimazione, dove ora è intubato. “Avevo già visitato la sua compagna, che aveva una brutta tonsillite batterica. L’ipotesi più logica era che anche lui avesse preso la stessa cosa, così ho accettato di visitarlo anche senza avere protezioni adeguate” racconta. “Aveva qualche linea di febbre, mal di gola e i polmoni del tutto liberi. L’ho rimandato a casa. Quattro giorni dopo mi ha mandato un messaggio dall’ospedale: ‘Dottore, mi stanno per attaccare all’ossigeno, ho paura’”. Sapendo che aveva avuto un contatto diretto con un soggetto positivo, e quindi rischiava di essere stato contagiato e contagiare a sua volta altri, Marzocchi si è responsabilmente messo in auto-quarantena e ha segnalato la situazione all’ATS. Dopo diverse chiamate a vuoto e due e-mail, gli è stato comunicato per telefono che sarebbe dovuto tornare immediatamente in servizio, essendo asintomatico, perché per i medici di base non era prevista quarantena o tampone. “Ero abbastanza basito” dice. “Ho chiesto che mi mandassero una comunicazione scritta, in modo da potermi tutelare in caso di problemi legali, ma nessuno mi ha mai mandato neppure una mail a conferma della cosa. Né mi hanno avvisato tempestivamente che ero stato esposto al virus: solo undici giorni dopo la mia visita a quel paziente, un collega dell’ATS mi ha chiamato per dirmi che era ricoverato per Covid19”.
Il caso del dottor Marzocchi non è un’eccezione, ma la regola: a quanto pare, nella pratica non c’è molto che protegga i medici di base – nonché i loro pazienti, che spesso hanno patologie pregresse o sono anziani, e quindi ancora più a rischio – che si imbattono in un malato con Coronavirus. Essendo liberi professionisti con partita Iva, non godono di molte delle consuete tutele del lavoro dipendente, e sia assicurazioni professionali che cause penali e civili ricadono interamente su di loro. Paradossalmente, però, per legge sono tenuti a garantire la continuità del servizio, sempre e comunque, anche in questa situazione, e anche in presenza di condizioni che mettono a rischio la salute del medico stesso, come patologie croniche o gravidanza. In un contesto normale, potrebbero trovare un sostituto che lavori al posto loro: ma con la carenza di medici che affligge la Lombardia, è quasi impossibile. Così Marzocchi, dopo lunghe ricerche, è riuscito a procurarsi una manciata di dispositivi e mascherine FFP3 – pagandole 60 euro l’una – ed è tornato al lavoro. “Sarebbero monouso anche quelle, ma grazie a una rete di medici lombardi volontari, il MOOSS, abbiamo imparato come sanificarle per farle durare di più: l’associazione ha contattato il Polo Interforze per la Difesa NBC di Rieti, il nucleo dell’esercito che si occupa di prevenire gli attacchi batteriologici e nucleari, che in caso di guerra è abituato a operare con quel poco che ha sul campo”.
Se fossero attrezzati adeguatamente e in grado di proteggersi, sia dal punto di vista legale che da quello della propria incolumità, gli operatori della sanità territoriale rappresenterebbero una risorsa preziosissima per combattere l’emergenza. Tra le molte iniziative che Marzocchi e altri suoi giovani colleghi estremamente proattivi stanno mettendo in campo, ce n’è una che potrebbe alleggerire di molto i reparti di terapia intensiva e rianimazione. “In sostanza si tratta di un protocollo per diagnosticare il Coronavirus precocemente, prima che subentrino polmoniti gravi, e monitorare i pazienti a domicilio” spiega. Al momento la prassi in caso di sospetto contagio da Covid19 prevede solo di prescrivere paracetamolo e aggiornarsi sulle condizioni del paziente via telefono. “La nostra idea è quella di effettuare una valutazione clinica avanzata sui pazienti che hanno sintomi sospetti: appoggiandoci a un pronto soccorso che confermi la diagnosi, somministreremmo a domicilio quelle terapie che è possibile erogare senza ricoverarli. Non solo: vorremmo anche fornire in prestito dei semplici strumenti come un saturimetro e un misuratore di pressione, in modo che il malato possa monitorare ogni giorno i suoi parametri in autonomia”. I dati verrebbero raccolti e inviati automaticamente al medico curante tramite a un portale gratuito, creato ad hoc da un gruppo di giovani programmatori, e in caso peggiorino verrebbe immediatamente ricoverato. Già diversi pronto soccorso si sono dichiarati interessati a supportare l’iniziativa. “Siamo tutti volontari e ci sobbarcheremmo gratis questo lavoro in più (sia noi che gli sviluppatori del portale, capitanati da Mirko Arena): però dobbiamo poter proteggere la nostra salute e quella di chi ci circonda. Dicono che c’è carenza di medici, ma quelli che ci sono spesso non sono messi nelle condizioni di lavorare bene, soffrendo per questa impotenza”.
E forse qualcosa si muove, finalmente. Proprio ieri il Ministero per l’Innovazione, di concerto con quello della Salute, ha lanciato un bando per individuare “le migliori soluzioni digitali disponibili sul mercato per app di telemedicina e strumenti di analisi dati, e coordinare a livello nazionale l’analisi, l’adozione, lo sviluppo e l’utilizzo di queste soluzioni e tecnologie per il monitoraggio e contrasto alla diffusione del Covid-19” (il bando è disponibile per i prossimi tre giorni). Nel frattempo, nel week end, il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri ha dichiarato che in questi giorni dovrebbero arrivare anche ai medici di base e alla guardia medica le mascherine FFP3, e la Regione Lombardia ha comunicato che verrà fatto un tampone a tutti i dottori che operano sul territorio. Nel frattempo, però, molti sono stati costretti a organizzarsi in altro modo, spiega Marzocchi. “La comunità cinese di Milano, per esempio, ci ha gentilmente donato molte mascherine, e dovrebbero arrivarci alcuni test rapidi altrettanto gentilmente donati dal Rotary Club. Ci permetteranno di sapere se siamo già venuti a contatto con il virus e se abbiamo sviluppato gli anticorpi”. Nel frattempo è passato un mese dallo scoppio dell’epidemia e dal ricovero del paziente 1 di Codogno. Non è difficile immaginare che centinaia di loro colleghi potrebbero essere stati infettati, infettando involontariamente a loro volta chissà quanti pazienti. La domanda che i posteri si porranno è: tutto questo si poteva evitare?
In merito a questo articolo, abbiamo contattato l’ufficio stampa dell’ATS di Milano e quello del responsabile dell’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia, e siamo ancora in attesa di un commento ufficiale sulla vicenda. Restiamo a disposizione dei diretti interessati qualora volessero fornirci chiarimenti in materia.