Un filo invisibile, tale non perché sottilissimo, quanto perché vasto e materico, troppo ingombrante per parere un filo, connette paesaggi musicali all’apparenza distantissimi in una geometria sbilenca: l’hardcore punk finlandese e quello brasiliano, il punk di Düsseldorf, l’elettro pop di Madchester, il punk italiano targato TO. Il nostro filo si rivela: è un cavo multiforme, srotolato da una bobina di cemento armato, accumulatori elettrici e ruggine. Facendo un passo indietro, il quadro si allarga: linee di fuga raggiungono in volo Detroit e la Motown, si corre verso la cornice sull’autobahn kraftwerkiana, scartando tra piccoli villaggi rurali nella Ruhr, ed una volta raggiunta la fumosa Chicago una breve linea retta (potrebbe essere una tradotta elettrica) collega blues ed elettricità.
La mano che disegna questa geometria appartiene a Giacomo Bottà, accademico specializzato in studi urbani, docente e ricercatore all’Università di Helisnki, che nel suo Deindustrialisation and Popular Music: Punk and ‘Post-Punk’ in Manchester, Düsseldorf, Torino and Tampere (Rowman & Littlefield Publishing, 2020) propone una lettura, attraverso la musica e le scene musicali, dei processi di deindustrializzazione di quattro importanti centri industriali europei: Manchester, Düsseldorf, Torino e Tampere. Per quanto sia spesso abusata, l’analogia tra libro e viaggio in questo caso funziona: del viaggio questo libro ha tanto: un sentimento, una tensione emotiva, luoghi e spazi disparati, universi di linguaggio distanti ma che si parlano.
Se viaggio dev’essere, questo parte lontano: dal XIX secolo e dall’industrial folk inglese, motivi musicali tradizionalmente rurali riadattati alla nuova realtà urbana e industriale (Woody Guthrie, ne ripropone moltissimi brani). Un’altra linea di partenza, un’altra stazione: Chicago, dove il blues del Delta, nato in un contesto rurale, incontra l’elettricità, i riff si fanno più ripetitivi, come la catena di montaggio, il volume sale e distorce, le valvole splendono (vedi Mannish Boy di Muddy Waters). Saranno poi, tra le altre, band come i Beach Boys e la produzione della Tamla Motown di Detroit a fare da colonna all’era dell’industria: crescita economica, Wouldn’t It Be Nice?, il modello fordista applicato all’industria discografica. Quello industriale è però un panorama che vediamo filare fuori dal finestrino, la nostra stazione è po’ oltre, un po’ dopo. Dove ci fermiamo il cuore delle fabbriche ha smesso di pulsare, l’ostinato ripetersi del respiro meccanico che originò il Motorik ora è fermo. L’industria c’è, ma è vuota. Non cresce più, non impiega più le masse.
Questo è il nostro setting, la scenografia per la nostra scena principe: una città che non è una capitale, non è un centro politico e tantomeno culturale, tra gli anni ’70 e gli ’80 del Novecento. Se scena dev’essere, qual è la colonna sonora? Bottà lo svela fin dal titolo del libro: punk e post punk. Il lavoro di ricerca ha portato l’autore a raccogliere e organizzare un’enorme quantità di materiale: volantini, dischi in vinile, musicassette, interviste, fanzine, frammenti digitali, giornali e oggettistica relativi alle scene punk e post punk nelle quattro città. Ci ritroviamo così in un mondo che rivive nelle parole e nelle prassi delle nascenti culture giovanili di quegli anni. In un mondo in cui in cui gli spazi della produzione, abbandonati dalle tute blu, diventano sale prove e da concerto, in cui l’estetica che predilige ossa arrugginite di mastodonti di cemento armato funge da rivendicazione, di provenienza e d’appartenenza.
Ci ritroviamo in un mondo culturale in cui la pratica del fare (da soli) è centrale. Se la Tamla Motown era il fordismo nell’industria musicale, una volta dileguatosi il signor Ford si sono messe in campo strategie e tecniche che proprio dal fordismo derivano, dall’etica del lavoro della working class e dalle reti sociali costruite in epoca industriale. Un esempio per tutti: nella città industriale europea per eccellenza, Manchester, il 4 giugno 1976 due giovani studenti, Peter McNeish e e Howard Trafford (che più tardi cambieranno nome rispettivamente in Pete Shelley e Howard Devoto), organizzano un concerto nella centralissima Lesser Free Trade Hall, sala minore della famosa Free Trade Hall, invitando a suonare una giovane band londinese, i Sex Pistols. Il concerto è organizzato completamente in stile DIY. Pete e Howard, dopo aver visto i Pistols a Londra, convincono il manager Malcolm McLaren a portare la band a Manchester. Il concerto è aperto da un complesso di Bolton, i Solstice, e la band degli organizzatori Pete e Howard, i Buzzcocks, non può esibirsi perché mancano loro bassista e batterista. I ragazzi si appoggiano all’organizzazione socialista Music Force, che rende possibile il concerto fornendo backline e gestendo la logistica.
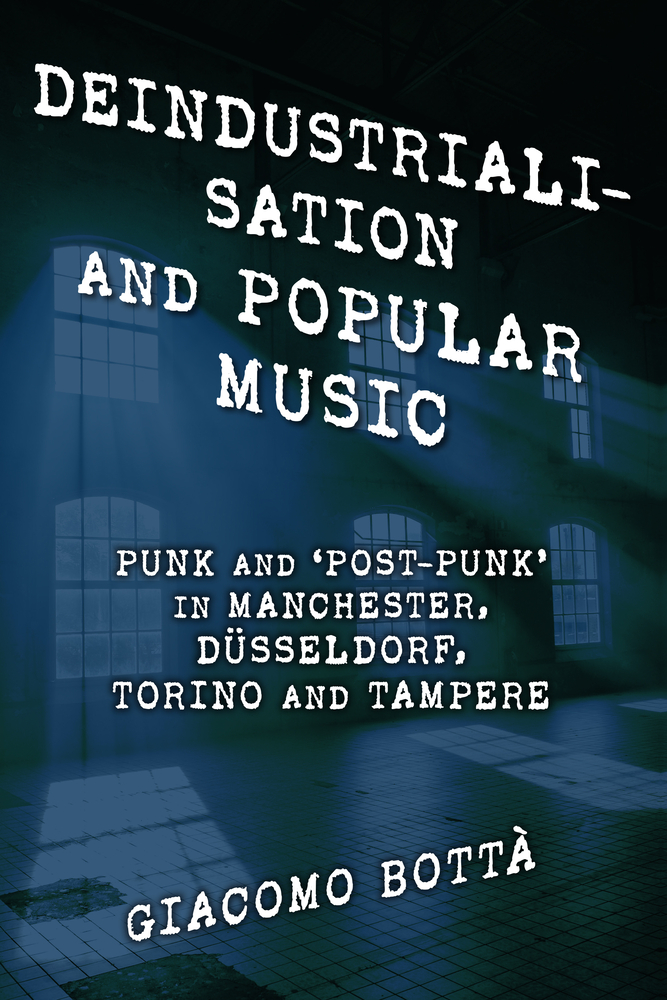
“Deindustrialisation and Popular Music: Punk and ‘Post-Punk’ in Manchester, Dusseldorf, Torino and Tampere” (Rowman & Littlefield Publishing, 2020), di Giacomo Bottà
La scelta di portare il punk nel cuore della città, mettendo in campo capacità e strategie organizzative collettive e, non ultimo, la scelta futura dei Buzzcocks di muovere un critica deliberata all’industria musicale londinese percorrendo una via discografica autonoma e completamente indipendente (i primi EP furono completamente autoprodotti e autonomamente distribuiti) evidenziano la necessità dei giovani punk mancuniani di adottare un linguaggio proprio e nuovo, dichiararlo nel cuore della città, marcando un legame tra la fisicità del tessuto urbano (e il suo declino) e le forme di espressione che vi si generano all’interno. Il concerto diventerà un evento mitico. Tra gli spettatori ci sono futuri membri di Joy Division/New Order, Fall, Smiths, ovviamente dei Buzzcocks e un imprenditore e conduttore televisivo locale, Tony Wilson (futuro fondatore di Hacienda e Factory Records). La storia di Manchester come alveo creativo di fama mondiale è nota, il terreno generato dal movimento culturale punk divenne un perno sul quale la città in parte si reinventò diventando, per alcuni aspetti, una music city, la quale produzione culturale è strettamente legata alle logiche di espansione capitalista riscontrabili anche in altri ambiti urbani, ad esempio nel mercato immobiliare. Ma questa è una stazione successiva.
Una storia diversa, ma connessa dal nostro singolare filo, è quella di Torino. Una delle città industriali per eccellenza d’Italia: company town, la FIAT, la Fabbrica. L’industria era dappertutto, impregnava e disegnava il tessuto urbano. Fino a quando non iniziò a ritirarsi e il tessuto connettivo lasciato scoperto si indovina ancora oggi. Siamo ad inizio anni ’80, il clima in Italia è ancora segnato dagli anni di piombo, e il processo di deindustrializzazione a Torino avviene in modo radicale. In concomitanza con il ritirarsi della fabbrica, l’onda lunga del Movimento del ’77, in termini di azione politica e creativa, si va esaurendo. In questo contesto, desolato e desolante, gruppi di giovani cercano di articolare risposte creative al progressivo inaridimento del tessuto urbano e sociale che li circonda: qualcuno trova la risposta nel punk, chi in chiave politicizzata (vedi il Collettivo Punx Anarchici), chi meno. Anche qui, DIY, duro lavoro, e riappropriarsi (o appropriarsi per la prima volta) di spazi urbani. Prima il circolo anarchico di via Ravenna, poi il centro d’incontro di Vanchiglia, fungono da porto per i punk torinesi. Il centro di Vanchiglia diviene sala prove e da concerto per band come Declino, Contrazione, Il Collettivo: un importante incubatore di creatività e uno spazio per la collaborazione. Le autoproduzioni risultano in prodotti (cassette in genere) con articolati messaggi e artwork densi di contenuto (anche politico). Per dare un’idea, tra le altre nel 1981 appare Torinoise, compilation su cassetta legata alla fanzine Ansia, con brani di Ivan Siberia, Fiori del Male, No-Strani, Rough, Blue Vomit, Negative Vibrations, Chain Kids, e Nuclear Code. Nel 1983 la fanzine Disforia pubblica Torino 198X, con brani di Blue Vomit, Kollettivo, Declino, C.B.A., Quinto Braccio, Kina Punk, e D.D.T., a cui segue L’incubo continua. Anche Torino, come Manchester cambierà volto (e continua a cambiarlo), e l’esperienza punk dei primi anni ’80 si esaurirà, ma siamo di nuovo a una stazione successiva.
Il punk torinese, come quello di Manchester, si inserisce in un contesto fragile e desolato: la deindustrializzazione è una terra di mezzo, temporaneamente priva di significato, un momento in cui spazio e tempo vengono percepiti come sconnessi. La musica, come lo spazio della deindustrializzazione che la contiene, è fatta di una materia effimera e cangiante: le scene sono nascono e muoiono, lasciando un’eredità rintracciabile nel tessuto urbano e culturale successivo. Proprio in questa fugacità sta la loro forza dirompente.
Il libro di Bottà ha un pregio raro: portandoci in viaggio in queste quattro città europee, quasi prendendoci per mano lungo strade e quartieri, locali e vecchie stazioni, riesce ad essere al tempo stesso un approfonditissimo lavoro di indagine accademica e un libro emotivamente e narrativamente molto coinvolgente.
















