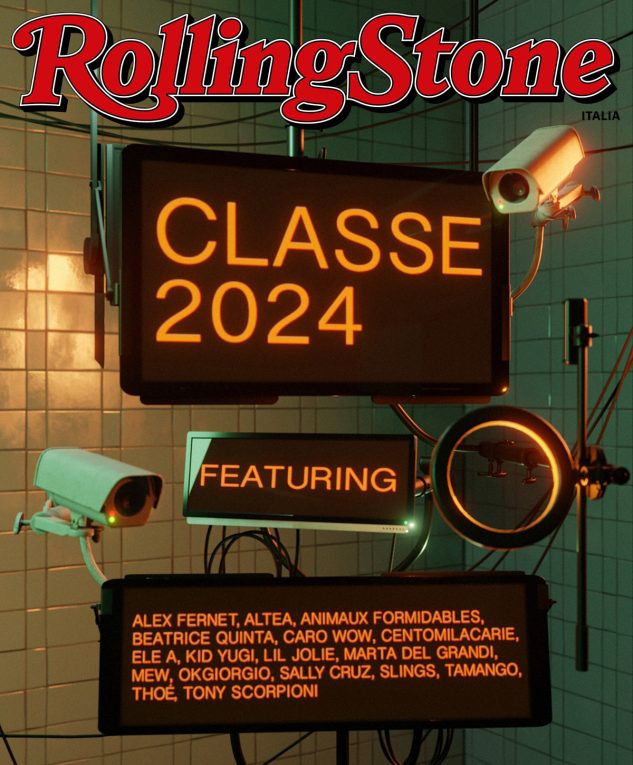I segreti del White Album
Scritto mentre le divergenze creative distruggevano la band, il capolavoro dei Beatles compie 50 anni e torna con un’edizione speciale che ne svela tutti i misteri
«Dovresti saperlo, sei tu quello cosmico!» è col suo sarcasmo tagliente che nell’aprile del 1968 John Lennon si congeda dal Maharishi Mahesh Yogi, che chiedeva spiegazioni per l’improvvisa fuga dall’ashram di Rishikesh in India, dove i Beatles si erano ritirati, per frequentare il corso di meditazione trascendentale e ritrovare se stessi. A dire il vero Ringo se n’era già andato da un pezzo – non sopportava gli insetti e tutta quella ricerca interiore non faceva proprio al caso suo – raggiunto poco dopo da Paul, che con la sua solita lungimiranza, aveva piantato baracca e burattini giusto in tempo per rendere l’esperienza piacevole e mantenerne un bel ricordo. Lennon e Harrison invece erano quelli che sin dall’inizio avevano preso il viaggio molto sul serio e si trattennero per un paio di mesi in più degli altri, decisamente troppo: i rapporti con il Maharishi si logorarono e la frustrazione esplose quando nel villaggio circolò la voce – mai confermata, né smentita – che il guru avesse molestato una delle ospiti del ritiro. A quel punto i due beatle scapparono nottetempo, non senza difficoltà: si persero per strada e il taxi si guastò durante la corsa verso l’aeroporto, pensarono di essersi beccati una maledizione, alla quale Lennon rispose con la provocatoria Sexy Sadie – che inizialmente si intitolava Maharishi, what have you done? – nella quale deride tutte le contraddizioni di un guru in realtà avido e ricco sfondato, col jet privato e un ashram adibito a centro benessere di lusso, per ospitare gli occidentali che elargivano cospicue donazioni – gli stessi Beatles furono molto, molto generosi – e godeva di tutti i comfort, d’altra parte non sta scritto da nessuna parte che una bella nuotata in una piscina olimpionica non favorisca il raggiungimento della “trascendenza”.
La strada del ritorno fu così lunga e tortuosa, che Lennon si ubriacò e una volta salito finalmente a bordo dell’aereo inizio a confessare senza freni alla moglie Cynthia tutti i tradimenti passati e soprattutto parlò di Yoko Ono, che in quel periodo stava entrando nella sua vita e per la quale iniziava a sbarellare. La questione si concluse pochi mesi dopo, con il divorzio. In realtà per Lennon tutta la permanenza in India non fu affatto una passeggiata. Proprio questo disagio fu di ispirazione per pezzi angosciati come I’m so tired, che racconta dell’insonnia di quei giorni causata dall’astinenza da alcolici e droghe – il pezzo rende bene l’idea anche perché poi verrà registrato alle tre di notte – o Yer blues, un grido di sofferenza e solitudine spedito a Yoko, come racconta l’epistolario di quei giorni. Dalla mente di Lennon nacquero anche brani più allegri, come The continuing story of Bungalow Bill, che deride un personaggio che va a caccia di tigri realmente incontrato in India, così come è cronaca vera la vicenda di Prudence Farrow, sorella e figlia d’arte di Mia e John Farrow, anche lei iscritta al corso e eccessivamente fissata con la meditazione trascendentale, al punto che finì in uno stato di catalessi dalla quale non uscì per settimane, rinchiusa nel suo bungalow (per inciso: in seguito divenne la più giovane insegnante di meditazione trascendentale degli Stati Uniti e continua a ottenere tutt’oggi una serie di attestati e riconoscimenti al riguardo in giro per il mondo). Per l’occasione Lennon scrisse Dear Prudence, conosciamo i dettagli della vicenda proprio grazie allo stesso autore, che ne parla in coda alla versione demo registrata una volta tornato in Inghilterra «tutte le persone attorno a lei erano preoccupate, perché presto sarebbe uscita fuori di testa… perciò cantiamo per lei», dice ironicamente.

Foto © Apple Corps Ltd. via Facebook
Sebbene Harrison si incazzasse quando John e Paul strimpellavano – «siamo qui per meditare, non per scrivere il prossimo album!» –, l’India fu di grande ispirazione per tutti e di fatto scrissero lì la maggior parte dei pezzi che finirono in The Beatles, il doppio LP di norma più noto come White Album. Il coacervo di suoni e sperimentazioni che lo caratterizza, si poggia su una solida base di pezzi nati e cresciuti con una struttura acustica, proprio perché in India non disponevano di strumenti elettrici e furono fortemente influenzati dalle lezioni di finger-picking impartitegli dal cantautore folk Donovan, anch’egli in India nello stesso periodo dei Fab Four. Una versione abbastanza fedele dell’atmosfera indiana si trova negli Esher demos, a tutti gli effetti una versione acustica e rudimentale del White Album, riemerso a scaglioni nel corso dei decenni.
Questo bootleg risale al maggio 1968 e fu registrato nella casa-bungalow di George Harrison, vicino Esher, nella campagna del Surrey. Diciannove dei ventisette pezzi incisi, finirono in quello che tuttora è l’album più venduto dei Beatles negli Stati Uniti. Sia i (pochissimi) testimoni presenti, che i dialoghi registrati tra un pezzo e l’altro, riportano un clima quieto e sereno tra tutti e quattro, collaborazione e coesione nel comporre i pezzi: l’esatto contrario di quello che avvenne durante le registrazioni ufficiali dell’album, che furono strazianti. C’è chi afferma che durante quei giorni i Beatles furono amici per l’ultima volta, l’attimo prima che le cose iniziassero a incrinarsi lentamente e in maniera irreversibile. Un anno dopo, Paul McCartney tentò di ricreare un contesto di complicità simile durante le Get back/Let it be sessions, ma fu un tentativo vano, in quel momento, allo stato essenziale delle cose, i Beatles già non esistevano più e di lì a poco tutti si arresero all’evidenza.
Anche se quei giorni a Esher furono felici, a dire il vero, c’erano avvisaglie di problemi all’orizzonte, già sul finire del 1967: innanzitutto la prematura morte di Brian Epstein, il caro manager che li aveva scoperti e lanciati, overdose di alcol e psicofarmaci. Un brutto colpo seguito subito dal flop del film per la tv Magical Mystery Tour e poi dal lancio della Apple Records, la casa discografica che non diede i frutti sperati e spesso causò ingenti perdite di denaro. Sia chiaro, il concetto di fallimento è da sempre estraneo a qualsiasi cosa riguardi i Beatles: a marzo ’68 il singolo di Lady Madonna – non di certo il loro pezzo migliore – va dritto in cima alla classifica, stessa sorte di Hey Jude ad agosto, niente di nuovo sotto al sole da questo punto di vista, sono più che altro le tensioni interne ed esterne al gruppo che presto sarebbero esplose.
Se è vero che è esagerato parlare di un clima di astio perenne durante le registrazioni – sarebbe stato umanamente impossibile, visto che durarono quasi quattro mesi – è anche un eufemismo sostenere che si trattasse di episodi sporadici. Tra tazze di te che volavano, insulti e vendette, il primo a cedere fu Geoff Emerick – lo storico tecnico di studio a cui si deve molto del sound di Revolver e Sgt. Pepper’s – che un giorno, durante l’ennesima lite nel bel mezzo delle sedute, si tirò dietro la porta e non fece più ritorno. Anche la pazienza di George Martin fu messa a dura prova in più di un’occasione, così come la sua autorità: il quinto beatle era sin dall’inizio contrario all’idea di un dispersivo doppio album e affidò a più riprese i lavori al suo assistente, concedendosi un lungo periodo di ferie alla larga dagli incandescenti studi di Abbey Road. A un certo punto pure Ringo Starr abbandona il gruppo e se ne va in vacanza in Sardegna, d’altra parte era pur sempre agosto, in seguito dichiarò di sentirsi poco importante e fuori luogo, fu convinto a tornare solo grazie a un telegramma di quelli che solo George Harrison può inviare.
L’anarchia che regnava in studio diede sicuramente libero sfogo alla creatività dei Beatles, senza ombra di dubbio agli apici in quel periodo, sebbene in forma individuale, ma si rivelò anche controproducente: Harrison impiegò più di cento takes prima di stabilire che il suo pezzo Not guilty andava scartato – per poi finire più di dieci anni dopo nel suo eponimo album, chissà dopo quante altre takes –, un record incalzato dalle 67 takes di McCartney impiegate per I will, d’altra parte era il primo pezzo che il Macca dedicava alla futura moglie Linda (ah sì, tanto per aggiungere stress causato dalla vita privata: all’inizio dell’anno aveva annunciato il matrimonio con Jane Asher per poi fare un brusco dietrofront). Un sondaggio della BBC ha stabilito che Ob-la-di Ob-la-da sia la peggior canzone dei Beatles, se di questo si può discutere. Invece è fuori discussione che anche l’anima più pia possa perdere totalmente il lume della ragione dopo 47 takes a suonare questa perversa filastrocca ska, figuriamoci Lennon, che letteralmente odiava quel pezzo e finì con l’inveire contro Paul abbandonando lo studio. Difficile biasimarlo. Tornò poco dopo, ancora furibondo, ma anche strafatto e si mise come un automa di nuovo su quello che chiamava “Paul’s granny shit”, c’è chi sostiene che il pianoforte che si sente su disco sia quello suonato dal Lennon sotto botta e fuori di sé. D’altra parte aveva appena iniziato con l’eroina, alla quale si fa un velato riferimento in Everybody’s Got Something to Hide Except Me and My Monkey e soprattutto in Happiness is a warm gun il famoso trittico di canzoni incollate per sempre in un unico capolavoro, uno dei pochi che coinvolse tutti e quattro i Beatles collettivamente. Un’altra rara occasione in cui Lennon e McCartney lavorarono in coppia, fu per Birthday, uno dei pochi pezzi scritti e composti interamente ad Abbey Road, in vista del compleanno di Linda. Durante le prove, fecero una pausa e andarono a cena a casa di Paul, dove videro la prima tv di The girl can’t help it il film del 1956 che li riportò indietro nel tempo, e ispirò il rock’n’roll di cui è caratterizzato il pezzo, finito quella la notte stessa.

Yoko Ono e i Beatles negli Apple Studios di Londra, 1968. Foto CAMERA PRESS/JHF
La fine del sodalizio tra Lennon e McCartney portò a una competizione spesso stimolante tra i due, Paul rispose con pezzi come Helter Skelter di cui da qualche parte esiste una versione lunga mezz’ora al termine della quale Ringo urla «I’ve got blisters on my fingers!», poi finito sul disco. Oppure con la ascetica Mother nature’s son, composta in India ispirato dagli insegnamenti del Maharishi, sulla stessa linea tra uomo e natura su cui si basa Child of nature di Lennon, registrata a Esher con questo titolo e con un testo ispirato dal soggiorno a Rishikesh, pezzo che poi fu scartato e in seguito, con un testo diverso, divenne nientemeno che Jelous guy.
C’è però anche la faccia negativa della medaglia, perché la competizione portò anche a colpi bassi tra i due, che spesso rifiutavano l’ingerenza dell’altro nei propri pezzi. Scatenando un’escalation di pezzi registrati di soppiatto, in fretta e furia, di nascosto dall’altro. Così fece Paul con Martha my dear un pezzo totalmente individuale, così come Julia di Lennon, l’ultimo a essere registrato di tutto il White Album, inciso praticamente nei minuti di recupero in pochissime e intimissime sedute con il solo Lennon alla chitarra acustica, per uno dei suoi pezzi più introspettivi e personali, dedicato alla madre che è la Julia in questione, ma anche a Yoko Ono, che del resto Lennon chiamava spesso “madre” e che è direttamente citata con quell’Oceanchild che è la traduzione letterale di Yoko Ono.
L’episodio più eclatante di questa diatriba riguarda però Revolution 9 il pezzo sperimentale e d’avanguardia, frutto del viaggio esclusivamente di John e Yoko, al quale solo in un secondo momento partecipò anche Harrison inserendo dei dialoghi, solo dopo che Paul era saltato su un aereo per gli Stati Uniti dopo una lite furibonda legata all’inserimento di questo pezzo (effettivamente fuori luogo) nel disco, ma anche perché la presenza di Yoko iniziava a diventare asfissiante e Lennon era troppo stordito per capirlo. Paul si vendicò escludendo John dalle sessioni di Why don’t we do it in the road? il suo pezzo più “lennoniano”, che incise proprio nel giorno del compleanno di John, il quale ci rimase parecchio male.

Naturalmente George e Ringo risentirono di questo clima di tensione che li relegava a spettatori inermi della battaglia tra due ego giganteschi, tra le pieghe di tutto questo però riuscirono a portarsi a casa qualche soddisfazione. La più grande è sicuramente quella di Ringo, che cantando e suonando il pianoforte in Don’t pass me by riesce finalmente a farsi accreditare un pezzo per intero, erano almeno quattro anni che cercava di convincere gli altri a registrare questo pezzo. Il batterista canta anche nella traccia conclusiva Good night di Lennon, ma solo perché questi si vergognava un po’ di esporsi in prima persona con una ninna nanna così dolce e melensa, a quei tempi era troppo impegnato a fare il duro con il movimento studentesco e maoista, provocandoli con Revolution 1 con la quale sostanzialmente si chiamava fuori (e poi dentro?) alla rivoluzione violenta di cui parlavano. Si tratta di un brano molto dibattuto, che in realtà esprime bene tutte le contraddizioni e le indecisioni vissute in quel momento da un personaggio celebre, ma anche attivo politicamente e dal quale ci si aspettava una presa di posizione chiara. Dal canto suo Paul se la cavò con la meravigliosa Blackbird, il cui testo per sua stessa ammissione è ispirato al Black Power e alla battaglia per i diritti civili.
Anche George ebbe modo di prendersi un po’ di spazio, col suo fare mansueto incise pezzi non tanto apprezzati come Piggies che in molti considerano uno dei pezzi più odiosi di Harrison, probabilmente perché non sanno che durante quelle magiche sedute venne eseguita una prima versione di Something con un clavicembalo lasciato lì dall’orchestra e anche una embrionale Let it be. Ad Harrison sono accreditate anche Long, long, long e Savoy Truffle, che dedicò a Eric Clapton e alla sua passione per il cioccolato che gli causò le carie. C’è proprio lo zampino di Clapton – che veniva chiamato in studio da Harrison perché la sua presenza rendeva gli altri beatle più seri e concentrati – nel brano indubbiamente più bello della produzione di Harrison per il White Album: While my guitar gently weeps sebbene Clapton fece tutt’altro che piangere la Les Paul di George.
L’estetica minimale che caratterizza questo disco furono un’idea di Richard Hamilton, che propose una linea totalmente opposta a quella caotica e colorata del precedente Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Fu anche un modo per provocare tutti i dietrologi che trovavano significati e simboli assurdi dietro qualsiasi cosa che riguardasse i Beatles, che da parte loro lanciarono una serie di frecciatine con il beatle più bravo a lanciare frecciatine: mister John Lennon che in Glass onion sparge una serie di indizi falsi e di frasi senza senso gettate in pasto alla follia dei cospirazionisti seguaci della PID (Paul is dead), la celebre teoria secondo la quale Paul sarebbe morto in un incidente stradale nel 1966 e cinicamente sostituito da un sosia. Naturalmente i seguaci di questa teoria trovarono un sacco di materiale.

Nel verso «You were in a car crash and you lost your hair» si fa riferimento all’incidente e alla conseguente decapitazione, Revolution 9 si apre con una voce che dice «number nine» che ascoltato al contrario direbbe «turn me on, dead man», ma nove sono anche le lettere che compongono McCartney, nonché la data della presunta morte (fissata al 9 novembre 1966). Anche il finale di I’m so tired se ascoltato al contrario, Lennon direbbe «Paul is dead, man: miss him, miss him, miss him!», c’è anche la traccia fantasma cantata dallo stesso McCartney (o dal suo sosia) che sul finale di Cry baby cry canta «Can you take me back where are people? Can you take me back?». Chissà quanti altri segni si sarebbero trovati se l’album si fosse intitolato A doll’s house come doveva essere all’inizio, prima che nel luglio del 1968 uscisse Music in a doll’s house album d’esordio dei Family.
A proposito di family, tanto per non farsi mancare niente, ce n’è un’altra alla quale questo album è tristemente collegata: quella di Charles Manson, la cui mente malata stabilì che i Beatles fossero i quattro Cavalieri dell’Apocalisse che nelle loro canzoni nascondevano messaggi criptati rivolti proprio a lui, e parafrasò il significato di parecchi testi. Finì che lui e la sua setta uccisero usando forchette e coltelli come nel finale di Piggies e imbrattarono le pareti con scritte di sangue come “pig” e soprattutto “Helter Skelter”, uno dei pezzi più coinvolti in questa macabra faccenda.
A questo punto è perfettamente inutile trovare una frase a effetto per rimarcare il valore di un album seminale per numerosi generi sviluppati negli anni successivi e che a cinquant’anni dalla sua uscita continua a parlare al presente, mentre ci ricorda che appartiene a un passato magico, che non tornerà più.