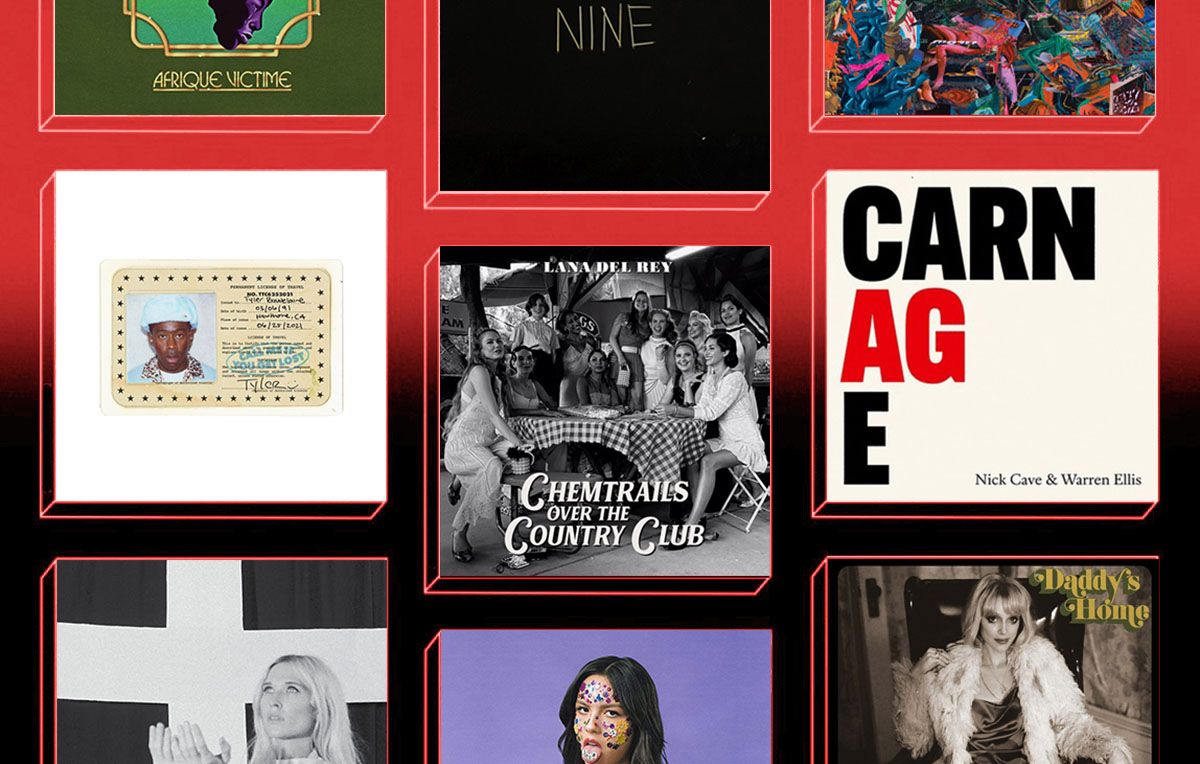Promises, l’ultimo disco di Floating Points con Pharoah Sanders e la London Symphony Orchestra, sta emozionando e polarizzando. Tra fan, stampa (nazionale e non) e addetti ai lavori si è gridato per lo più al capolavoro dopo neanche 24 ore; quasi per reazione si è parlato anche di flop sopravvalutato, se non peggio. Posizioni così definitive e chiuse in sé stesse, formulate in una manciata di giorni, lasciano probabilmente il tempo che trovano. Anche se le reazioni forti sono anche comprensibili, viste le premesse: uno dei musicisti elettronici più seguiti e discussi degli ultimi anni (con annessa orchestra) incontra una vera e propria leggenda vivente del jazz; uno che sta di diritto nella categoria dei Coltrane e dei Davis, per altro storicamente restio a operazioni discografiche di questo tipo. Credo comunque che sia molto più interessante riflettere sull’immediato successo del disco e su cosa racconti del pubblico e della musica nel 2021, piuttosto che scannarsi per affibbiargli una definizione che solo lo scorrere del tempo può aiutare a chiarire.
Cosa vuol dire questo apprezzamento trasversale e quasi unanime per un album che ha senso solo se ascoltato per intero, più di 45 minuti, decisamente sopra la media della soglia di attenzione? Per di più un disco estremamente minimale (faccio fatica a definirlo sperimentale: l’unione tra fiati jazz, elettronica colta e parti orchestrali non nasce certo qui) basato sulla ripetizione, su un crescendo che sfugge continuamente alle aspettative, che rimanda il climax fino alla fine. Quanto influisce il momento storico che stiamo vivendo, quanto risponde a delle necessità emotive più o meno consce? Per cercare di capirci qualcosa ho raccolto le opinioni di amici e colleghi, tra musicisti, giornalisti, promoter, fotografi e via dicendo. Partendo dall’assunto a che più o meno tutti hanno concordato nell’attribuire all’album qualità che sarebbero state riconosciute in qualunque momento storico.
Nell’ultimo anno la maggior parte di noi sono diventati un tutt’uno con i muri della propria casa, con gli occhi fusi ai vari display ma la mente liberissima di vagare incessantemente attraverso quello che ci sta succedendo. Tutto ciò per tanti ha contribuito alla formazione di un costante senso di agitazione, un moto costante di pensieri in aperto contrasto con l’immobilità fisica. Una specie di disturbante e costante rumore di fondo che accompagna la nuova realtà che viviamo. Ecco, non sorprende quindi che una delle tendenze musicali del 2020 sia stata un rinascimento della musica ambient. Album, compilation e video di questo genere (perfino direttamente di solo rumore bianco) sono stati molto ascoltati e cercati. Ne hanno già parlato estensivamente sia il New York Times che The Verge, me lo conferma un giornalista e ricercatore: «Ultimamente ho dei grandi problemi di soglia d’attenzione, dati proprio dal costante uso di tecnologia social media etc di questo periodo. Mi sono accorto che con l’ambient e i vinili riesco a combatterlo. Stando sempre dentro casa a lavorare davanti uno schermo ti serve proprio qualcosa che ti faccia staccare». È della stessa idea anche un altro giornalista e scrittore: «È un po il trionfo del lo-fi beat ten hours to relax to».
Però nessuno ovviamente si è mai sognato di definire capolavoro un video di beat lo-fi o di rumore bianco. Perché quindi rintracciamo alcune di quelle caratteristiche nell’album? La pura materia musicale di Promises è un flusso sorretto da un arpeggio lungo 46 minuti che fa presto a diventare il nostro baricentro, ad identificarsi con noi. Intorno gli scorre un fiume di intuizioni e suoni che si modella lungo tutta la durata del disco, apparendo impetuoso e più spesso discretamente, con un grande uso del silenzio. Si instaura un meccanismo di comfort: aggrappati al baricentro siamo come legati ad una fune da bungee jumping: senza accorgercene ci lanciamo nel vuoto sonoro, sicuri di tornare in superficie. È un disco che ti tiene piacevolmente immerso nell’acqua, ma che sa benissimo quando sollevarti per farti prendere una boccata d’aria.
Questa sensazione di finta perdita di controllo, questa estetica delle emozioni controllate che arrivano come onde è forse la chiave: siamo stremati, abbiamo bisogno di provare emozioni che ci distraggano e che siano anche impetuose. Allo stesso tempo dobbiamo essere rassicurati, mantenere la sensazione di essere al sicuro. In generale l’album trasmette un forte senso di serenità complessa ma non incomprensibile, di cui si può godere facilmente. Secondo un graphic designer con cui ho parlato, il benessere che pervade l’ascolto ha a che fare anche con la capacità del disco di bloccare quel ritmo produttivo che, tra le mura di casa, fa fatica a distinguersi dai momenti di riposo. «Ascoltando un disco del genere si riscopre il piacere della calma, della concentrazione. Non essendo improntata ad una “performatività”, non è più frustrante, ma rasserena. Per riassumere con una frase, si tratta di un disco che fa riscoprire il tempo libero come otium e non come ozio».
Un amico che lavora per un’etichetta è più pragmatico: «la ragione più emotiva alla base, legata al momento, secondo me deriva proprio dal fatto che da un anno a questa parte non succede niente e quello che succede nel mondo della musica (almeno per me) è veramente poco stimolante. Un grande produttore e una leggenda del jazz che insieme hanno fatto un grande disco, che è quello che deve essere: bella musica. In un periodo del genere diventa ancora più grande, lo sarebbe stato già di per sé, ma così è riconosciuto all’estremo». C’è chi sottolinea che «è una specie di supegruppo: unisce storia, profondità ed estetica. La versione riuscita di Lou Reed con i Metallica».
All’innegabile difficoltà e immobilità del mercato musicale e della voglia di progetti di questa portata si unisce anche il maggior tempo a disposizione dell’ascoltatore medio. Un musicista, organizzatore di festival e gestore di un’etichetta indipendente riflette in merito citando un album che scatenò reazioni molto simili: «Fetch the Bolt Cutters di Fiona Apple dura quasi un’ora. Solo due anni fa sarebbe stato impensabile che dischi così “interi” potessero diventare il disco del momento. Dicendo intero intendo un disco con uno svolgimento, una certa attenzione richiesta e quindi anche una visione a monte ben precisa». C’è chi rincara la dose: «tutto è amplificato dal fatto che abbiamo molto più tempo da dedicare all’ascolto ed è anche più facile concentrarci su un disco del genere rispetto al passato». Il discorso quindi si divide e si intreccia tra due correnti: considerarlo un disco complesso a cui ora possiamo dedicare un’attenzione diversa rispetto al passato e valutarlo come un ottimo album un po’ “paraculo” (consciamente o meno), con caratteristiche che soddisfano molto bene delle necessità emotive esacerbate dalla pandemia.
Per finire c’è poi il discorso dell’hype, sviscerato bene da Federico Sardo su Esquire. I musicisti coinvolti mettono in comunicazione due pubblici tra i più devoti, elitari, complessi e litigiosi: jazzisti e fan di musica elettronica “colta”. Il giornalista e ricercatore già citato lo definisce un po’ sarcasticamente come «il cosmic jazz per i cool kids di NTS Radio. C’è una spinta che porta a voler far vedere che sei parte della bolla, che stai apprezzando un disco percepito come intellettuale». Anche altri sono convinti che questo meccanismo di polarizzazione e scontro tra bolle diverse stia giocando un ruolo fondamentale. Anche nel successo commerciale del disco, che in poche ore è diventato l’album più venduto su Bandcamp e mentre scrivo è ancora saldamente al primo posto – con le copie del vinile andate sold out nelle prime ventiquattro ore. «Ci son quei dischi che appena escono son subito capolavori. C’è chi lo dice in prima persona, chi viene condizionato e chi si oppone per bastiancontrarite e dice no è una merda non capite un cazzo. Ogni reazione però fa rotolare e ingigantire ancora di più la palla della curiosità». Non c’è migliore pubblicità della cattiva pubblicità, diceva Andy Warhol.
I discorsi si intrecciano, tra il musicale e il sociale. Capolavoro o flop, arrosto o fumo: chiudendo il cerchio, rimane il fatto che un album con caratteristiche così lontane dallo stereotipo del best seller sia ascoltato, comprato e celebrato come l’album del momento. Escludendo tutto il rumore, gli applausi e le polemiche che gli girano attorno, all’interno di Promises c’è evidentemente qualcosa che funziona e risuona con chi lo ascolta, tanto a livello superficiale quanto più profondo. È curioso, e può essere lo spunto per iniziare (o continuare) a domandarsi come è cambiato il nostro rapporto con l’ascolto musicale dopo un anno di pandemia. Per chiedersi se siamo di fronte all’inaugurazione di un nuovo trend e se di conseguenza altri artisti cercheranno di intercettare queste necessità. Siamo forse di fronte alla nascita di una stagione di album la cui cifra stilistica è un grande impianto estetico intellettuale dalle qualità narcotizzanti, come l’equivalente di uno Xanax con una puntina di LSD?