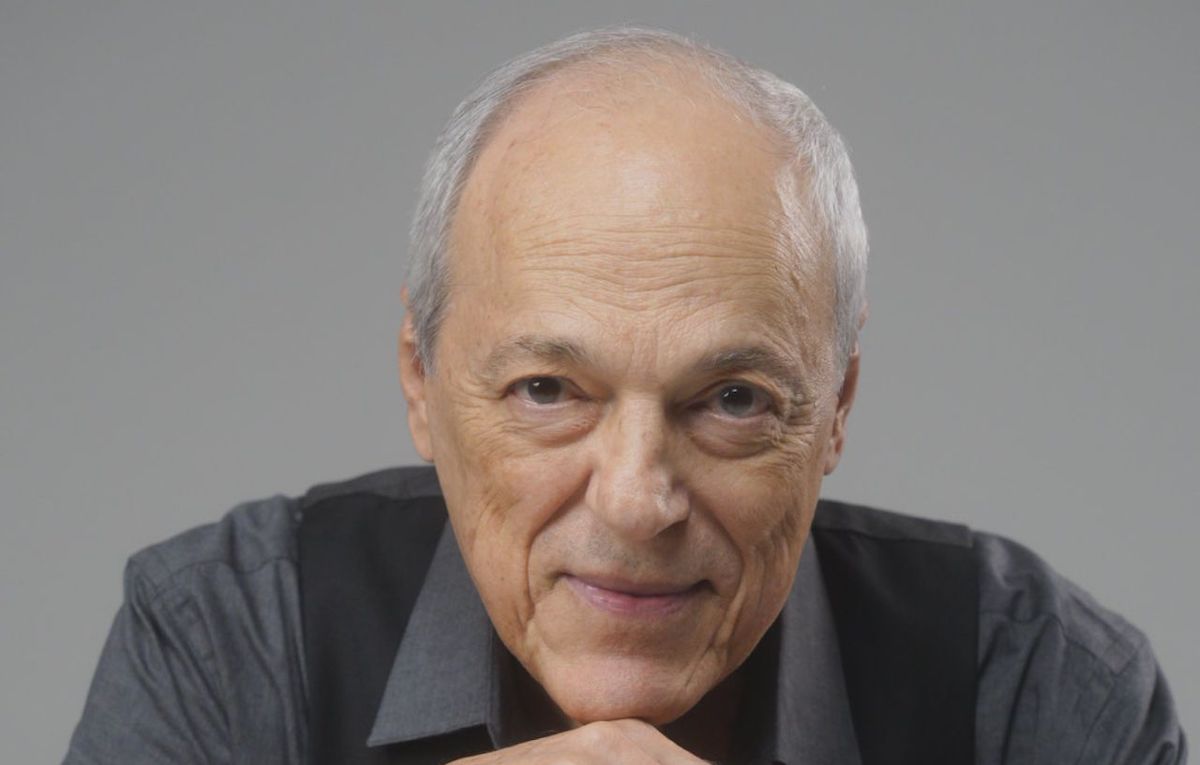«Sono stanca. Però mi diverto» (Ornella Vanoni, sempre)
Diceva sempre che era stanca, ma rideva quando lo diceva, come se la stanchezza fosse una delle tante maschere che la vita ci appiccica addosso, e che lei, con quella voce da sigaretta postcoitale e quella pigrizia olimpica che le permetteva di essere continuamente due o tre secondi in ritardo sul tempo del mondo, indossava come un pigiama di seta in pieno giorno. Così uno pensa che non è morta sul serio, non ancora, che magari è solo in uno dei suoi addormentamenti televisivi o in una delle sue pause lunghissime, quelle in cui lasciava sospesa una nota, una frase, un pensiero, aspettando che fosse il silenzio a completarlo per lei. Oppure è svenuta su una chaise longue color pastello, con gli occhiali da sole ancora addosso e un gatto addormentato sulla pancia. Ora del decesso: il momento esatto in cui la realtà ha smesso di interessarla.
Ma Ornella Vanoni non è mai stata davvero interessata alla realtà. Le piacevano i sogni, le metafore, i titoli dei dischi più dei dischi stessi. Le piaceva fingere di non sapere, di non capire, di essersi dimenticata chi eri – anche se ti conosceva meglio di te. Le piaceva raccontare di avere la gastroesofagite, la depressione, la stitichezza, la sensualità, l’amore, la noia, la vecchiaia, tutto nello stesso elenco e con lo stesso tono, come se ogni cosa fosse un ingrediente qualunque nella sua ricetta personale del caos.
Ornella non si è mai capita del tutto, perché non si è mai voluta spiegare. Si è lasciata interpretare come un quadro astratto. Come un vocale di sei minuti in cui si ride, si tossisce, si sospira, e poi, quasi inspiegabilmente, si prende a cantare.
C’è stato un tempo, che sembra lungo come uno o più secoli, in cui le donne di spettacolo dovevano scegliere se essere madonne o puttane. Lei scelse di essere sé stessa: una signora colta che sembrava svampita, una radicale sentimentale, una donna di spettacolo che odiava lo spettacolo, una musa pigra, una paziente ribelle, una diva che si prendeva per il culo da sola.
Non è facile scrivere la parola fine quando si tratta di qualcuno che, più che attraversare il tempo, sembra averlo intaccato con unghie smaltate, lasciando graffi sottili sulle sue superfici più fragili: la voce, il desiderio, il ridicolo, la libertà. Ornella Vanoni è stata molte cose: cantante, attrice, testimone irregolare dell’arte e del sentimento; ma, più di tutto, è stata un’eroina della resistenza contro l’ovvio, il decoroso, il dovere di spiegare tutto a tutti.
Ora che la sua voce si è spenta (o, meglio, si è ritirata in un sottotetto del silenzio dove alcuni fortunati possono sentirla ancora) ci accorgiamo meglio che quella voce non era un timbro, non era un’estensione, non era una tecnica, ma una maniera di stare sopra e sotto al mondo, di entrarci e uscirne ogni volta con una domanda sulle labbra e un sorriso mezzo vero e mezzo svogliato, come se il dramma della vita fosse interessante solo fino a un certo punto, e il resto potesse benissimo essere raccontato da una pausa. Quest’ultima, ahinoi, troppo lunga.
Non ha mai avuto la potenza pura di Mina, né la tenacia fulva di Milva, né la frenesia pop di Patty Pravo. Ma ha avuto qualcosa che nessuna ha sfiorato: una consapevolezza spietata e insieme malinconica del fatto che tutto ciò che conta (tra cui: l’amore, la voce, il corpo, la fama, il tempo) tende a disfarsi, e che la vera eleganza sta nel sapere come accompagnare quella dissolvenza, come danzare dentro la propria progressiva disintegrazione con la grazia di chi ha già fatto pace con l’idea di scomparire.
Infatti per lei la voce veniva dopo. Prima c’era quel modo di stare al mondo, quel corpo che si muoveva come una domanda lasciata a metà, come un bicchiere lasciato mezzo pieno perché tanto “Poi ci torno”. Camminava sempre un po’ sbandata, come se non sapesse bene dove fosse il centro del palco, e proprio per questo lo trovava sempre. Era tutta obliqua, tutta stonata nel modo giusto, tutta “Forse”, tutta “Vediamo”, tutta “Non so se ci riesco ma intanto ci provo”. E ci riusciva.
Vanoni non si è mai presentata come un modello più intonato o videogenico di te, ma come la possibilità di essere altro, anche da sé stesse, anche contro il proprio passato, anche contro il personaggio che la cultura dello spettacolo voleva inchiodarle addosso. E infatti, a ogni decade, a ogni disco, a ogni intervista, lei rinasceva un po’ diversa. Più spettinata, più svagata, più vicina a una certa verità che nessuno aveva e ha il coraggio di dire, e che lei invece spiattellava quasi senza accorgersene, con quel tono per metà stanco e per tre quarti ubriaco che sembrava domandarti, biascicando con una tenerezza infinita: “Ma davvero ci tieni così tanto a capire tutto?”.
Chi ha ascoltato Vanoni cantare dal vivo almeno una volta sa che con lei non si trattava mai solo di una performance, ma piuttosto di una breccia, come se per un attimo lei ti lasciasse entrare nella sua stanza (non quella piena di oggetti di scena dell’artista, ma proprio quella con i libri storti, i farmaci sul comodino, le fotografie degli amori sbagliati) e da lì ti raccontasse le canzoni che interpretava con un’intimità che non era finta confidenza, ma un abbandono consapevole. La sua voce preferiva restare nel registro crepuscolare dell’allusione, non salire mai verso l’acuto della dimostrazione, cosicché le sue parole erano già ricordo mentre venivano pronunciate. Non c’era bisogno di spingere, bastava lasciarsi scivolare, ed è in quella scivolata che si compiva il miracolo: la verità non era mai netta, ma sempre mormorata, come una cosa che non ci riguarda fino in fondo, eppure ci tocca, ci punge, ci salva.
L’inizio di Ornella, come è noto, fu sotto l’egida di Strehler, che la plasmò a modo suo ma fu anche il primo a capire che quella ragazza borghese e irrequieta, più che una semplice interprete, sarebbe stata la cartografa liminale tra il teatro e la canzone, tra la cronaca e la favola, tra la Milano della mala e il Sud America delle passioni fatali. Le sue prime canzoni raccontavano un’umanità marginale ma mai miserabile, e anche quando parlava di donne derubate, tradite, recluse, lo faceva senza retorica e senza pietà, con quella distanza affettuosa che solo gli artisti disillusi sanno mantenere. La pietà le stava stretta, la compassione non le interessava. E così, negli anni Sessanta, mentre altri rincorrevano la solarità delle canzonette estive, lei se ne andava per sentieri laterali, infilava bossanova nei Festival, parlava portoghese con la lingua dell’anima, accostava la propria malinconia a quella di Vinicius de Moraes e Toquinho, costruendo un’idea di mondo in cui la leggerezza era meno evasione e più profondità travestita da sorriso.
Poi è venuto il tempo lungo della maturità, che per Ornella non è mai stato sinonimo di equilibrio ma semmai di una inadeguatezza felice, coltivata come un giardino zen al contrario in cui ogni disordine è perfettamente voluto. Nelle interviste diceva cose impossibili da incasellare: parlava di sesso, di depressione, di Dio, di dieta, di arte, di addetti alle canne, e tutto in un’unica frase, con l’aria di chi è troppo vecchia per avere paura ma ancora troppo viva per lasciarsi addomesticare. Gli altri costruivano strategie, lei si abbandonava all’improvvisazione. Gli altri chiedevano attenzione, lei la riceveva senza pretenderla. Negli anni Duemila è diventata, suo malgrado, una specie di influencer dell’imperfezione, una musa delle nuove generazioni senza nostalgia ma con ammirazione autentica: perché quella signora smaltata, sempre in bilico tra l’eccesso e il ritiro, incarnava meglio di chiunque altro la possibilità di esistere fuori dal centro, fuori dal codice, fuori dalla prestazione.
La libertà di Ornella Vanoni non è mai stata solo una libertà stilistica, ma una forma di anarchia elegante che investiva tutto ciò che toccava, e passava anche attraverso i suoi contrasti. E non solo quelli interiori, tra sonno e desiderio, tra carne e pensiero, tra palco e divano, ma anche quelli molto concreti con gli uomini che le sono stati accanto, nella vita e nella musica: compagni, ex, amanti, amici, nemici temporanei. Non li hai definiti né ha lasciato che fosse definita da loro. Li ha lasciati parlare, cantare, sbagliare accanto a sé, accettando di farsi rifrangere da quelle voci, da quei corpi, da quei maschili diversi, in cui spesso si specchiava e, altrettanto spesso, si disfaceva. È in questi duetti – duetti veri, non featuring costruiti a tavolino – che si capisce chi era davvero Ornella: una donna che non ha mai avuto bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare.
Nella storia di Ornella Vanoni ci sono due principali ordini di duetti: due tipi di dispositivi emotivi, piccoli laboratori sentimentali in cui lei mette a confronto, quasi senza volerlo, due modi opposti e complementari di stare al mondo. Da una parte l’amore che si ricorda, dall’altra quello che si recita; quello che ti scava e quello che ti salva, quello che ti prende la voce e quello che te la restituisce.
Da una parte Gino Paoli, l’uomo che ha trasformato le loro rovine relazionali in spartito, l’amante che ha visto Ornella giovane prima di tutti (o quasi), quando ancora era una ragazza piegata dall’amore e inflessibile nella dignità, e che in Ti lascio una canzone sembra chiederle scusa senza averne il coraggio. Dall’altra Franco Califano, che in teoria è l’opposto di Paoli (più sfrontato, più malinconico, più notturno) ma che davanti a lei si disarma, si raddrizza, diventa quasi tenero, come se fosse cosciente che, in certi contesti, le sue famose spacconate romanesche non funzionavano più.
Il duetto con Paoli, quello che negli anni è diventato una specie di inno per chi crede che gli amori finiti continuino a parlarsi attraverso le canzoni (sorry, Strani amori di Laura Pausini), è un dialogo in cui non c’è più niente da dire e tutto da ricordare. Lui avanza piano, con quella voce prosciugata, come uno che cammina nel corridoio di una casa vuota. Lei gli risponde non come un’innamorata, ma come una donna che ha visto la linea d’ombra, che conosce il dolore della resa, e però – in un modo tutto suo – sa farlo sembrare un gesto di eleganza. Non cantano insieme: sono separati in musica.
Con Califano, e qui entra in scena Due come noi, che è forse la più perfetta definizione di coppia che lui abbia mai scritto: due come loro, cioè due come tutti, cioè due che si lasciano e si ripigliano, si perdonano troppo tardi, si dicono addio nella forma più onesta possibile, cioè sapendo che non durerà. In questa canzone, che già da sola sembra un film intero ambientato tra il lungotevere d’inverno e il pianerottolo di un’eterna domenica sera, la cosa straordinaria non è Califano – che fa il Califano, con la sua malinconia di uomo che ha sbagliato sempre nello stesso modo – ma Ornella, che entra come un contrappunto, come una donna che sa benissimo di essere diversa da tutte quelle che lui ha amato, e proprio per questo può permettersi di dirgli la verità senza ferirlo.
In Due come noi, Ornella diventa l’elemento che rimette il mondo a fuoco: prende la nostalgia del Califfo (quella nostalgia disordinata che lui trascinava sempre con sé come un cappotto troppo grande) e la trasforma in qualcosa di quasi pulito, quasi commovente, quasi innocente. È come se dicesse: “Sì, siamo due come noi, cioè due disastrati, due imperfetti, due che il mondo non ha mai davvero saputo decifrare, ma proprio per questo ci capiamo subito”. E lì, in quella frase, c’è l’essenza del duetto: una complicità senza sentimentalismi, un’intimità senza promesse, una forma di amore senza obbligo.
Paoli era la ferita che non smette di pulsare. Califano era il cerotto messo male che si stacca la mattina dopo. Ornella, in mezzo, era quella che non sanguinava e non si medicava: osservava, traduceva, respirava. Ascoltava il maschile senza farsi invadere, e lo cantava senza farsi ridurre. Due duetti, due uomini, un’unica verità: che nelle grandi storie serve qualcuno che abbia il coraggio di dire “Sta finendo” (altro che Senza fine), e farlo sembrare comunque una dichiarazione d’amore.
È difficile dire addio a chi ha fatto del non-finito la propria grammatica, del ritardo la propria puntualità, del dubbio il proprio modo di credere nelle cose. Ornella Vanoni non muore, perché non è mai stata interamente viva nella forma in cui intendiamo la vita nei suoi tracciati ordinari: ha sempre oscillato, ha sempre scartato, ha sempre messo la propria fragilità davanti alla scena come un’ammissione e insieme una sfida. Il lutto, in questo caso, è un fatto teorico: nella pratica, lei continuerà ad apparire nei nostri salotti, nelle nostre notti insonni, nei nostri amori stanchi, come una voce che non consola ma accompagna, che non chiarisce ma raddoppia, che non salva ma rende tutto più sopportabile.
Ornella ci ha lasciato in sospeso. Come faceva con le note, come faceva con le frasi, come faceva con la vita. E noi, che non siamo pronti per le conclusioni, la lasciamo lì: a metà. Con una frase interrotta, un sorriso appena accennato e un orecchino spaiato che deve pur brillare, da qualche parte, sul pavimento.