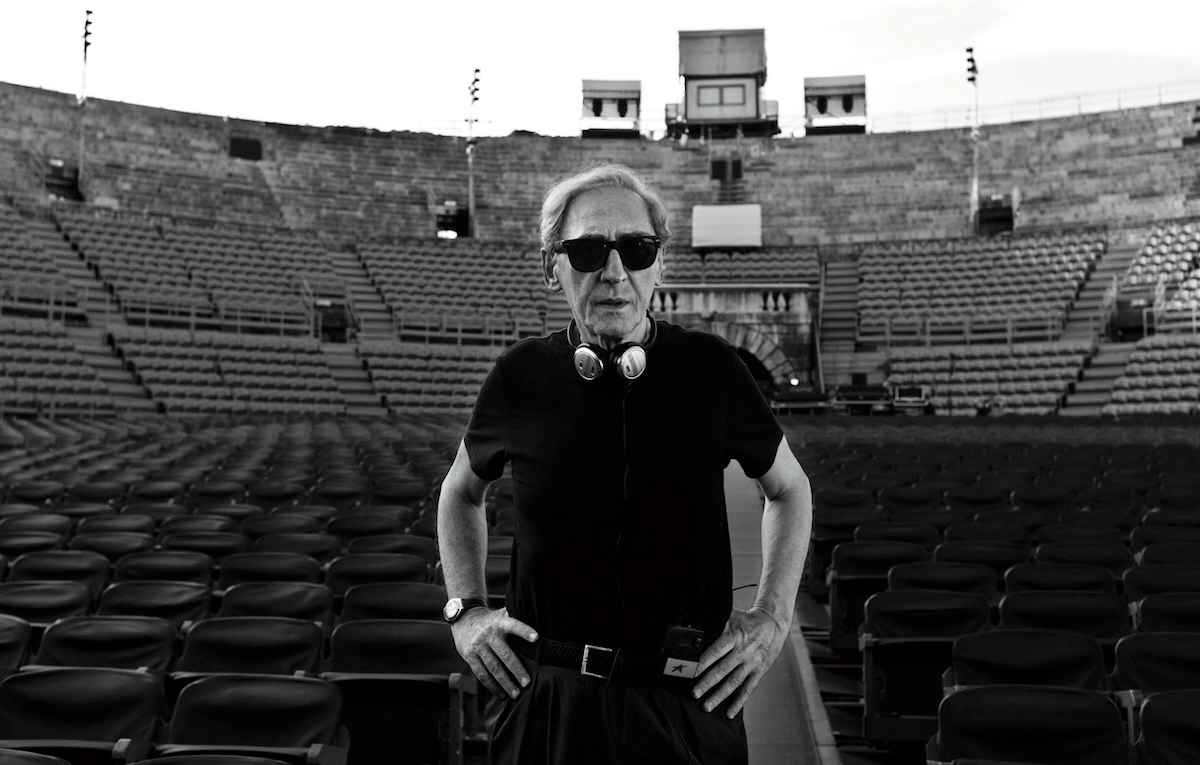Ci sono cicatrici e cicatrici. Quelle che quasi ti vergogni a raccontare come te le sei procurate e quelle che possono diventare una bella storia, talvolta leggenda. Della serie: ti sei fatto male sì, ma ne è valsa la pena. La parabola dei Fugees, a trent’anni dall’uscita di The Score, è questa. Cadute e risalite, sporadiche esibizioni, vicende giudiziarie che si intrecciano a quelle personali, accuse tra gli ex membri – come la denuncia, tempo fa, da parte di Pras Michél nei confronti di Hill per il tour revival cancellato – di un gruppo che si è sciolto subito dopo essere esploso in cielo come una supernova, lasciando dietro di sé detriti di fan nostalgici che guardano a quella cicatrice come a una parentesi irripetibile e che, forse, proprio per questo, brucia ancora di più.
Cosa rimane, oggi, di un album epico che ha riscritto le regole? Moltissimo. Attuale non solo per la versatilità artistica che ha fatto scuola, ma anche per costruzione narrativa e temi: discriminazione razziale, immigrazione, violenza istituzionale, brutalità delle forze dell’ordine, vita di strada autodistruttiva. All’indomani di una serie di prese di posizione pubbliche nel mondo della musica contro l’ICE in seguito ai fatti di Minneapolis, costati la vita a Renee Good e Alex Pretti, con Springsteen che ha parlato di terrore di Stato e scritto Streets of Minneapolis, The Score assume i connotati di un atto di resistenza.
The Score segna un prima e un dopo. Una chiave di volta e di lettura utile non solo al mondo R&B/hip hop da cui proviene, ma anche a tutto il resto del circuito che da quella cornice è fuori. Dall’individuale al collettivo, come uno zoom out che dalla strada, senza perdere la propria street credibility, porta ad avere una visione d’insieme e di cui chiunque detiene, se va bene, almeno un aneddoto.
Il mio è questo: una presa di coscienza col silenziatore, nel bel mezzo degli anni ’90, in una mattina qualunque davanti a una tazza grigia di latte e cornflakes appassiti. In tv, Killing Me Softly With His Song.
Quella cover era uscita chissà da quanto, Lauryn Hill aveva persino già intrapreso, come gli altri membri del trio, la carriera solista con quello che sarebbe stato l’osannato The Miseducation of Lauryn Hill, ma io, all’epoca, lo ignoravo; arrivavo con ritardo – dovuto all’età – quasi un viaggio a ritroso o, perlomeno, in parallelo.
Sala buia, una proiezione, cinema, popcorn. In giro tanta gente, un’atmosfera cool e, poi, lei. Di un altro pianeta, stratosferica. Un femminile impegnato, forte, ironico, veloce: “Strumming my pain with his fingers / Singing my life with his words / Killing me softly with his song / Killing me softly with his song / Telling my whole life with his words / Killing me softly with his song” (“Strimpellando il mio dolore con le sue dita / Cantando la mia vita con le sue parole / Uccidendomi dolcemente con la sua canzone / Uccidendomi dolcemente con la sua canzone / Raccontando tutta la mia vita con le sue parole / Uccidendomi dolcemente con la sua canzone”). E quell’inconfondibile riff di sitar, campionato dagli A Tribe Called Quest. Pazzesco.
Gli altri, dopo, mi sembravano sbiaditi. O erano i Fugees che erano troppo avanti? Qualcuno con spirito d’iniziativa cominciava a far circolare tra gli amici quella copertina il cui destino era forse già stato scritto: uno sfondo nero su cui si stagliavano i volti dei cugini Wyclef Jean e Pras Michél e di Lauryn Hill, ritratti, se vogliamo leggerci un presagio, in cui ognuno guardava in una direzione differente.
L’album – che esce il 13 febbraio del 1996, giorno in cui viene pubblicato anche All Eyez on Me di Tupac, assassinato a settembre dello stesso anno – entra di diritto nella storia della musica e, con decisamente meno pretese, tra gli ascolti – one time/two times e, poi, many times – di quella pre-adolescenza italiana che si era presa la briga, un po’ per sfida, un po’ per gioco, di provare a capire qualcosa della semisconosciuta scena hip hop d’oltreoceano.
In quel periodo al rap delle sparatorie, violento e misogino, faceva da contraltare l’immagine plastificata e iperglicemica delle boyband. Tra le compagne di classe non c’era spazio per i bad boys a meno che, nell’immaginario comune, non si avesse già qualche debito con la giustizia. Piuttosto improbabile. Eppure, quel sound sofisticato, eclettico, irriverente che sapeva, con stile, alternare forza e leggerezza, contenuto e visione, melodia e potenza lirica, parlava una lingua diversa e arrivava a tutti. E a distanza di trent’anni, dopo ascolti più ragionati, l’imprevedibile tsunami di The Score impatta ancora con la stessa, carismatica onda d’urto.
Un progetto complesso che, a partire dal primo singolo estratto, Fu-Gee-La, col refrain di Ooh La La La, canzone dell’88 di Teena Marie, riscrive i simbolismi di un genere che, da certe regole, era rimasto ingabbiato. Un disco, come l’aveva definito Hill, che voleva essere «un audio-film, come era la radio negli anni ’40» che «racconta una storia» e in cui «ci sono tagli e interruzioni nella musica. È quasi una versione hip hop di Tommy, come quello che gli Who hanno fatto per il rock».
Del ghetto, ma fuori dal ghetto. Quasi un ossimoro che si incarna in album che suggerisce un concetto sovversivo: non occorre avere una vita ai margini per ascoltare questa roba, non serve aderire alla cultura lowrider e ostentare catene al collo. Questa cosa qui ti arriva dritta dritta… ready or not. Questa storia puoi sentirla e farne parte anche se non ci sei dentro perché parla a un’intera comunità – in particolare, per Wyclef Jean è quella di Haiti – ma anche, trasversalmente, a tutti i (re)fugees del mondo con slancio identitario.
I Fugees sono stati la cassa accesa al centro della stanza che nessuno voleva spegnere, un cult che, successivamente, da quella stanza era uscito imponendosi a livello globale (il disco nel ’97 viene premiato con due Grammy: miglior album rap e migliore performance vocale R&B per Killing Me Softly With His Song). Una rivoluzione.
Con l’incipit delle carriere indipendenti però seguono allontanamenti e riavvicinamenti, mancate presidenze (quella haitiana per la quale, nel 2010, Wyclef Jean non è riuscito a concorrere), battaglie legali e beghe giudiziarie. Crisi. L’inizio di quest’anno ha poi segnato l’addio di un’altra figura di spicco con l’annuncio della morte dello storico producer John Forté (Family Business, Cowboys e Fu-Gee-La).
Nel frattempo Pras Michél è stato condannato a 14 anni di prigione per associazione a delinquere, riciclaggio di denaro sporco e lobbying illegale, finendo al centro di un intrigo internazionale stile spy story mentre, sempre in occasione degli ultimi Grammy, Ms. Lauryn Hill e Wyclef Jean sono saliti sul palco insieme, nel segmento In Memoriam, regalando un “puntuale” duetto di Killing Me Softly With His Song.
Quasi un ologramma dal passato che ricorda non solo la scomparsa dell’interprete originale Roberta Flack, ma anche l’influenza di un’opera che resta pur sempre (monumen)tale, anche se i percorsi di chi l’ha resa possibile si sono divisi. L’arte e l’oggetto che la racchiude – quando non si aggiornavano playlist virtuali ma si collezionavano, con malcelato compiacimento, i supporti materiali – rimangono un testamento che oltrepassa le esistenze di ciascuno.
Volevano ispirare, volevano innovare, volevano durare. Ci sono riusciti.