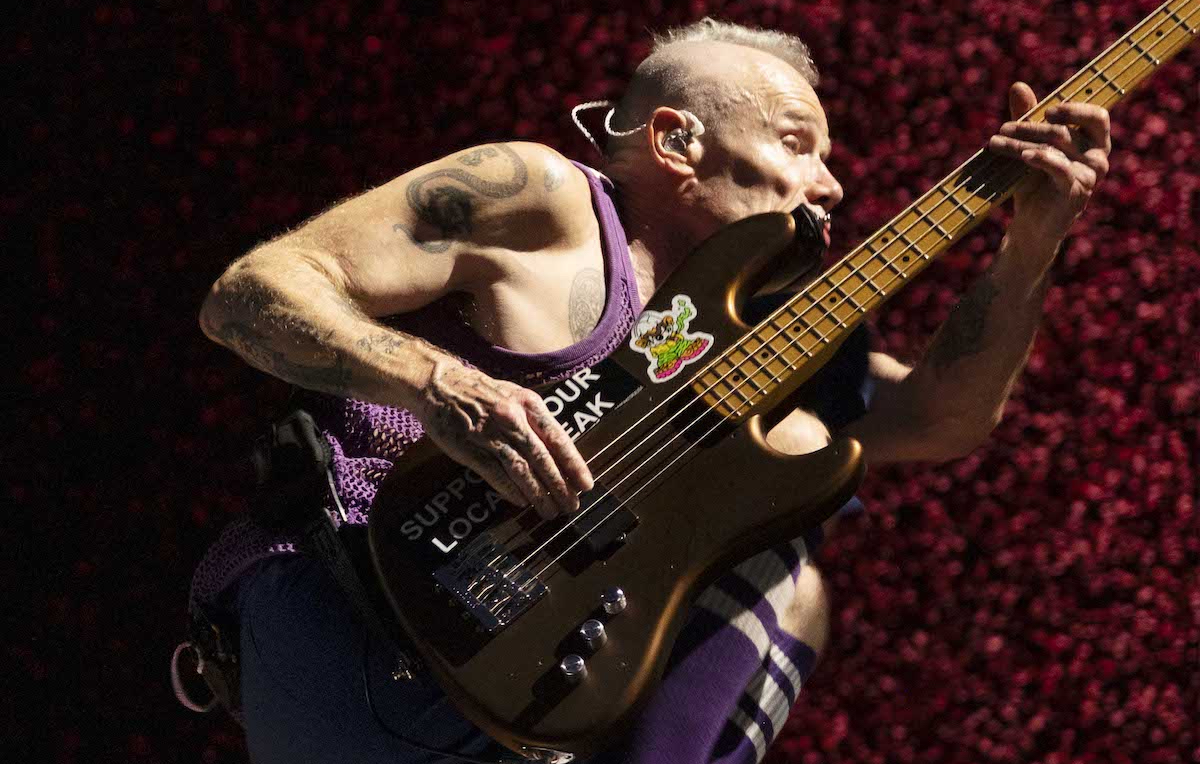Quando fu annunciato il nome di Peter Jackson per il docufilm Get Back, la fazione mistico-nerd dei beatlesiani vi lesse un chiaro disegno divino. Un nuovo anello, è il caso di dirlo, andava a collegare il mondo dei Beatles a quello di Tolkien, dopo una prima collisione all’alba del ’68.
Nel loro eremo indiano, tra meditazioni e fingerpicking, i quattro si erano dati alla lettura immergendosi nei testi inviati dal loro produttore cinematografico Denis O’Dell, smanioso di realizzare un nuovo film dei Beatles dopo il disastroso Magical Mystery Tour. Tra i libri recapitati a Rishikesh c’era appunto la trilogia del Signore degli Anelli uscita tra il 1954 e il ’55, praticamente in contemporanea con il rock’n’roll. Cosa che non le era certo valsa l’esclusiva attenzione di Lennon e McCartney.
Il seguito è storia piuttosto nota, con tanto di cast: quanto ci sarebbe stato bene George Harrison nei panni di Gandalf; ma anche il duo hobbit McCartney-Starr (Frodo e Sam) non prometteva male. Qualche dubbio in più su Lennon-Gollum, semmai. Per la regia si volò basso: perché non chiedere a Kubrick? Magari Peter Sellers poteva metterci una buona parola… Alla fine sarebbe stato il signor Tolkien in persona a porre il veto, inorridito all’idea che un gruppo rock potesse profanare la sua opera. Non se ne fece nulla, purtroppo.
È solo l’esempio più celebre di una filmografia fantasma ricca di progetti appositamente ideati per i Beatles ma mai realizzati. Atti mancati che, ancor più delle pellicole prodotte, ci parlano del rapporto tra musica, cinema e società nel corso degli anni ’60. Una maglia i cui anelli si annodano in fogge difficilmente comprensibili secondo la nostra visione attuale. Certo, è facile capire che nell’era pre-internet e ante-videoclip i film fossero indispensabili supporti per diffondere la musica e l’immagine delle popstar, ma c’è ben altro.
Non per niente, era stato il lungometraggio Rock Around the Clock (1956) a incollare allo schermo i futuri Fab Four già dai titoli di testa, con il formidabile incipit di Bill Haley: «One, two three o’clock, four o’clock, rock!». Nello stesso anno, Elvis aveva personificato la ribellione giovanile in Love Me Tender bissando l’anno dopo con Jailhouse Rock (rivelatrici, per una volta, le traduzioni italiane: Fratelli rivali e Il delinquente del rock and roll). Nati come figliastri del musical per un pubblico da drive-in, quei film avrebbero diffuso a livello globale una seppur goffa idea di ribellione.
Che fu presto addomesticata in salsa beach movie con tripudio di salsedine e amori da fotoromanzo. Gli stessi dei nostri musicarelli — feudo dei vari Little Tony, Gianni Morandi, Caterina Caselli — nei quali il contrasto generazionale covava sottotraccia, come intuì Marco Bellocchio, cercando proprio Morandi per I pugni in tasca (1965). Molto meno sotterranea la reazione degli impresari di Gianni, accorsi a impedirgli di turbare la sua rodata immagine nazionalpopolare: un’ulteriore spia delle diverse velocità con cui cinema e musica si sintonizzavano con il cambiamento sociale.
Di questo e di altro parla la filmografia fantasma dei Beatles, inaugurata già nel 1963 con il primissimo film proposto ai Fab Four: Yellow Teddybears. Un giallo ben più scialbo di quello del futuro sottomarino e una trama agghiacciante, che avrebbe visto i Beatles cimentarsi con un gruppo di studentesse dalle uniformi decorate con orsacchiotti gialli a segnalare l’avvenuta perdita della verginità. Non se ne fece nulla, per fortuna.
E vennero gli acclamati A Hard Day’s Night e Help! (in cui c’è un altro anello, quello di una setta indiana finito per errore al dito di Ringo), tra 1964 e ’65: «I Beatles sono i nuovi fratelli Marx!», esultarono in tanti. Anche meno, magari. Ma l’entusiasmo la dice lunga sulla ventata di novità portata dai quattro anche sul grande schermo, con umorismo e fantasia inediti nel genere rock movie, anche grazie a Richard Lester e alla sua pimpante regia.
Buon per la United Artist, il cui contrattato reclamava un terzo film. A fine 1965 si iniziò a parlare addirittura di un western, A Talent for Loving, dall’omonimo romanzo di Richard Condon. In breve, un sacerdote azteco del XVI secolo si taglia una mano per lanciare una maledizione su un conquistatore spagnolo (e su tutti i suoi discendenti, già che se l’è tagliata). Tre secoli dopo, ne è vittima l’avvenente figlia di un rancher texano: sarà la mano di lei, stavolta, a essere concessa al cowboy — dal non proprio filologico accento di Liverpool — che spezzerà l’incantesimo. D’altronde i Beatles erano amanti del western, no? Solo che nel frattempo, a differenza dei produttori hollywoodiani, essi erano cresciuti in fretta acquisendo consapevolezza del valore commerciale ed estetico dei propri film. E poi erano impegnati a registrare Revolver, sulla cui copertina avrebbero campeggiato anche le foto in abiti da cowboy scattate in un ranch del Missouri. Il film fu girato tre anni dopo senza di loro.
Walter Shenson, l’agente hollywoodiano che trattava i diritti cinematografici dei quattro, menzionò nell’estate del 1966 altre idee fortunatamente cestinate: «Abbiamo rifiutato tutto, da The Beatles in the Army a The Beatles Meet Elvis Presley». Stessa sorte per i Beatles ladri a cavallo (Ringo dixit). Duelli reali si ebbero quando entrò in campo la Disney proponendo un film animato del Libro della Giungla, per il quale la band avrebbe dovuto scrivere la colonna sonora originale e apparire in un breve cameo finale, proprio come in Yellow Submarine. A scontrarsi, manco a dirlo, Paul e John. Entusiasta il primo, diplomaticamente contrario il secondo: «I Beatles non canteranno mai per Mickey fucking Mouse! Dite a Walt Disney di andare a farsi fottere!». Il magnate dei cartoon morirà di lì a poche settimane, e nel film compariranno quattro avvoltoi dall’accento british e un simpatico caschetto.
Non mancò l’idea dei Beatles-moschettieri, un modo come un altro per perpetrare l’iconografia in stile beatlemania da cui ormai la band si era definitivamente allontanata. Per convincere Lennon si puntò su una Milady interpretata da Brigitte Bardot, sua autentica ossessione. Non bastò neanche quello, e Lester finì per girare ben tre versioni senza Beatles, dal 1973 al 1989.
Cassata per sempre la pista dei film in costume, una proposta ben più raffinata fu indirizzata alla band a inizio 1967: Shades of a Personality, per la regia di Michelangelo Antonioni e con John (reduce da How I Won the War) nei panni del protagonista Stanley Grimshaw, un uomo dalla quadrupla personalità. Superfluo specificare chi avrebbe interpretato le altre tre. Un ottimo soggetto — di cui avrebbe serbato ricordo Quadrophenia degli Who — accantonato soltanto perché in quei mesi i Beatles erano piuttosto presi dal nuovo album: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.
Quell’estate Brian Epstein commissionò a Joe Orton, noto per le sue commedie macabre, una seneggiatura ancor più audace fatta di sesso, poligamia e travestimenti, in cui sarebbero stati coinvolti anche Mick Jagger e Ian McKellen. Il 9 agosto era fissata una riunione con l’autore e i Beatles al completo. L’autista giunto a casa Orton rinvenne il corpo del drammaturgo ucciso dal compagno Kenneth Halliwell, suicidatosi nella stessa stanza. Epstein morì diciotto giorni dopo. In seguito McCartney sarebbe tornato sull’argomento: «Non l’abbiamo fatto perché era un film gay. Non che fossimo omofobi, solo che a differenza di Brian non eravamo gay».
Infine, dopo il mancato Signore degli Anelli con Kubrick, un ultimo incontro sfumato con un maestro del cinema, Jean-Luc Godard. Stavolta fu il regista stesso a cercare la band per One Plus One, film impegnato e sperimentale in cui i Beatles avrebbero semplicemente interpretato se stessi in studio di registrazione, come sarebbe accaduto pochi mesi dopo per Let It Be, girato da Michael Lindsay-Hogg prima del felicissimo remake di Jackson.
I motivi del disaccordo non furono mai chiariti, fatto sta che il dualismo Beatles-Rolling Stones aggiunse un nuovo capitolo alla sua leggenda, allorché Godard si rivolse a Jagger e compagni, i quali accettarono di comparire nel film poi ribattezzato Sympathy for the Devil. Dalle pagine di International Times il cineasta francese accusò i Beatles di disimpegno politico. Lennon rispose quasi in punta di fioretto su Rolling Stone: «Caro signor Godard, solo perché non abbiamo voluto partecipare al suo film, non significa che non stiamo facendo più di quanto stia facendo lei». Alla fine non andò tanto meglio con gli Stones, impreparati a un montaggio così rivoluzionario. «Un cumulo di stronzate» fu la recensione di Keith Richards. Chi era in ritardo sui tempi in quel maggio del ’68?
L’ultimo anello si sarebbe chiuso di lì a poco. A novembre lo stesso Godard volò a New York per girare il materiale poi confluito in One P.M. di Leacock e Pennebaker. Nella scena madre i Jefferson Airplane avrebbero suonato in cima a un palazzo di Manhattan, per lo stupore dei passanti. Due mesi dopo i Beatles salirono sul tetto della Apple. «Spero che abbiamo passato il provino», concluse il ragazzo con gli occhiali.