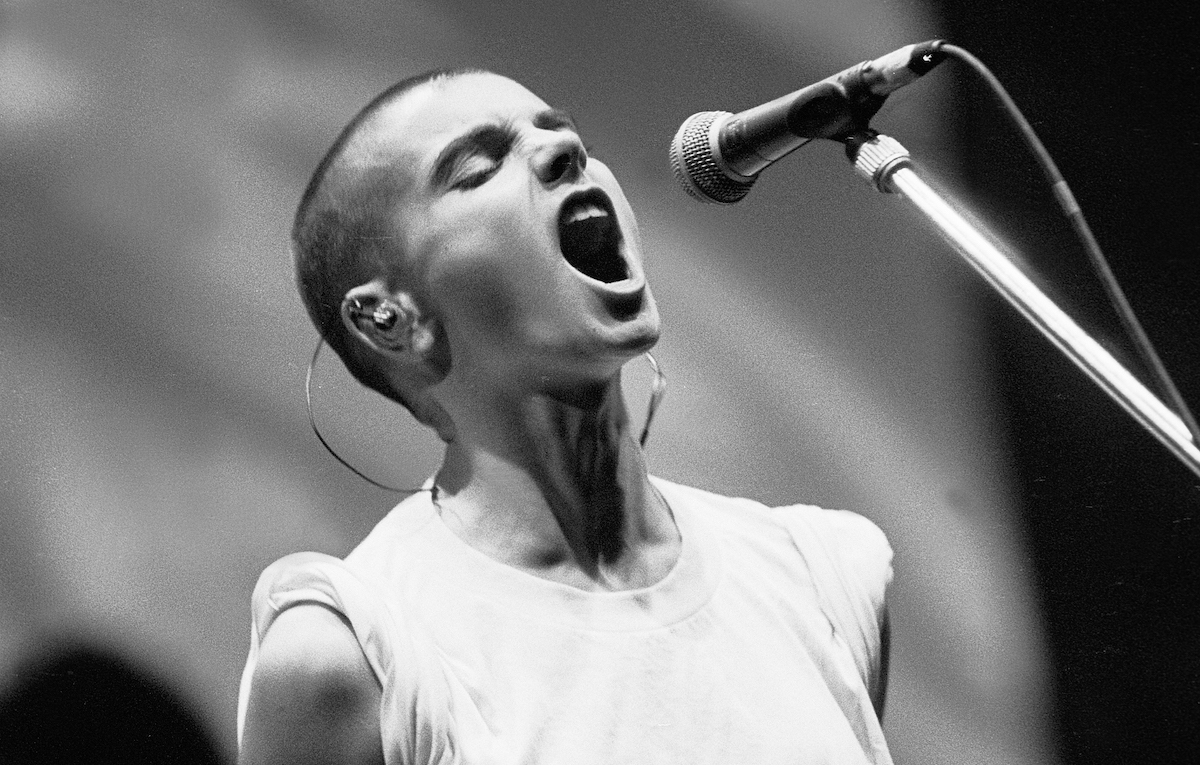Ho conosciuto un sacco di tossici. Molti di questi ci hanno lasciato la pelle, altri si trascinano ancora adesso conducendo una vita miserabile. Da giovane, con parecchie di queste stesse persone, ho sperimentato una meravigliosa gioia di vivere, mentre suonavamo insieme e ci proiettavamo verso il futuro. Ovviamente, nessuno programma di trasformarsi in un tossicodipendente o in un alcolizzato. Alcuni sono in grado di fare certe esperienze in gioventù e poi andare avanti. Altri no.
Quando i Guns N’ Roses iniziarono a irrompere nelle coscienze collettive, io ero reputato un grande bevitore. Nel 1988, MTV trasmise un concerto durante il quale Axl m’introdusse, da prassi, come Duff “Il Re delle Birre” McKagan. Subito dopo quest’episodio, una casa di produzione che stava creando una nuova serie animata mi telefonò per domandarmi se io fossi d’accordo che loro usassero il nome Duff come marca di birra nel cartone animato. Mi misi a ridere e risposi Certo, nessun problema! L’intera faccenda sembrava un programma con velleità artistiche di basso profilo o qualcosa del genere: voglio dire, chi crea cartoni animati per adulti? Non potevo certo immaginare che quello show sarebbe diventato I Simpson e che, in capo a qualche anno, avrei cominciato a vedere bicchieri e roba col marchio Duff ovunque andassimo in tour.
Comunque, tenuto conto di tutto, la nomea di grande bevitore non mi dava particolarmente fastidio. Ma – nel momento in cui i Guns N’ Roses trascorsero ventotto mesi in tour per gli album Use Your Illusion, dal 1991 al 1993 – il mio consumo di alcol toccò vette inaudite. Per quella tournée mondiale i Guns noleggiarono un aereo privato. Non si trattava di un piccolo jet da uomini d’affari; era un 727 affittato presso il Casinò MGM, con salottini e suite per ogni componente del gruppo. Io e Slash celebrammo il nostro viaggio d’esordio su quel colosso d’acciaio fumando crack insieme. Ben prima che le ruote si staccassero dalla pista per il decollo (per inciso, non è una cosa che consiglio: la puzza si diffonde ovunque). Non ricordo neppure di aver suonato in Cecoslovacchia: abbiamo tenuto un concerto nello stadio di una delle città più incantevoli dell’Est Europa, poco dopo il crollo del muro di Berlino, e sono a conoscenza di essere stato in quel paese solo grazie al timbro sul mio passaporto.
Non era più tanto sicuro se io fossi o no uno di quei soggetti che, da giovani, fanno esperimenti e poi sono capaci di passare oltre. Mi premuravo quotidianamente di tenere una bottiglia di vodka accanto al letto, per il momento in cui mi sarei svegliato.
Provai a smettere di bere nel 1992, ma ricominciai senza freni dopo alcune settimane. Non riuscivo a fermarmi. Mi ero spinto troppo oltre. Cominciai a perdere i capelli a ciocche e, quando urinavo, provavo dolore ai reni. Il mio corpo non era più in grado di sopportare l’aggressione degli alcolici, senza mandarmi dei segnali di avvertimento. Avevo il setto nasale ustionato dalla cocaina e mi gocciolava il naso in continuazione, come un rubinetto guasto in un cesso malridotto. La pelle delle mani e dei piedi mi si stava sgretolando, e avevo delle pustole sulla faccia e sul collo. Dovevo fasciarmi le mani con delle bende sotto i guanti, per essere in grado di suonare il basso.
Ci sono tanti modi per tirarsi fuori da simili circostanze. Alcuni si fiondano in una clinica, altri vanno in chiesa. Altri ancora presso gli Alcolisti Anonimi. La maggior parte finisce distesa in una cassa di pino, alla quale mi sentivo condannato pure io. All’alba del 1993, il mio abuso di cocaina era diventato così serio che i miei amici – con alcuni dei quali avevo tirato coca o fumato crack – iniziarono a temere il peggio e, quando rientrai a casa per una pausa nel mezzo della tournée, provarono in tutti i modi ad allontanarmi dagli spacciatori. Ovviamente, io avevo i miei metodi per svincolarmi dai loro buoni propositi. C’era sempre un modo, a L.A. Una delle favole che mi raccontavo a ripetizione narrava che io non fossi un vero cocainomane. Dopotutto, non mi presentavo ai droga-party e non sniffavo mai solo per il gusto di farlo. A dire la verità, non sopportavo l’idea che mi stessi facendo di coca. Il mio consumo era prettamente funzionale: la tiravo perché i suoi effetti eccitanti mi facevano riprendere dalle sbronze colossali consentendomi di ubriacarmi ancora, spesso per più giorni consecutivi. In realtà, quasi sempre per più giorni consecutivi.
Dato che non volevo per nulla rientrare nello stereotipo del cocainomane, non adoperavo mai bizzarre attrezzature per rendere la sostanza più pratica da inalare. Mi procuravo semplicemente la mia bustina, la scartavo, tagliuzzavo in maniera dozzinale la pietruzza di cocaina in schegge più piccole e ne tiravo un po’. In breve tempo, ovviamente, quel comportamento burbero mi avrebbe fatto pagare dazio. Le mie pareti nasali erano sempre ustionate; a volte, il dolore era così insopportabile da spezzarmi in due. Poi, la moglie del mio spacciatore di fiducia, Josh, restò incinta.
Cominciai a preoccuparmi che non ce l’avrebbe fatta a smettere con la cocaina. Era una situazione inconcepibile per me, nonostante avessi un codice morale parecchio debole: si può giocare a proprio piacimento per divertirsi con la propria vita e quella soltanto, ma finire col mettere a rischio qualcun altro è inaccettabile. Non ero per nulla intenzionato nel ritrovarmi coinvolto in una faccenda nella quale ci avrebbe rimesso una terza persona innocente. Non si trattava soltanto di semplice dignità umana. Venivo da una famiglia numerosa, e a quel punto della mia vita avevo tipo ventitré nipoti tra maschi e femmine, che conoscevo fin da quand’erano nella culla. No, avrei insistito con Josh e sua moglie Yvette, e mi sarei imposto affinché lei smettesse. Sicuramente non ero capace di dare il buon esempio, ma mi resi disponibile per sostenere le spese del suo ricovero in riabilitazione. Sia Josh sia Yvette mi giurarono che, ovviamente, lei ci avrebbe dato un taglio, senza dubbio, e che non c’era nessun dannato motivo per cui avrebbe dovuto continuare a drogarsi con un bambino in grembo. Io ero sospettoso. Nel corso di un weekend mi raggiunsero con qualche altro amico al lago Arrowhead, sulle montagne a est di L.A., dove avevo acquistato un cottage. Certamente Josh si era portato dietro della roba. Li sistemai in una delle stanze al piano terra. Yvette mi sembrava fuori di testa. Per confermare i miei dubbi, entrai di soppiatto nella loro stanza e la sorpresi intenta a sniffarsi una striscia di coca. In quell’istante, capii che la mia esistenza aveva toccato il punto più basso. Persi il controllo. Li cacciai fuori da casa mia, intimandogli di non farsi rivedere mai più. Stavo schiumando di rabbia, nei loro confronti e verso me stesso. Quella giornata smisi di sniffare, e continuai a ubriacarmi nella depressione più nera per tutte le due terrificanti settimane che seguirono.
Le conseguenze dell’abuso di alcol erano più palesi senza cocaina, ed essere in grado di gestirsi divenne indiscutibilmente più complicato, molto più che smettere di farsi. Oggi so che cosa significhi soffrire davvero di delirium tremens. La definizione clinica del delirium tremens è che si tratta di una seria debilitazione psicotica che si manifesta in alcune soggetti affetti da alcolismo cronico ed è caratterizzata da violenti tremori, vivide allucinazioni, profonda ansietà, sudorazione eccessiva e improvvisi attacchi di panico. Allora sapevo soltanto che non fosse piacevole. Stavo veramente male. Il mio corpo mi stava lasciando così in fretta che mi sembrava di patire gli effetti collaterali della radioterapia.
Nel corso della tournée per Use Your Illusion, avevo registrato qualche canzone per conto mio, intrufolandomi negli studi qua e là lungo la strada. Quel progetto mi era tornato utile soprattutto per impiegare il tempo, che altrimenti avrei sprecato ubriacandomi, e non avevo un obiettivo preciso con quei provini, sul serio. Una di queste demo – la mia versione di You Can’t Put Your Arms Around a Memory di Johnny Thunders – fu poi inclusa in The Spaghetti Incident? dei GN’R, un disco di cover pubblicato appena dopo la conclusione di quella tranche di spettacoli. Mi cimentai con un po’ di tutto nel corso delle sessioni: basso, chitarra, batteria. Cantai pure, e in alcuni brani si sente in maniera palese che non riuscivo a respirare col naso. A un tratto, un impiegato della casa discografica che ci accompagnava in tournée mi domandò perché, in quei giorni, io continuassi a sparire a intermittenza. Glielo confessai.
Quando Tom Zutaut, che aveva messo sotto contratto i Guns per la Geffen, ebbe sentore delle demo, mi chiese se fossi interessato a un contratto solista. L’etichetta, m’informava, le avrebbe racchiuse in un album. Ero conscio che, probabilmente, stava solo facendo i suoi interessi: in quel momento i Nirvana e i Pearl Jam erano sulla cresta dell’onda, e lui voleva puntare sulle mie radici di Seattle e le mie influenze punk per riposizionare i GN’R. Ma non aveva importanza. Per me era l’occasione di realizzare un sogno.
Ero cresciuto idolatrando Prince, che aveva suonato più di venti strumenti nel suo primo album, dove nei crediti compariva l’incredibile informazione: “scritto, composto, eseguito e registrato da Prince”. Figo, il mio disco realizzato come quello di Prince – in gran parte da solo – sta per essere distribuito in tutto il mondo. La Geffen lo fece uscire con il titolo Believe In Me nell’estate del 1993, proprio nel corso della tranche finale dell’Illusion Tour. Axl lo pubblicizzò sul palco durante gli ultimi spettacoli. E anch’io cominciai a promuoverlo in Europa. A una presentazione pubblica in Spagna, arrivarono talmente tanti fan che la polizia dovette bloccare l’ingresso del negozio di dischi in tenuta antisommossa.
Avevo schedulato l’inizio del mio tour da solista subito dopo gli ultimi show dei GN’R, i due concerti finali a Buenos Aires nel luglio del 1993, e mi avrebbe portato a esibirmi prima in diversi showcase a San Francisco, Los Angeles e New York e, in seguito, ad aprire il tour negli stadi degli Scorpions in Europa e Regno Unito. Appena rientrato a L.A. raggiunsi il gruppo di amici e conoscenti che mi avrebbe seguito on the road. Avevano già iniziato a provare prima che tornassi, e ci organizzammo in tutta fretta. Axl, saputo che stava pianificando di tornare in tour, mi telefonò. «Ma sei impazzito? Dannazione, non puoi rimetterti in strada proprio adesso. Sei un folle anche per il solo fatto di averci pensato».
«È l’unica cosa che so fare», gli dissi. «Suonare».
Sapevo anche che, se fossi rimasto a casa, probabilmente sarei ricascato ancor di più nella droga. Non mi facevo troppe illusioni sul rimanere sobrio, ma pensavo che andando in giro con una formazione composta da vecchi amici punk rocker di Seattle forse sarei riuscito a tenere le cose sotto controllo. E a stare alla larga dalla cocaina. Se fossi rimasto a Los Angeles, la certezza di potermela procurare con estrema facilità avrebbe rappresentato una tentazione troppo difficile a cui resistere.
Il management dei GN’R mi fece seguire in tour da Rick “Truck” Beaman, già mia guardia del corpo durante i giri per Use Your Illusion. Però in questo caso il suo comportamento nei miei confronti sembrò andare oltre i suoi doveri professionali. S’interessava personalmente, come amico, a tentare di limitare il male che mi stavo facendo. Ora, finalmente, avevamo degli obiettivi comuni. Almeno per quanto riguardava la cocaina. Ma Axl aveva ragione. Prima della data inaugurale di San Francisco la mia moglie dell’epoca, Linda, finì coinvolta in una scazzottata nel backstage con un’altra donna, rimettendoci un dente. C’erano schizzi di sangue dappertutto. A New York, gli Hell’s Angels si presentarono a frotte imballando la Webster Hall e scatenarono una rissa. Urlavo alla folla per cercare di contenerla, credendo di potere in qualche modo fare la differenza. Dopo lo spettacolo, un po’ di gente tentò di venirmi a trovare nei camerini, ma io volevo restare solo. «Sono troppo stanco», dissi alla security. «Non ce la posso fare». Le parole di Just Not There, una delle canzoni di Believe In Me, risuonavano nella mia testa:
You know I look but just can’t find the reasons
To face another day
Cause I feel like crawling up inside
Just fading away, fading away…
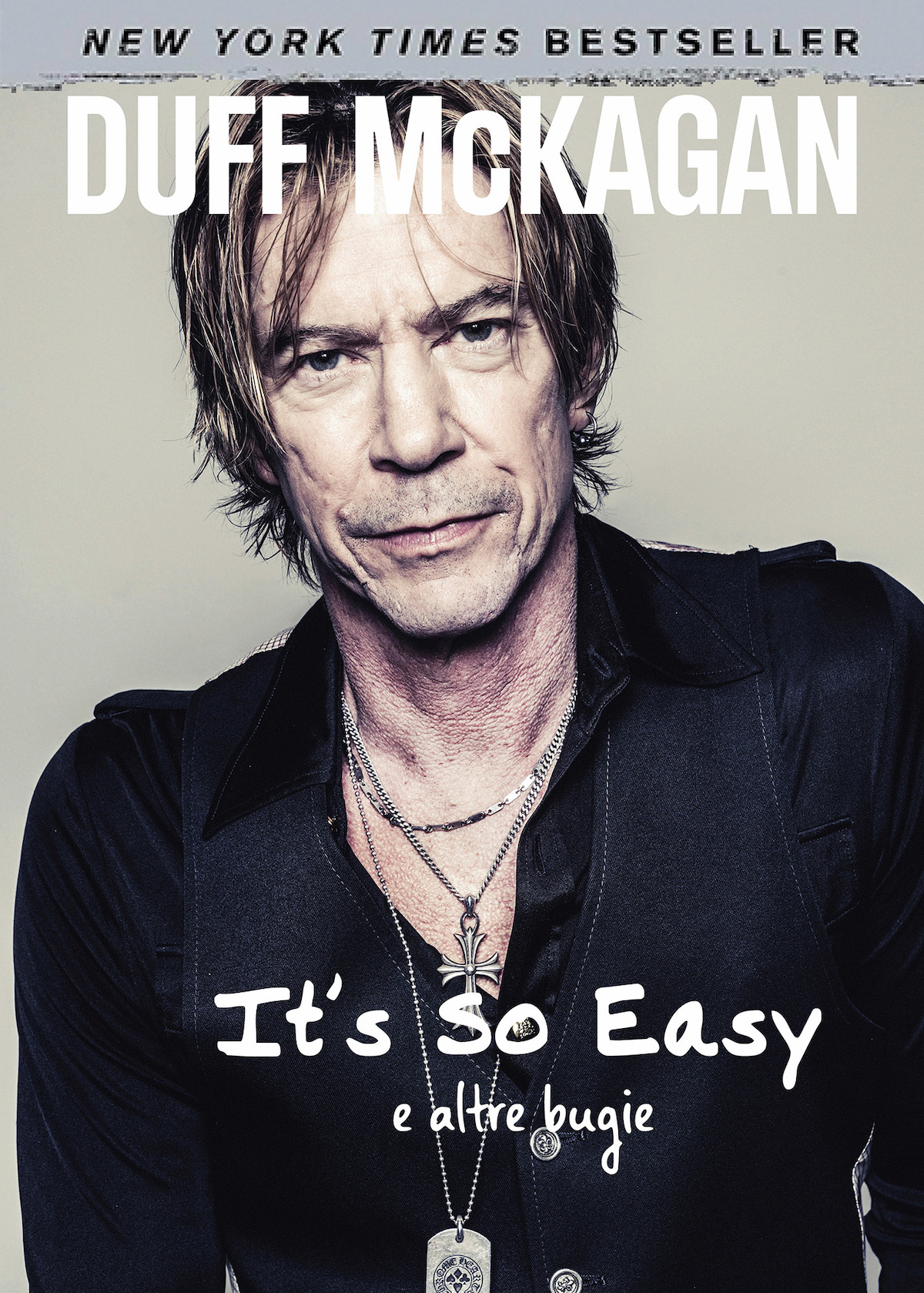
Tratto dalla nuova edizione di It’s So Easy e altre bugie di Duff McKagan (Il Castello).