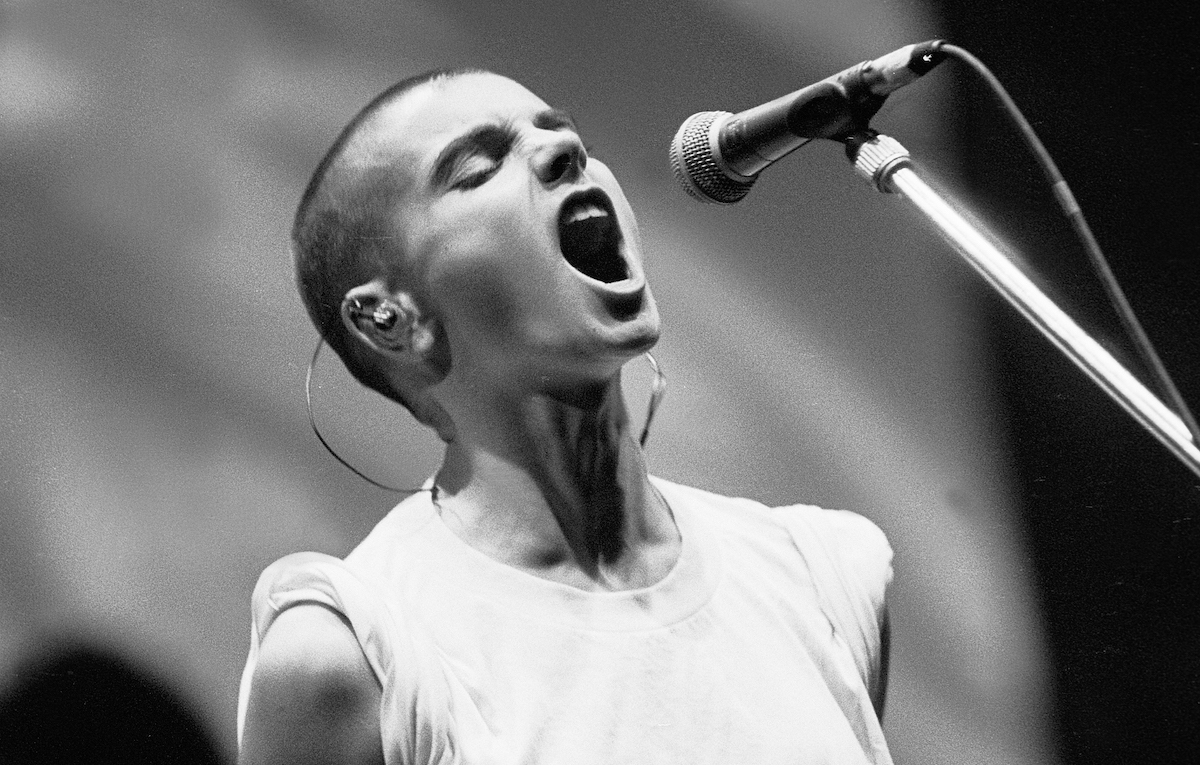Si passa alla storia solo quando si è morti, o quando si è diventati – nel presente – una stanca replica di se stessi? Eh. Non è una domanda simpatica, effettivamente. Ma è una domanda che nasce proprio dalla bellezza e dell’intensità del film-documentario Disco Ruin: scritto da Lisa Bosi e da lei diretto assieme a Francesca Zerbetto, esce in una quarantina di sale in giro per l’Italia il 5, 6 e 7 luglio ed è davvero da consigliare caldamente come visione. Lo è se si è appassionati di discoteche, clubbing e dintorni, perché la quantità di materiale prezioso raccolto è davvero impressionante (dai flyer alle foto d’epoca, dalle interviste ai retroscena); ma lo è in realtà ancora di più se si ha una frequentazione solo tangenziale o addirittura una diretta ostilità (o un ragionevole dubbio…) nei confronti del mondo del ballo, ovvero della musica e della cultura ad esso connesse dagli anni ’70 in poi.
Le discoteche sono una roba da fascisti: questa è un’eredità – o una polpetta avvelenata – che ci portiamo dietro da quando il disimpegno e l’edonismo hanno minato alla base la grande stagione del ’68 e dintorni, e dei libretti rossi maoisti o autonomisti, così come l’ombra ingombrante dei grandi partiti – madre e padre insieme – che decidevano come ti dovevi comportare e come ti dovevi divertire. Discoteche perfetto capro espiatorio, anche con loro concorso di colpa, sia chiaro.
Poi, sfangati gli anni ’80 demichelisiani petulanti e arroganti, che si sono proprio messi d’impegno a far confermare su ballo e discoteche tutti i pregiudizi da sinistra, sono arrivati gli anni ’90: ovvero l’onda lunga propagatasi in tutta Europa di quello che l’Inghilterra ha capito da un lato della rivoluzione techno di Detroit e della house di Chicago (musiche post black, e per molti versi post umane), dall’altro invece della voglia di divertirsi al sole del Mediterraneo di Ibiza. L’energia della gioventù anglosassone presa a nerbate dalla Thatcher e la capacità cinicamente British di spremere industria dalla passione per la musica hanno poi chiuso il cerchio, combinando i vari fattori. Ecco: lì la discoteca e il ballo hanno smesso di essere roba da fascisti, ma hanno iniziato ad essere roba da drogati (e non è che i fascisti abbiano iniziato a drogarsi, eh, non è così che è andata; lo facevano anche prima, ma per essere più stronzi, non per essere più pace & amore & libertà).

Il Woodpecker di Milano Marittima. Da ‘Disco Ruin’
Insomma: in Italia c’è una lunghissima tradizione del non capire un cazzo – o capire solo una parte della faccenda, va’ – per quanto riguarda il ballo e il clubbing. Tradizione talmente micidiale da averci impedito, ecco, di essere inglesi: ovvero di capitalizzare e strutturare imprenditorialmente e pure socialmente a nostro vantaggio quel momento in cui sì, siamo stati avanguardia assoluta d’Europa. Disco Ruin, decisamente preciso, efficacissimo e pure suggestivo nel ricostruire tutta una serie di passaggi, di talenti e di colpi di genio, è (anche) il racconto di questa occasione mancata. Nel nuovo millennio, dove l’immaginario dei ventenni (anche quelli meno strettamente devoti all’elettronica) è colonizzato dalla dinamicità di Berlino e/o dall’edonismo di Ibiza, al posto di queste due realtà poteva esserci la Riviera romagnola, o la Toscana dell’Insomnia, o Roma, o la Jesolo del Movida. Sì. Potevano esserci loro. Perché queste realtà di casa nostra – e anche altre, anche alcune non citate nel film – a un certo punto sono state avanguardia mondiale. Soprattutto, sono state cucina di un avanzamento intellettuale e sociale spaventoso, vertiginoso (a partire dall’accettazione del gender fluid, di cui ci si riempie la bocca ora, ma che in Italia è nato ed è stato praticato prima di tutto nelle discoteche anni ’80 e ’90; così come la distruzione delle barriere di classe, perché nei posti migliori non era importante quanto fossi ricco e di chi fossi figlio e quale fosse il tuo lavoro, ma quanto eri creativo nel weekend).
Il modo in cui Disco Ruin con interviste, testimonianze, materiali d’archivio, scelte registiche documenta tutto questo è, ve l’assicuriamo, magistrale, pur non potendo contare su chissà quali mezzi produttivi se non il duro lavoro di ricerca e documentazione. Anche perché riesce veramente a far risuonare una visione d’assieme, a livello sia estetico che emotivo: visione che sì, a un certo punto nel clubbing italiano c’è stata, in una linea che è comparsa tra l’altro anche in letteratura: e giustamente sono le parole di Fluo di Isabella Santacroce e di Rimini e Altri libertini di Tondelli a fare da filo narrativo poetico in voice over, una scelta tanto bella e corretta quanto efficace.

Il Topkapi di Lido di Spina (FE)
Nella meravigliosa e proverbiale capacità dell’Italia di essere cialtrona e, al tempo stesso, di non saper sfruttare in modo sistemico le sue ricchezze intellettuali e i suoi talenti, tutto questo è andato a schifìo. La Ruin, ovvero la rovina, apre proprio il film, con le macerie della discoteca Ultimo Impero a rappresentare il primo piano sequenza, e nell’arco del resto del girato continua cupamente ad apparire tra un’intervista inedita e un’immagine di repertorio. Macerie, continue macerie (tra l’altro se siete appassionati del genere c’è un bel volume da reperire: Disco Mute. Le discoteche abbandonate d’Italia, Addictions-Magenes Editoriale, a cura di Alessandro Tesei e Davide Calloni). Giusto così, scelta corretta. Perché se qualche discoteca storica c’è ancora e ancora opera, a partire dal Piper via via fino al Tenax, e se la Riviera annuncia grande rinascita a partire dalla riapertura – ancora però non fissata, e di continuo rimandata – del Cocoricò dopo il fallimento della gestione romana di qualche anno fa, sono in realtà più le scomparse a farla da padrona, nel mondo del clubbing italiano, tolto chi ha capito il giro del fumo ed è salito a bordo del carrozzone di Ibiza e dei grandi festival a trazione capitalista e finto-edonista.
Una scomparsa dura da accettare è anche quella del compianto Claudio Coccoluto, che con alcune parole molto sentite a Disco Ruin ha dato un bellissimo contributo. Per fortuna altri suoi colleghi – partire da Ralf e dalla sua immensa umanità e da Alex Neri – tengono alta la bandiera, e nel film-documentario sono presenti con interventi azzeccati e molto a fuoco, così come un’altra pletora di dj storici (Corrado Rizza) o meno storici (Lele Sacchi). Chiaro: il senso persistente è come si stia parlando un po’ tutti quanti di un bellissimo futuro dietro le spalle, e chi è ancora nel gioco e nel sistema – sono tanti – lo è più per cocciutaggine e persistenza, e magari per amore del proprio mestiere, che per altro. La stanca replica di se stessi, nella frase che apre questo articolo. Il clubbing di oggi, in alcuni suoi meccanismi (non in Italia, eh), è magari più organizzato, più professionalizzato, più a bravo a tenere di conto e a massimizzare il profitto, ma ha retrocesso se non tutto almeno molto a ragioneria, a calcolo, ad abitudine imprenditoriale. Pure l’uso della droga è stato oggi abbastanza normalizzato, senza la devastante bulimia escapista degli anni ’90 ma con la capacità di sapersela amministrare per non restare espulsi dal ciclo produttivo standard: e questa se vogliamo è l’unica mezza buona notizia, perché bella la creatività da fattanza, ma poi arriva il down che ti fiaccia mente e corpo e, insomma, non è proprio una bella cosa.

L’Ultimo Impero ad Airasca (TO)
Ecco: magari una critica che si può fare a Disco Ruin è di essersi soffermato solo sui lati più belli, più scintillanti e più creativi della stagione d’oro dei club e delle discoteche in Italia, senza raccontare invece il malaffare, le gestioni a cazzo, le infiltrazioni malavitose, la gente via via più rincoglionita dall’uso ed abuso di droghe o anche solo da semplice mitomania. Ma sarebbe stato probabilmente chiedergli troppo. Quello che è certo è che anche (e soprattutto?) ad occhi profani o scettici, restituisce una storia, un immaginario, un senso di rivoluzione collettiva, una estetica condivisa; testimonia con notevole efficacia qualcosa che c’è stato davvero, e che dall’esterno non è mai stato compreso fino in fondo, con la conseguenza che ha inciso meno – o proprio inciso gran poco – nel rendere l’Italia un posto migliore.
Avrebbe potuto; e, per certi versi, in medias res ci stava in parte anche riuscendo, chi all’epoca c’era se un po’ ci ripensa magari se ne rende conto. Oggi nel 2021 ci emozioniamo per l’indie a Sanremo, o i Måneskin in eurovisione (o al contrario ci siamo sentiamo fighi, antagonisti e controculturali a denigrare tutto ciò). Confrontate però tutto questo con la follia, la visione e la creatività che Disco Ruin fedelmente (e molto efficacemente) annota e racconta, ricordando che certe faccende e certe visioni sono state per qualche stagione proprio un fenomeno di massa, e mettete tutto in proporzione. Con buona pace della discoteca che è da fascisti, dell’elettronica che non è musica, del ruock.