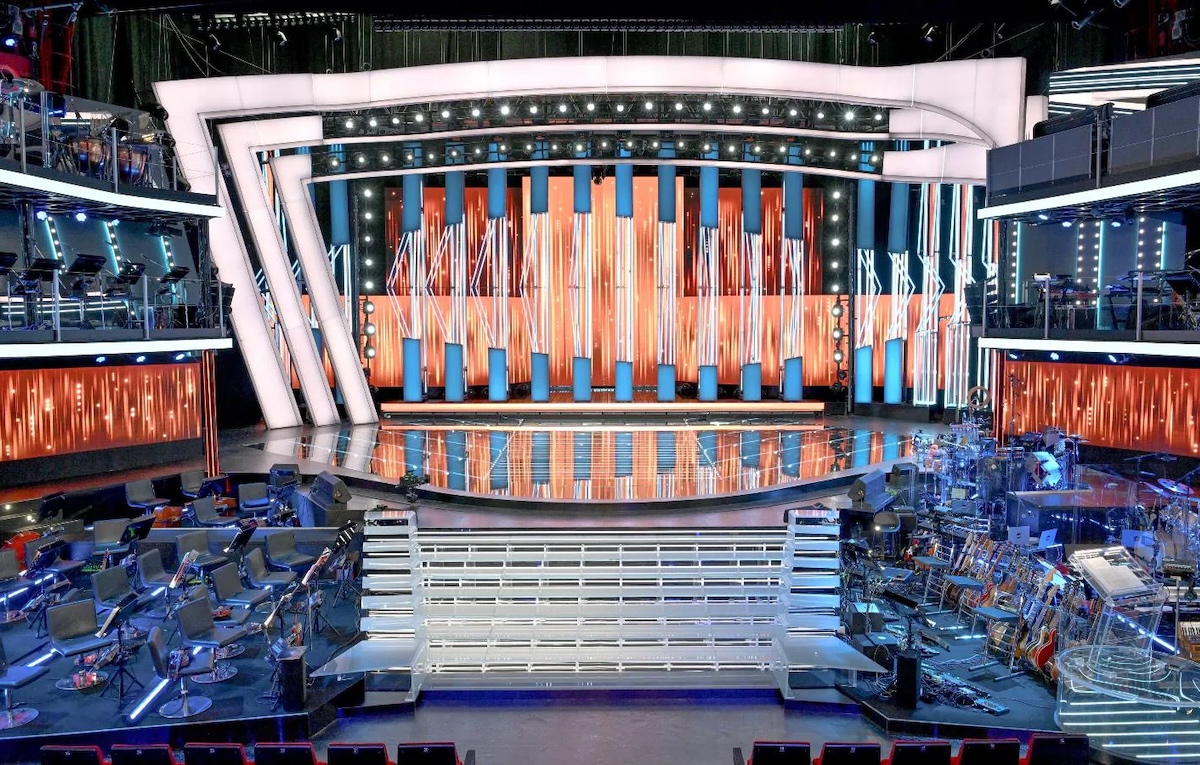«Tempo. Una delle espressioni più complesse. È la memoria che lo ha reso manifesto. È sospeso tra passato e futuro, senza mai essere davvero presente. O piuttosto, all’inizio sembra indifferente al presente. Una tensione che non è umanamente misurabile. La parola brama di essere compresa per avere significato. Ma in qualche modo senti che la parola non è indirizzata a te. Sembra scorrerti sopra, intrattenendo un dialogo con qualcosa di arcano, che forse non è mortale. È questo che ti affascina, forse ti cattura. Sei consapevole di un’esistenza più profonda, che ti dà un momentaneo conforto. Non c’è inizio e non c’è fine. All’improvviso trascendiamo l’apparenza esteriore del significato. Quando ti ritrovi a lottare per comprendere un mistero profondo e assoluto, tutto diventa transitorio. Ha importanza? Mi importa?».
David Bowie ha sempre avuto un rapporto complesso con l’idea di memoria e con lo scorrere del tempo. Più che essere ricordato, sembrava interessato a capire come il tempo potesse essere attraversato senza trasformarsi in una trappola. È forse da qui che vale la pena partire, a dieci anni dalla sua morte, per evitare l’ennesimo ritratto celebrativo e provare invece a seguire il metodo quasi scientifico con cui ha portato avanti la sua sfida personale con la temporalità.
Molto prima che la parola curatela diventasse centrale nel lessico culturale, Bowie aveva già impostato il suo lavoro in questi termini, non limitandosi “solo” a produrre, ma tenendo sempre in primo piano il concetto di selezione. Non a caso, già all’inizio degli anni ’70, parlando di sé al Melody Maker, spiegava di non sentirsi un grande autore quanto piuttosto un abile compilatore. Non si trattava di una posa, né un gesto di modestia: era una descrizione accurata del suo modo di stare all’interno della cultura del suo tempo. Bowie ha sempre lavorato per connessioni, accostamenti, filtri. Lo si vede con chiarezza ogni volta in cui ha reso esplicito il suo sguardo, come è accaduto nel 2003 con la lista dei suoi 100 libri preferiti pubblicata dalla BBC. Un vero e proprio tracciato, una costellazione in cui Mishima conviveva con Orwell, Kerouac con Genet, Burgess con Colin Wilson, non una semplice lista basata sul gusto, né una biblioteca ideale. Bowie non usava dunque il passato come rifugio, ma come materiale ancora attivo, qualcosa che poteva essere rimesso in circolo se collocato nel punto giusto.
La stessa logica ha attraversato in qualche modo tutta la sua traiettoria musicale. Dalla fusione degli idoli musicali giovanili per creare i suoi primi personaggi, al Kraut rock portato dentro il rock britannico, fino al soul di Philadelphia filtrato attraverso Young Americans, Bowie ha agito spesso come un mediatore, qualcuno che prendeva linguaggi già esistenti e li spostava di contesto. Quando nel 1976 ha detto a Rolling Stone di non sapere dove stesse andando, ma che di certo non sarebbe mai risultato noioso, parlava di movimento, di una necessità quasi fisica di non fermarsi, di non tornare a occupare la stessa posizione due volte. Qualcosa di molto diverso dal rivendicare l’imprevedibilità come valore assoluto.
In questo senso, il tempo è probabilmente il vero grande tema della sua opera. Più delle identità, più delle maschere, più delle ambiguità. Major Tom, figura che Bowie riprende e abbandona più volte, è l’immagine perfetta di ciò che teme di più: la sospensione, l’impossibilità di andare avanti o indietro, il restare bloccati in orbita. Negli anni ’90, quando affermava che se ti senti al sicuro mentre lavori significa che stai operando nel posto sbagliato, Bowie parlava proprio del rischio di trasformare il passato in una comfort zone. Per questo ogni suo personaggio nasceva già come provvisorio. Ziggy ha un arco narrativo chiuso. Il Duca Bianco è destinato a dissolversi. Non c’è accumulo, non c’è continuità rassicurante. La carriera, per Bowie, è una serie di passaggi, di fratture, di deviazioni calcolate. E per lo stesso motivo, il periodo più buio della sua carriera, gli anni ’80, rappresentano un unicum in cui Bowie non lavora più su quel piano, ma si limita a guardare cosa aveva intorno e a seguirlo senza reinventarlo. Non a caso, quello sarà anche l’unico momento in cui metterà in piedi un tour totalmente autocelebrativo, il Glass Spider.
Paradossalmente, questa attenzione costante al movimento non ha mai significato rimozione del passato. Anzi. Bowie conservava tutto. Oggetti, costumi, appunti, fotografie, materiali di lavoro di ogni epoca. Lo ha fatto in modo sistematico, quasi ossessivo nel corso di tutta la sua vita. Bowie Is, la mostra inaugurata nel 2013 al Victoria and Albert Museum, nasceva proprio da quell’immenso archivio. L’ha seguita in prima persona proprio per evitare che potesse trasformarsi in un progetto postumo, in una celebrazione affidata ad altri. In quel contesto, Bowie organizzava la propria storia come un percorso, dove ogni fase veniva collocata, spiegata, messa in relazione con le altre. Qualcosa utile non a fissare un’immagine definitiva, ma a rendere leggibile la chiara traiettoria del suo percorso. È un altro atto di curatela, forse il più esplicito: in quel frangente Bowie ha deciso come il suo passato doveva essere attraversato, senza lasciarlo alla mitologia o alla nostalgia.
La stessa attenzione emerge anche nella gestione di quello che sarebbe stato pubblicato dopo la sua morte. Le uscite postume, le ristampe, i box set seguono infatti una linea editoriale precisa, impostata maniacalmente prima della fine. Un atto in cui anche l’assenza viene governata e persino il silenzio ha una struttura. Un decennio prima, Bowie aveva intuito con la stessa lucidità un altro nodo destinato a diventare centrale nelle nostre vite: quello della sovrabbondanza. Alla fine degli anni ’90, parlando di un Internet ancora agli albori, osservava che il vero problema era rappresentato dalla somiglianza della rete con la vita stessa, perché, come disse alla BBC nel 1999, era «semplicemente troppo di ogni cosa». La sua risposta non è stata però la sottrazione a quel troppo, ma, ancora una volta, si è fatto filtro. BowieNet, le raccomandazioni pubbliche, le playlist ante litteram: Bowie anche lì si è mosso come un selezionatore in un mondo che sembrava perdere rapidamente gerarchie e strutture obsolete.
Anche Blackstar si inserisce perfettamente in questo disegno, come ultimo e definitivo lavoro sul tempo. Quando in Lazarus canta “guardate quassù, sono in paradiso”, Bowie non chiede di essere ricordato, né offre una consolazione finale. Lascia ancora una volta simboli, immagini e connessioni aperte, riprende sì qualcosa del suo passato ma anche qui come a dire che tutto è collegato e ha una temporalità ben precisa. Forse è questo il punto, a dieci anni di distanza dalla morte: più che chiederci chi fosse David Bowie, vale la pena chiederci cosa ci ha insegnato a fare con il tempo che abbiamo. In un presente che tende a ripetersi, Bowie resta inattuale perché non invita a tornare indietro. Mostra piuttosto come scegliere, come ordinare, come attraversare. E come prendersi cura del futuro, senza smettere di guardare ciò che lo ha reso possibile.