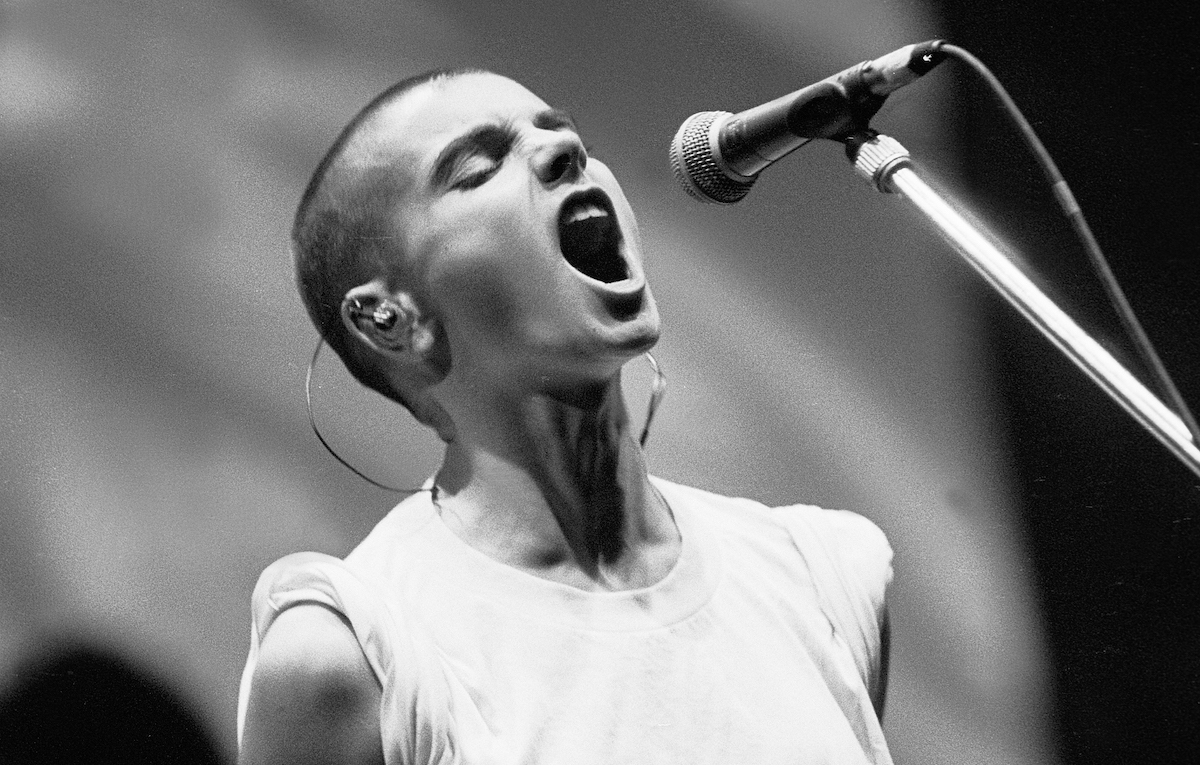Al netto del panico da necromanzia AI, sono le dichiarazioni dei diretti interessati a indicarci suggestive chiavi di lettura sulle ultimissime collaborazioni postume in campo musicale. Colapesce e Dimartino si chiedono se sia «eticamente giusto» completare un inedito di Ivan Graziani – I marinai (1997) – ricevuto direttamente dalla di lui famiglia. Per Now and Then, «the last (e non the latest, nda) Beatles track», Paul McCartney dichiara che si è proceduto al mix «as you would normally do», affidando all’avverbio «normalmente» la consapevolezza di una pratica in linea con qualsiasi altra produzione discografica, mentre Sean Ono Lennon sottolinea il verbo «to work», emozionandosi per «l’ultima canzone a cui mio padre, Paul, George e Ringo hanno lavorato insieme». Il dirompente sottinteso è che sì, può esserci collaborazione tra il nostro mondo e l’aldilà; e che anche il lavoro dei morti, nella società capitalista, è produttivo e redditizio.
Che siano percepite o meno come etiche, queste operazioni suscitano di volta in volta minor clamore (sempre al netto dell’incubo AI): sarà che entrambi i brani citati sono usciti a ridosso del 2 novembre, sarà più probabilmente che siamo ormai abituati all’idea di ascoltare nuove canzoni da voci non più legate a corpi viventi.
E ci mancherebbe, dato che queste tracce fantasma rappresentano un affermato filone almeno dal duetto virtuale del 1991 tra Nat King Cole (passato a miglior vita nel 1965) e sua figlia Natalie. Unforgettable di nome e di fatto, diversamente dal Grammy per la miglior «country vocal collaboration» dell’anno prima, che in pochi ricordano vinto da Hank Williams Jr. e dal defunto padre per There’s a Tear in My Beer. Sì, già allora ci poteva essere collaborazione tra vivi e morti; o addirittura tra due interpreti deceduti, come accaduto già nel 1981 tra Jim Reeves e Patsy Cline (Have You Ever Been Lonely), anch’esse star del country, perite in due distinti incidenti aerei tra 1963 e 1964.
Senza dilungarsi in inventari retrospettivi ci basti ricordare che il primato nel genere spetta niente meno che a Enrico Caruso, la cui voce era stata isolata da un vecchio disco già nel 1932 e riportata in sala d’incisione con un’orchestra in carne e ossa. Nel video intitolato Voice Grafting – The Latest Miracle of “Sound” Science è palpabile l’albionica soddisfazione negli studi della His Master’s Voice. Il cui logo è pur sempre il cagnetto Nipper che ascolta dalla tromba del grammofono la voce del padrone (anch’egli, manco a dirlo, estinto).
Questo per dire che una certa necrofilia è connaturata all’industria discografica sin dai suoi albori. «Il pungiglione della morte si è spuntato, da quando siamo in grado di conservare per sempre le voci dei morti», si legge in un articolo del 1896, a dimostrazione di quanto il carattere tanatologico di questa tecnologia fosse evidente ai suoi pionieri, ben più di quanto lo sia per noi quello dell’AI. Lo sviluppo della registrazione in multitraccia ha “soltanto” ampliato le discontinuità cronologiche e spaziali alla base della produzione discografica: quando Sir Paul adopera l’avverbio «normalmente», allude proprio al fatto che produrre una hit a partire dalla performance di un interprete scomparso non è tanto più problematico che mixare tracce registrate da esecutori vivi in momenti diversi.
Più o meno. Perché la questione non è soltanto tecnologica. C’è innanzitutto il fatto che come ascoltatori siamo ben coscienti della natura intermondana di questi featuring post mortem e del loro valore simbolico, il che è proprio l’elemento cruciale nella reunion finale dei Beatles e nei ricongiungimenti familiari dei Cole e dei Williams.
In Mortality and Music: Popular Music and the Awareness of Death (2015), Christopher Partridge scrive che «la morte di un musicista richiede una risposta alla mortalità che riduca l’impatto della nostra consapevolezza dell’impermanenza»: le tracce registrate ci forniscono una sorta di reliquia, una connessione spirituale con l’artista da cui deriva un’idea di sacralità e di immortalità.
Trattando la ricca produzione postuma di Tupac Shakur, Alessandro Bratus precisa tuttavia che «per essere percepite come operazioni legittime e non di sfruttamento, queste tracce fisiche devono essere composte in oggetti comunicativi dotati di significato, che non contraddicano le idee preesistenti sul performer morto. Gli artefatti sonori postumi, quando riescono, integrano le reliquie dei musicisti del passato all’interno di un ambiente di ascolto significativo e di una serie di relazioni con altri artisti basate su convenzioni di stile e genere». Nella sua forma «registrata e distribuita», prosegue, il passato è credibile e rilevante nel presente solo se capace di «influenzare e partecipare al discorso culturale attuale».
Un nuovo verbo entra così in campo: credere. Nel caso di Tupac, riteniamo credibile il suo primo album postumo, The Don Killuminati: The 7 Day Theory, le cui tracce rievocano vita, morte e presenza fisica del performer anche grazie alla sua voce parlata, percepita come autentica. Non così per Loyal to the Game – titolo eloquente – prodotto da Eminem e criticato come non certo leale nei confronti della personalità e dell’integrità artistica di Tupac. Nonostante le possibilità tecnologiche, scrive ancora Bratus, «ci sono confini che possono essere superati solo al prezzo di perdere il sostegno del pubblico in termini di fiducia nell’artefatto sonoro o audiovisivo».
Se riteniamo credibile Now and Then è perché sono Paul e Ringo a “lavorare” assieme a John e George: ci affidiamo alle loro convenzioni di gruppo e alla loro pertinenza stilistica; diamo per sincera la volontà di riunirsi» ai cari estinti (con le dovute differenze, lo stesso discorso vale anche per Colapesce e Dimartino). In definitiva, inseriamo il brano in un contesto comunicativo più ampio.
Eppure non possiamo fare a meno di chiederci se Lennon sarebbe contento di vedere pubblicato un provino domestico che egli stesso non aveva ritenuto degno di comparire nel suo ultimo album. Ma non possiamo neanche avere la certezza che Freddie Mercury, pur cosciente di lasciare le sue ultime tracce vocali ai compagni che gli sarebbero sopravvissuti, avrebbe approvato il mix finale di Made in Heaven.
In questo processo di autenticazione entra infatti in gioco la volontà dell’artista, la sua agency, termine con cui si indica intenzionalità, capacità di agire e di avere conseguenze effettive. Quando si tratta di assumere decisioni, però, la voce degli artisti scomparsi viene doppiata da quella dei loro eredi e nessuno può garantire fino in fondo sulla loro armonia, né tanto meno sulla concordia familiare, come ci insegna la stessa Natalie Cole, citata in giudizio dalla madre per questioni di eredità nel 1995 (guarda caso dopo il successo di Unforgettable). Il dilemma etico, insomma, è ben fondato.
Ma se è vero che un artista può continuare a esercitare la sua agency — e a generare guadagni — anche post mortem, allora dovremmo forse ripensare l’idea stessa di personalità, riconoscendole la capacità di trascendere i limiti fisici e di articolarsi in entità testuali, tecnologiche, affettive, giuridiche ed economiche.
È il dazio di ciò che i filosofi chiamano società postumana, quella in cui gli uomini smettono di vivere per “funzionare” e che costringe anche la musica a recidere il filo tra corpi e suoni, in un persistente feedback tra liveness e deadness. La registrazione, reversibile e combinatoria per natura, continua ad assemblare, disassemblare e riassemblare, «as you would normally do»: annulla, ripeti, copia e incolla (per dirla male). Non si accontenta più di imbalsamare le voci dei defunti, ma mira a riarticolarle: il suo statuto non è più la simulazione del reale ma il suo superamento (per dirla meglio).
Etiche o meno che siano, le tracce fantasma sono tra i più efficaci esercizi per realizzare tale statuto; ogni qual volta vengono riesumate, però, portano con sé l’eco dei propri valori simbolici e il rumore di fondo di quelli commerciali.
Resta qualche dubbio sulle loro funzioni artistiche. Non sarà per i duetti virtuali – presumiamo – che Nat King Cole resterà unforgettable, e c’è da scommettere che Now and Then aggiungerà poco o nulla all’eredità artistica dei Fab Four. Restando nel campo delle speculazioni possiamo concordare che sì, con Lennon in vita il pezzo non sarebbe uscito: non perché ne avrebbe vietato l’utilizzo, ma perché sarebbe stato certamente capace di scriverne uno migliore.
Il fatto è che stavolta il discorso non è artistico. Piuttosto, e qui non stiamo più speculando, chi può garantirci a questo punto che in un futuro senza Beatles viventi le loro voci non saranno riassemblate in nuove forme con il prossimo trucchetto tecnologico? C’è una linea sottile tra last track e latest trick.