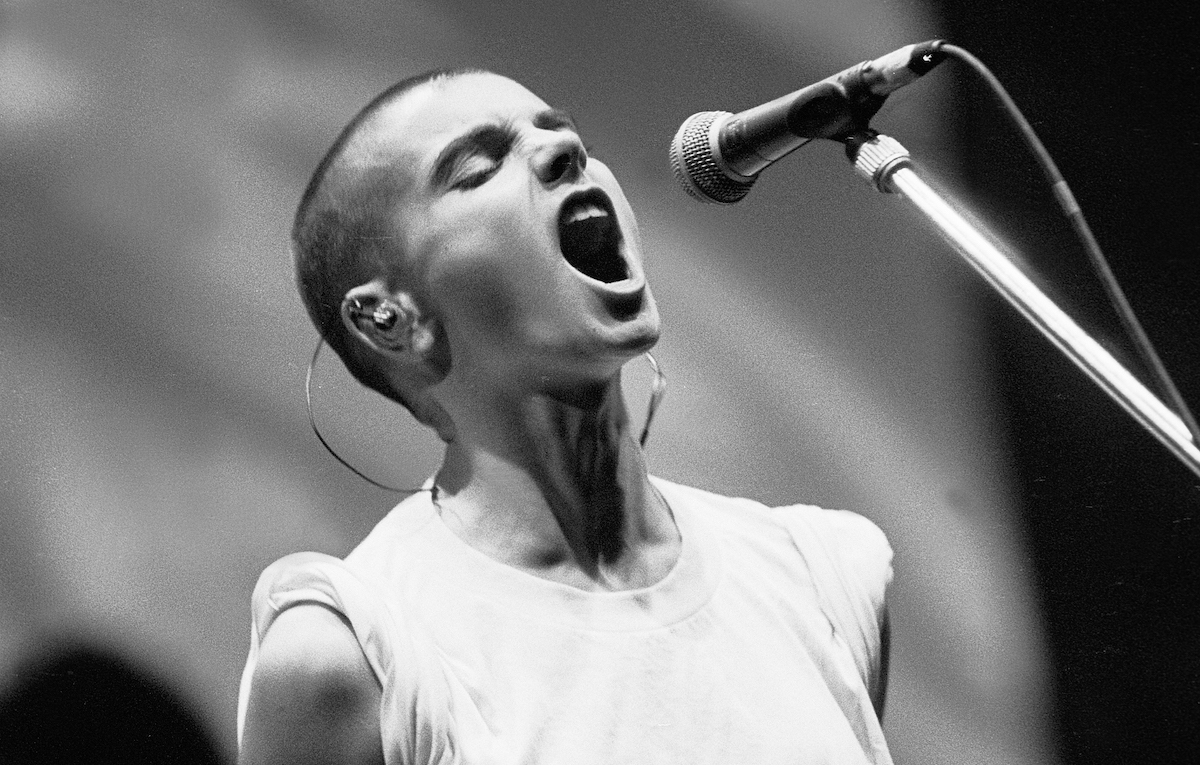La prima cosa che ti chiedi è perché mai nel 1962 una ventenne debba cantare un pezzo usato trent’anni prima da Roosevelt come inno della campagna presidenziale. Non appena Barbra Streisand attacca Happy Days Are Here Again cominci a intuire qualcosa. Non è la versione che si è abituati a sentire del canto carico d’ottimismo di chi si lascia alle spalle la crisi del ’29. Interpretata da Streisand pare un lamento funebre. L’aveva fatta così, ironica e drammatica, sei mesi prima al Garry Moore Show, trasformandola nella canzone di chi ha perso tutto nel crollo della borsa. Sei mesi dopo, c’è dell’altro. Streisand canta che “il cielo è di nuovo sgombro” e lo fa con aria mesta, quasi non ci credesse, quasi stesse pensando ai giorni in cui le dicevano che era «troppo speciale» per fare la cantante, e cioè probabilmente che era bruttina, ebrea e volgare. Per dirla col grande scrittore Tennesse Williams, la dolcezza della sua voce era alimentata dalla rabbia. Quando finalmente arriva il finale festoso, perché arriva, Streisand continua a stare dentro la canzone con la medesima credibilità. Si capisce che questa Happy Days non è solo l’autobiografia di una nazione, è una storia personale. L’anatroccolo di Brooklyn s’è trasformato nel cigno di Broadway.
È il 1962, dunque, e siamo al Bon Soir di Manhattan, dove Streisand si esibisce da un paio d’anni. Questa ventenne con «tanta voce, tanta sfacciataggine e tanto naso» s’era presentata all’audizione nel locale due anni prima masticando una gomma. Prima di cantare l’aveva appiccicata al microfono. Adorava passare da eccentrica, amava quei gesti apparentemente improvvisati, in realtà attentamente studiati. Continuò ad appiccicare la gomma tutte le volte, suscitando la curiosità d’un giovane Dustin Hoffman: «Che ragazza intelligente, c’è del metodo nella sua follia». Pure lui frequentava il Bon Soir, che stava tra la West 8th Street e la 6th Avenue, nel Greenwich Village: un palchetto, 25 tavoli, il bancone sul fondo, davanti gli etero, al bar i gay. Era un posto talmente buio, scriveva nel 1960 il New York Times, che le cameriere erano dotate di pile per orientarsi, «dando l’impressione di stare in una stanza piena di lucciole».
Messa sotto contratto dall’etichetta Columbia, Streisand avrebbe dovuto registrare il suo primo disco proprio al Bon Soir nei primi giorni del novembre 1962. Una volta riascoltate, le registrazioni non le parvero soddisfacenti. C’era troppo fruscio, gli strumenti non si sentivano bene, non c’era modo di separare il suono del pianoforte da quello della voce, forse il locale non aveva l’acustica giusta. Alcune incisioni sono state pubblicate, altre sono rimaste negli archivi fino all’uscita una decina di giorni fa di Live at the Bon Soir, il debutto che non è stato (e che ora credo sia suppergiù il 57esimo disco della cantante) e che ora suona benissimo grazie al lavoro dell’ingegnere del suono Joachim van der Saag. Non è certo il disco perfetto di Barbra Streisand, ma è la fotografia bella vivace d’una stella nascente e d’una cantante diventata tale per caso. Voleva recitare, ma le audizioni andavano male. Era troppo strana, la rimandavano a casa. E allora aveva cominciato a cantare, calandosi nei personaggi di vecchie canzoni, alcune scritte quando nemmeno era nata, proprio come un’attrice si prepara a un ruolo teatrale.
Verso la fine del Live at the Bon Soir arriva Nobody’s Heart Belongs to Me, un pezzo anni ’40 di Rodgers & Hart. È la storia d’una donna amata da nessuno, per la quale nessuno scrive canzoni, una che nessuno abbraccia. Era in un certo senso la storia di Streisand. Si considerava la ragazza a cui i ragazzi non concedono un secondo sguardo, una donna invisibile. Era diversa anche per l’abbigliamento. Portava scarpe e vestiti usati di venti, trent’anni prima. A volte indossava completi maschili. Strana e fuori moda oppure in anticipo sui tempi, come ha detto Camille Paglia: «È stato il primo personaggio pubblico a indossare abiti rétro anni ’30. Quel look da negozio dell’usato divenne poi lo stile hippie adottato da Janis Joplin».
In ogni caso, tutto passava in secondo piano quando saliva sul palco e apriva bocca. «La prima cosa che notavi era il naso», ha detto Tiger Haynes, chitarrista e leader del quartetto che l’accompagnava al Bon Soir, «poi guardavi il vestito. E quando sentivi la voce… beh, ecco». Lo scriveva pure il Time: «La sua voce cancella la goffaggine della presenza scenica».
Quella suonata al Bon Soir era musica vecchia nel 1962, figuriamoci oggi. Che ne ne facciamo di interpretazioni appassionate, stupefacenti e divertenti, sì, ma vecchio stile di Lover, Come Back to Me o di stranezze come Come to the Supermarket di Cole Porter o di quello scherzo di Leonard Bernstein su come nascono i bambini? Oggi Streisand è un monumento della musica americana che sembra interessata alla politica più che alla musica, un’aristocratica di sinistra con una timeline da attivista digitale. Per alcuni, non è che un’ottantenne milionaria che ha clonato la cagnetta ed è famosa per lo Streisand Effect. Non è così o comunque non è sempre stato così. Live at the Bon Soir è un disco pieno di vita che fa sembrare molta della musica di oggi nata morta. Ha anche un significato extramusicale. Ci rimanda all’epoca dopo il tramonto del primo rock’n’roll e prima dell’avvento dei Beatles, quando Streisand era una presenza dirompente nello show business, un’eccentrica che ce la faceva nonostante difficoltà personali e l’avversione di molti, un simbolo di diversità, un’interprete di canzoni d’amore e vendetta. Se suona famigliare, se somiglia alla biografia d’una popstar di questi anni ’20, è perché Barbra Streisand c’è passata prima di loro.
Viene in mente la descrizione che Oriana Fallaci fa di questa Cleopatra di Brooklyn quando la incontra a New York un paio d’anni dopo la registrazione al Bon Soir e ne scrive per l’Europeo. A quel punto Streisand è già famosa. È la star del musical Funny Girl, ha pubblicato tre album, è finita sulla copertina di Time e Life, ha duettato con Judy Garland. È stata alla Casa Bianca dove ha chiesto l’autografo a Kennedy per la madre. «Da quanto canta?», le ha domandato JFK. «Più o meno da quanto lei è presidente». Il ritratto che Fallaci fa della diva è formidabile e forse oggi per la schiettezza sarebbe persino impubblicabile: «Gli occhi sono piccoli, il naso è immenso. Appesantito da una aggressiva gibbosità si attacca direttamente alla fronte e prosegue inesorabile fino alla bocca che, aperta, incute spavento tanto è spaziosa. Le gambe sono lunghe e ossute, il busto è corto e tarchiato, tutto si può dire di lei fuorché sia bella».
Il suo anticonformismo è irritante, scrive Fallaci, la sua maleducazione è feroce. E però è fantastica perché «non assomiglia a nessuno, è incatalogabile come nessuno, e tipi come lei capitano tutt’al più una volta in una generazione: riscattandoci dalla mediocrità, la banalità, la noia nella quale viviamo». Questa piccola ebrea sfacciata, questa show-woman che vive in una casa elegante e volgare con mobili da dentista e letti a baldacchino, questa cantante-orchestra che «canta balla recita come l’enciclopedia del migliore spettacolo», questa donna così buffa e allegra «è brutta e tuttavia bella». E questa proposizione avversativa è fondamentale. Streisand non è «brutta e tuttavia bella» solo perché il talento è sexy, come si usa dire. È perché lei stessa ha contribuito a cambiare l’idea di bellezza accettata nello show business americano. Non con prediche e proclami, ma con la voce e la personalità e tutto il resto.
L’ha spiegato qualche anno fa il giornalista e scrittore Neal Gabler in un libro sull’ebraicità della cantante intitolato Barbra Streisand. Redefining Beauty, Femininity, and Power. Quante chance aveva questa donna ebrea con un marcato accento di Brooklyn, che all’epoca non era la capitale morale dell’hipness ma un posto abitato da immigrati? Quante possibilità aveva questa cenerentola nasuta cresciuta in quel luogo tutto «baseball, noia e alito cattivo» (la sua descrizione di Brooklyn, poi ritrattata) non solo di sfondare, ma di diventare una delle più grandi dive di sempre?
Per Gabler, Streisand «faceva sentire le persone bene con se stesse perché lei per prima sembrava stare bene con se stessa». Non nascondeva la sua ebraicità, né la usava a scopo comico come facevano altri. La rimarcava, anzi, la sbatteva in faccia a chi l’ascoltava e la guardava, trasformando un potenziale svantaggio in un punto di forza. L’ha scritto Paglia: «Di Streisand sorprendeva l’etnicità aggressiva». Il naso che si rifiutava di operare «era sfacciatamente etnico. Era un personaggio rivoluzionario». Il fatto di essere ebrea non l’ha aiutata nemmeno nella negoziazione con la Columbia, nonostante la presenza di un ebreo che la presiedeva, Goddard Lieberson. Era stato lui a dire che Streisand era «troppo speciale» per incidere dischi. E del resto, racconta Shaun Considine nella biografia Barbra Streisand The Woman, The Myth, The Music, Lieberson era un «haute jew» che frequentava gli Stravinsky, i Leonard Bernstein, i Moss Hart. Streisand era una plebea che lo metteva in imbarazzo.
Eppure quella ragazza dai modi eccessivi sarebbe diventata un’icona culturale. Se è accaduto, suggerisce Gabler, non è solo per via del talento, ma anche del modo in cui s’è fatta largo nella psiche collettiva «diventando un’incarnazione dei nostri impulsi profondi. Pare quasi che ci capisca, anzi, addirittura che esprima ciò che siamo». A sentirsi capito, in quel 1962, era «chiunque avesse sperimentato un rifiuto e avesse dovuto lottare per emanciparsi». Era l’entertainer degli emarginati, dei diseredati, degli svantaggiati, dei delusi, degli abbandonati. Dei diversi.
Ascolto il modo in cui Barbra Streisand intrattiene il pubblico al Bon Soir – a un certo punto dice nella nostra lingua che sta imparando l’italiano – e penso che non ci si crede che avesse solo 20 anni. Aveva già tutto: verve (si ride ascoltando il disco), fraseggio fenomenale, intonazione, senso della melodia, espressività. Era evidentemente nata per stare su un palco. Parlando con Fallaci, diceva di non avere complessi, vivaddio. Aggiungeva persino che era preoccupata di non averne a tal punto da voler andare dallo psicanalista – immaginate questa frase oggi, che scandalo e che umiliazione per chi dallo psicanalista ci va sul serio. Non era complessata, giusto un po’ confusa. «Dick Avedon, il fotografo, dice che sono bella. Dice che il mio profilo è greco, eccetera, amen. Cecil Beaton, l’altro fotografo, dice che sono stupenda: la reincarnazione di Cleopatra, eccetera, amen. La maggior parte della gente mi trova bruttissima, gli impresari teatrali ad esempio dicevano sempre no, oh no, proprio no!».
E invece sì, oh sì, decisamente sì. A pochi isolati di distanza dai locali dove Bob Dylan portava il folk nordamericano nella contemporaneità presentandosi fieramente come un anti Sinatra (un anti Sinatra che, si badi, mezzo secolo dopo avrebbe cantato i pezzi del cantante del Jersey, perché a 20 anni certe cose non le capisci, ma a 70 sì), non lontano da dove John Coltrane scriveva lettere a Dio sotto forma di jazz, Streisand diventava un modello per quelle che si sentivano dire «no, oh no, proprio no». Rompeva soffitti di cristallo, convenzioni, tutto. Apriva la strada alle popstar contemporanee, all’idea che la diversità è bellezza, non solo nei corpi, ma anche nelle voci, negli stili, nelle idee. Sfacciata com’era, si prendeva il posto che pensava di meritare nel mondo dello spettacolo, senza aspettare che qualcuno glielo concedesse perché ne aveva diritto o perché era nel giusto. Nel farlo, scrive Gabler, sfidava l’ordine morale, sociale, sessuale e culturale. Un poco esagera quando aggiunge che «era una minaccia per l’America tradizionale», ma è vero che rappresentava idee non convenzionali di bellezza, femminilità, decoro e persino potere. «Stava mostrando un altro modo di essere americani».
E chissà che pensava lei, Barbra Streisand, quella sera al Bon Soir mentre tirava fuori una versione spettacolare e spietata nella sua bellezza di Cry Me a River, deliziando il pubblico e i musicisti, tant’è che uno di loro alla fine dell’esecuzione dice «andiamo a casa», forse perché fare di meglio era impossibile. Chissà che pensava Streisand che da piccola ripeteva a sé stessa «diventerò una diva e avrò tanti sofà» perché in casa di sofà non ce n’erano. Educata dalla madre a considerare il cibo la massima ricchezza, misurava l’apprezzamento non col fragore degli applausi (oggi diremmo col numero di like), ma in modo decisamente più prosaico. E dava una lezione a noi che ci troviamo sessant’anni dopo a calcolare troppe cose in termini di consenso impalpabile ed evanescente. «Quando la gente mi applaude» diceva all’Europeo «non so come reagire, che fare. Se mi gettassero soldi, roba da mangiare, non so, polli arrosto, bistecche, uova sode, biscotti, allora sì capirei che gli sono piaciuta. Ma quel buffo rumore di mani, mi spiego, che me ne faccio: lo spendo, lo mangio?».