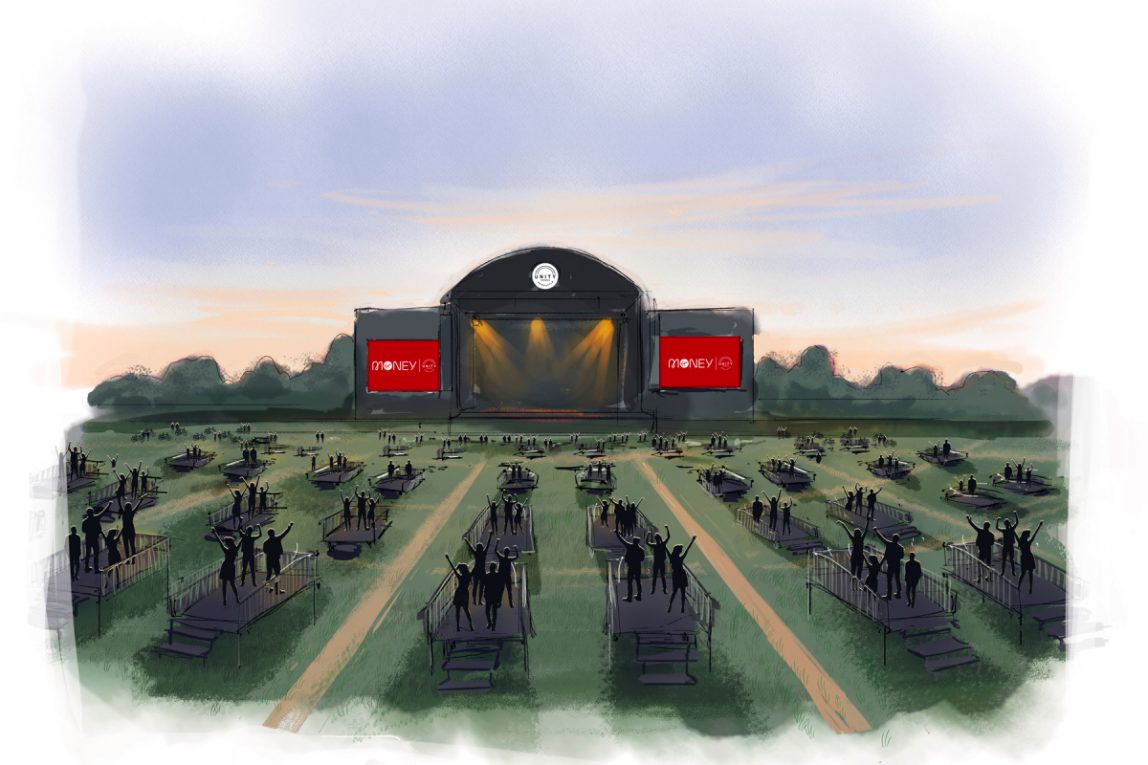Non è certo un locale qualunque, il Cavern Club di Liverpool. Non ci si può fidare della calma apparente, del moderato afflusso all’arrivo, quando di fronte al palco gironzola uno sparuto drappello di spettatori, tanto meno della poco plausibile sobrietà di costoro. E infatti dura poco.
Ci si inizia a riscaldare quando si presenta on stage la band di apertura, guidata da Saint Leonard, che dei Libertines è un po’ un figlioccio artistico. Bello, altero, si direbbe un Duca Bianco se non fosse per quella patacca verdognola sulla manica sinistra a stemperare il candore della giacca aperta sul petto nudo. Poco dopo lo si incrocerà in zona bancone, rinserrato in un bomberino da dopolavoro, invecchiato di qualche anno. La security allontana un tizio in prima fila, anche in questo caso senza apparente motivo, come fanno certi arbitri che sventolano il giallo per prendere in pugno la partita sin dai primi minuti (in serie A, il Var probabilmente revocherebbe l’espulsione, ma qui siamo in Premier League).
È questo il clima che i Libertines di Peter Doherty e Carl Barât hanno fortemente voluto per la prima parte del loro Albion Tour (sì, la loro fissa albionica non sembra voler recedere di un millimetro): una serie di piccoli club inglesi per avvicinarsi all’uscita di All Quiet on the Eastern Esplanade, che il prossimo 8 marzo interromperà un silenzio discografico durato nove anni. Qui a Liverpool la coppia di frontman ha addirittura suonato in due locali in poche ore, stile Maestro Canello (nel tardo pomeriggio erano al Jacaranda Baltic in versione acustica). «Un ritorno alle nostre radici», è il loro auspicio, «in questi piccoli club che sanno di sudore, dove possiamo vedere il bianco degli occhi degli spettatori».
Saranno accontentati su tutta la linea. Sin dalla pennata d’attacco di Run Run Run, primo singolo estratto dall’album in arrivo, il cui ritornello è già pronto per il sing-along: “Faster than the past!” urlano Pete e Carl all’unisono con il pubblico del Cavern. Che nel frattempo si è decuplicato, iniziando a erogare in sala quel retrogusto di ghiandole sudoripare che tanto mancava alla band londinese giunta nel North West; con aggiunta di birra, volata via dai bicchieri già a metà del primo ritornello. Principalmente addosso a chi scrive, si vorrebbe dire (ma è forse un’impressione soggettiva).
Il nuovo pezzo parla del terrore di rimanere intrappolati cercando di rivivere costantemente il proprio passato. Così Barât cerca di esorcizzare l’atmosfera da Good Old Days – brano assente dalla scaletta di stasera – che rischia di far pendere troppo nettamente il piatto della bilancia dalla parte dei classici. Manco a farlo apposta, alla sinistra del palco, verso l’ingresso della sala, una delle tante teche dello storico club raccoglie foto e reliquie di una loro serata di vent’anni fa: più o meno l’epoca di Can’t Stand Me Now, che segue senza soluzione di continuità mentre già lo staff inizia a disseminare a terra i primi segnali Caution Wet Floor.
È solo un po’ di nostalgia, e si torna subito al nuovo repertorio con Mustang, prima assoluta per un brano vigorosamente sostenuto dal basso di John Hassall e dal charleston del buon Gary Powell, la cui tuta gialla tuttavia fa a botte con la giacca di pelle di Carl e con l’impermeabile di Pete Doherty, che a sua volta farebbe a botte con qualsiasi altra cosa (l’impermeabile, non lui; almeno credo).
La situazione, considerata la densità nei pochi metri quadri di fronte al palco, non è quella più adatta per prendere appunti sul taccuino man mano che scorre la scaletta, ma possiamo convenire con buona sicurezza che tutta la prima parte della breve tracklist sia un pendolo tra 2024 e primissimi anni Duemila; infatti Music When the Lights Go Out reclama puntualmente il suo dazio di cori prima di cedere nuovamente il passo agli inediti. È la volta di Shiver, che Doherty racconta essere stata scritta mentre la band si trovava in Giamaica per le registrazioni, guardando da lì il funerale della regina Elisabetta, “not really knowing what we were feeling”. Ora c’è qualche coro in meno, su versi come “The day they boxed all Lizzy away…”; non è dato sapere — né è il caso di lanciarsi in un sondaggio — se per pudore monarchico o perché non si è avuto ancora il tempo di mandare a memoria un brano che, dal punto di vista sonoro, odora di fine anni ’90 da diverse miglia.
Pete e Carl si lanciano in qualche altro momento acustico con le loro Gibson gemelle, e in generale dimostrano buona forma e più che accettabile simbiosi. Ne hanno parlato spesso, durante le ultime interviste, di questa ritrovata affinità favorita dalla sobrietà di Doherty, che pure se lo porta addosso, qualche segno dei vecchi eccessi.
Proseguendo con la spola tra passato remoto e futuro prossimo, la band si avvia verso la fine della scaletta con Vertigo, pezzo di apertura dell’album di debutto Up the Bracket (2002), il cui gradimento è ormai indicizzabile in litri di birra versata a terra. Neanche il tempo di chiedere il bis, che dallo stesso album partono i due pezzi finali, Death on the Stairs e Tell the King. Il primo è tra i preferiti degli stessi Libertines, col suo punk revival nobilitato da uno dei testi più riusciti della loro storia. Il secondo, che suonato in versione molto più energica rispetto al disco riecheggia ancor più gli Stokes, stavolta non viene introdotto dal rodato dialogo tra pubblico che reclama il titolo e Doherty che risponde: «No, you tell the fucking king!». Anche perché a quest’ora non c’è da fidarsi a replicare così schiettamente.
It’s time to go. Per guadagnare l’uscita – realizzando d’improvviso tutto il senso del verbo guadagnare – bisogna attraversare metri cubi di corpi ancora mossi dal ritmo ma allo stesso tempo ben saldi a difendere la loro posizione. La collisione con uno di questi, e l’incauto incrocio di sguardi che ne segue, rischia di diventare un serio impedimento alla stesura di questo articolo. Fortunatamente, proseguendo oltre il mixer verso il fondo sala, si raggiunge l’altro spazio del Cavern, quello ancor più storico e musealizzato.
E lì, ignaro di tutto nella sua bolla acustica e temporale, un fricchettone da campionario sta cantando Penny Lane, voce e chitarra, mentre un anziano al bancone chiede: stanno ancora suonando di là?