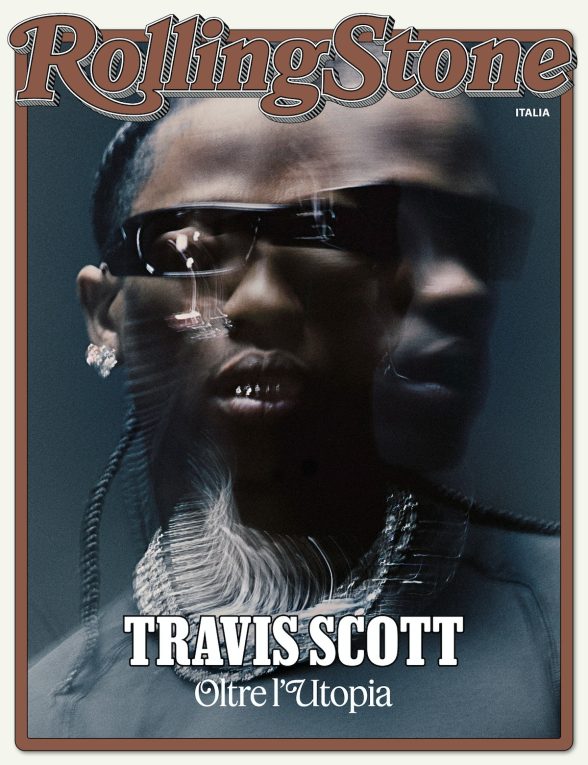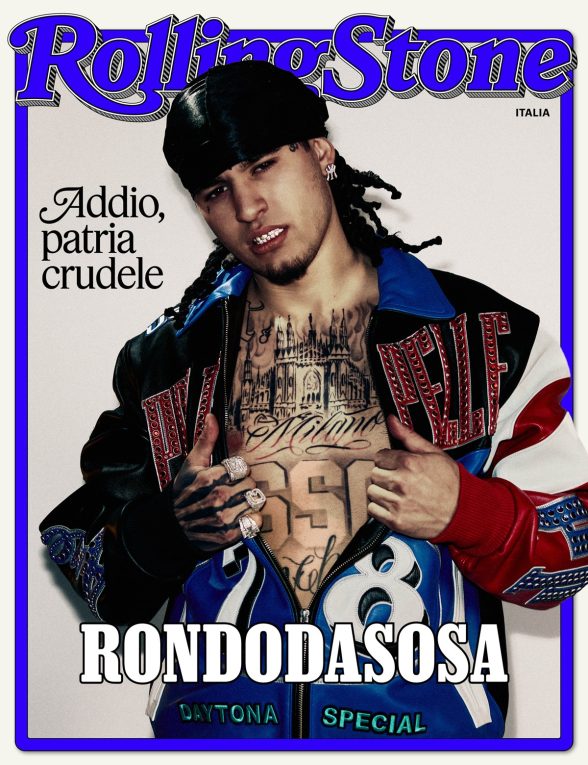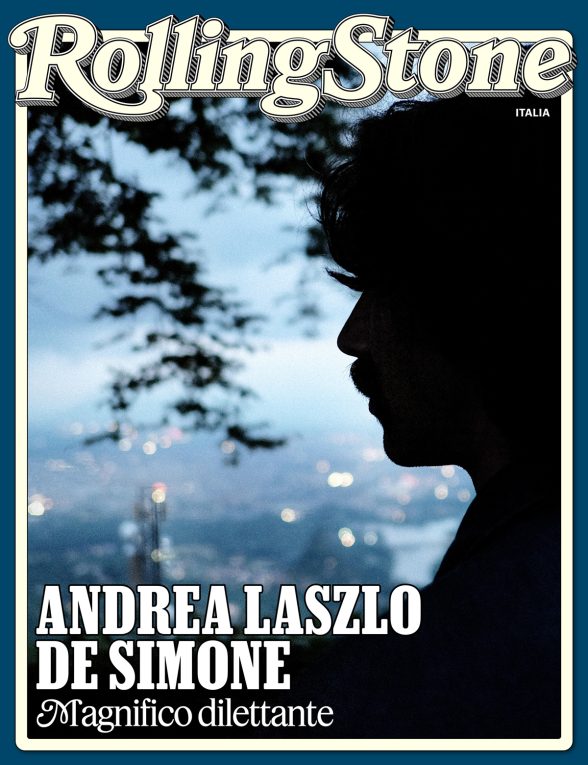La loro vita stava per diventare davvero una fantasia e del resto era più o meno quello il piano. Alla fine degli anni ’60 Roger Taylor e Freddie Bulsara se ne stavano sdraiati sul pavimento, con la testa dell’uno contro quella dell’altro, e si perdevano nei pensieri del futuro ascoltando Electric Ladyland. Magari si smezzavano una bottiglia di vino, niente di più forte. «A me e a Fred non veniva di fumare erba», dice Taylor oggi, più di cinquant’anni dopo. «Mi faceva sentire la testa infuocata, non m’è mai andata a genio».
Prima ancora che Bulsara entrasse a far parte dei futuri Queen col nome di Freddie Mercury, lui e Taylor condividevano la passione per i velluti, Jimi Hendrix e le grandi ambizioni. «Volevamo essere i migliori, volevamo avere successo», dice il batterista dei Queen seduto nel grande salotto della sua residenza del XVIII secolo nella campagna britannica, circondata da 48 acri di bosco. Forse non sarebbe qui senza la canzone di cui stiamo parlando, il momento in cui i Queen si sono spinti là dove nessun’altra band aveva osato andare, e ancora oltre, per poi aggiungerci qualche “Galileo”. Stiamo parlando di Bohemian Rhapsody, che sta per celebrare il cinquantesimo anniversario.
Trasmessa per la prima volta dalla radio britannica nell’ottobre 1975 e pubblicata su un 45 giri alla fine di quel mese, è la canzone del Ventesimo secolo più ascoltata in streaming avendo oltre 2,9 miliardi di riproduzioni solo su Spotify. «Incredibile», dice Brian May quando lo vado a trovare il giorno dopo. «Bohemian Rhapsody non diventa mai vecchia, vero? È la magia che ci permette di non invecchiare». Si ferma un attimo e si corregge: «È la musica che non invecchia».
I numeri parlano chiaro: la canzone più famosa dei Queen è sulla buona strada per diventare il manufatto più duraturo dell’età dell’oro del rock, con tanto di Figaro, Belzebù e tutto il resto. Bohemian Rhapsody è il reperto di cinque minuti e 54 secondi di un’epoca breve in cui i musicisti potevano permettersi di passare settimane in studio a mettere una sovraincisione sull’altra, gli ingegneri del suono tagliavano i nastri coi rasoi, le band si spingevano oltre la forma-canzone tradizionale e le consuete tecniche di registrazione. Un’epoca, dice in modo caustico Taylor, in cui «bisognava essere molto bravi con gli strumenti, cosa che oggi non è un requisito necessario». Mentre i Queen faticavano su Rhapsody e sul resto del loro quarto album A Night at the Opera, il mondo non si fermava, anzi. Due settimane prima dell’uscita dell’album, i Sex Pistols debuttavano a Londra.
La canzone è anche, e questo è ovvio, figlia del genio, dell’ironia e del dolore di Freddie Mercury, morto a soli 45 anni per complicazioni legate all’AIDS nel 1991 . «Ci sono campi in cui ci piace esagerare», diceva. «È ciò che ci mantiene vivi, tesoro… Probabilmente siamo la band più pacchiana del mondo».
In una piacevole mattina di fine primavera le porte laterali del salone di Taylor sono spalancate sul giardino. Da qualche parte là fuori, un po’ defilata, c’è una statua in vetroresina alta sei metri che raffigura Mercury e che è stata usata per pubblicizzare il musical We Will Rock You. Taylor è certo che l’amico avrebbe trovato esilarante la collocazione. Da qualche altra parte in giardino c’è anche il gong da 60 pollici che Taylor percuote negli ultimi secondi di Rhapsody. «Siccome i Led Zeppelin avevano un gong», dice con un sorrisetto, «noi ne abbiamo preso uno molto più grande. In sostanza, era una gara patetica a chi ce l’aveva più grosso».
I capelli un tempo biondi sono ora argentati, tagliati corti e abbinati alla barba. È vestito come un magnate in pensione, pantaloni chino slim e camicia grigia. Sul pianoforte a coda c’è un foglio con su appuntata una progressione di accordi in fase di lavorazione. Dietro di lui ci sono libri sui Beatles e Bob Dylan.

Foto: Queen Productions Ltd/Universal
Nel 1969, Taylor suonava la batteria negli Smile con May, un tipo brillante, meticoloso e riccioluto, pure lui fan di Hendrix. Bulsara cantava invece in una band durata poco chiamata Ibex. I membri dei due gruppi vivevano ammassati in alcuni appartamenti londinesi, con Bulsara che cercava di entrare negli Smile. Accettarlo non era scontato. «La verità» dice Taylor «è che all’epoca non era un gran cantante. Cantava sì in modo potente, ma senza controllo».
Sullo specchio della camera Freddie teneva una foto di Hendrix, che aveva visto almeno 14 volte in concerto. Hendrix era «tutto ciò che volevo essere», ha detto. Rappresentava pure un’eccezione in un panorama di rock star bianche, una barriera che avrebbe infranto anche Mercury. Voleva disperatamente diventare qualcosa di simile, cancellare il ragazzo goffo, timido e coi dentoni sporgenti che era stato. Parlava di rado delle sue origini peculiari: un’infanzia di relativo privilegio nella colonia britannica di Zanzibar, coi genitori Parsi che seguivano l’antica fede dello Zoroastrismo (che non è mai stata molto aperta verso la diversità sessuale). Dagli 8 ai 16 anni di età aveva frequentato un prestigioso collegio in India. Lui e la famiglia si erano rifugiati nel Regno Unito nel 1964, dopo la rivoluzione che a Zanzibar aveva rovesciato il dominio britannico.
Quando all’inizio degli anni ’70 il cantante Tim Staffell ha lasciato gli Smile, Freddie è entrato a far parte ufficialmente della band. L’ha ribattezzata Queen, con un certo imbarazzo iniziale da parte di Taylor e May. Il nome voleva evocare qualcosa di regale, insisteva Mercury, non sempre in modo convincente. Del resto, se oggi la sua sessualità è evidente, all’epoca lo era molto meno, forse anche per lui. Mercury ha conosciuto nel 1970 Mary Austin, la sua storica fidanzata e di certo non la prima donna che i compagni hanno visto al suo fianco. Al massimo, ha raccontato May, avevano un «leggero sospetto» sulla sessualità dell’amico.
Nell’estate di quell’anno Freddie ha cambiato il cognome, ispirato a un verso su “Mother Mercury” contenuto in una canzone che uscirà nel debutto dei Queen, My Fairy King. «In un certo senso si è creato da sé», dice Taylor. «Ha semplicemente forgiato questo soggetto, Freddie Mercury, apparentemente dal nulla».
Lo straordinario impasto vocale che ha raggiunto l’apice in Rhapsody è nato grazie all’eco prodotto nelle grotte sulla costa inglese durante le frequenti visite in Cornovaglia, terra natale di Taylor. Già prima che se ne andasse Staffell, May, Mercury e Taylor avevano iniziato a cantare lì impegnandosi in armonie a tre voci. «Entravamo nelle grotte e ci mettevamo a cantare qualsiasi cosa», ricorda May. «Ci perdevamo nel suono, in quell’intreccio meraviglioso di armonie. Eravamo Freddie e io, in particolare, a condividere questa passione».
La formazione definitiva dei Queen ha preso forma l’anno dopo con l’arrivo del bassista John Deacon. A quel punto sapevano già il tipo di musica che volevano fare. «La nostra visione per i Queen» dice May «consisteva in una musica strmentale heavy, potente ed emozionante su cui aggiungere melodie e armonie meravigliose. Questo cercavamo». Quando May è stato al primo concerto dei giganti del prog Yes e ha sentito il loro mix di riff complessi e armonie ispirate a Crosby, Stills & Nash ha pensato: «Beh, questo ci si avvicina».
Nel dicembre 1969, May, Mercury e Taylor sono andati a vedere gli Who che facevano il loro nuovo album Tommy al London Coliseum, un altro passo nell’immaginare cosa avrebbero dovuto fare in futuro: magari non rock operistico, ma qualcosa di simile a un’opera rock travolgente e bombastica. Taylor pensa ancora che la versione in studio di Tommy fosse sottoprodotta, meno imponente rispetto alle versioni dal vivo che portavano in giro gli Who, una critica che nessuno ha mai pensato di fare ai Queen (secondo May, sono stati invece i dischi precedenti degli Who a influenzarli: «Tommy è venuto un po’ più tardi rispetto a quando abbiamo formato il nostro gusto»).
May e Taylor sono stato colpiti anche dall’insieme ultraterreno di voci in un altro pezzo uscito quell’anno, Because dei Beatles. «Ci ha ipnotizzati», racconta il chitarrista, «avevo i brividi lungo la schiena. Era il pezzo di armonia più pura e audace che avessimo ascoltato». Per creare quell’effetto corale, i Beatles avevano sovrapposto strati delle loro voci, una tecnica che May, Taylor e Mercury hanno poi spinto ancora più in là. Ma i Queen sono stati influenzati anche da pezzi vecchi dei Beatles, come This Boy del 1964 e prima ancora dagli idoli dei Fab Four come Buddy Holly e gli Everly Brothers. «Tutto quello che facevano i Beatles ci influenzava», dice May. «In un certo senso siamo partiti dal punto in cui loro hanno lasciato».
Avranno anche avuto 50 anni per pensarci, eppure May e Taylor non hanno ancora capito con precisione di che diavolo canti Mercury in Bohemian Rhapsody. «Purtroppo non glielo possiamo chiedere», dice il batterista. I Queen non hanno mai discusso tra di loro dei testi e Mercury non era certo incline a dare spiegazioni. «La gente mi chiede ancora di cosa parla Bohemian Rhapsody», ha detto molti anni dopo, «e io rispondo che non lo so». Qualsiasi rivelazione, suggeriva, avrebbe segnato «la fine del mito, rovinerebbe il mistero che la gente si è fatta in testa». Il suo amico Kenny Everett, il dj che per primo ha passato la canzone, ha detto che Mercury l’ha liquidata in privato come «nonsense in rima».
John Reid, manager dei Queen da metà del 1975, ovvero poco prima delle session di A Night at the Opera, era apertamente gay e in quel periodo frequentava Elton John, che era anche suo cliente. Durante una cena ha fatto riferimento alla propria sessualità e Mercury ha fatto coming out in tutta naturalezza. Viveva ancora con Mary Austin, ma passava le serate al Rods, il club gay dove ha incontrato un giovane di nome David Minns con cui ha intrecciato una relazione. Reid è convinto che una delle tante teorie che ci sono su Bohemian Rhapsody sia corretta, ovvero che la canzone parli fondamentalmente di Mercury che affronta la sua identità sessuale. Una frase come “Gotta leave you all behind and face the truth” (“Devo lasciarvi tutti alle spalle e guardare in faccia la verità”) sembra confermare questa lettura. «Quella è la chiave», dice Reid, «un po’ di dubbio su di sé e il fatto che non avrebbe mai potuto essere completamente aperto coi genitori».
Come ha scritto Minns, Mercury era tormentato dal senso di colpa riguardo la sua vita passata. Sono sentimenti che effettivamente Rhapsody sembra esprimere. La canzone del resto è in gran parte rivolta a una “Mama”. È facile interpretare l’uomo ucciso nelle prime righe come un simbolo della fine delle pose etero di Mercury, anche se a quanto pare ha iniziato a scrivere quel verso alla fine degli anni ’60. Secondo Reid, «stava dicendo addio a quella vita» (Mercury a volte si descriveva come bisessuale e non come gay e secondo un nuovo libro avrebbe avuto una figlia “segreta” attorno al 1976, una storia a cui Reid però non crede affatto, né lo convince l’idea che Mercury abbia potuto tenerla nascosta: «Tutta questa storia è ridicola, la gente nel suo giro sapeva cosa faceva Freddie», dice, mentre Taylor e May hanno rifiutato di rilasciare un commento sul libro).

Un tè alla Ridge Farm, luglio 1975: Deacon, May, Mercury, Taylor. Foto: Watal Asanuma/Shinko Music/Getty Images
Taylor chiama «sovrainterpretazione» le teorie su Bohemian Rhapsody. «Stava semplicmenete scrivendo una canzone intensa e riflessiva. E poi abbiamo messo tutte quelle sezioni incredibilmente assurde nel mezzo. Molti si chiedono qual è il significato segreto. Non credo ce ne sia uno. Quello che c’è è chiaro, il resto è nonsense nello stile di Lewis Carroll. “Belzebù ha messo un diavolo da parte per me”. Sono immagini belle, ma non mi spingerei oltre» («Non significa che studi demonologia o roba del genere», ha detto una volta Mercury, «mi piace semplicemente la parola Belzebù. È bella, vero?»).
Nemmneo May, che parla dell’amico usando il tempo presente, ha grandi certezze. «Sta creando qualcosa di bello nella sua testa e usa tutto ciò che ha dentro. Usa il dolore, la frustrazione, la confusione. Non è certo letterale. Non è una cosa conscia. Anche My Fairy King viene fuori dalla sua fantasia interiore no? È oscuro nello stesso modo. Freddie non sente il bisogno di spiegarsi o di essere diretto. A volte ama semplicemente il modo in cui suona la voce quando canta quelle sillabe. È tutto mischiato in una specie di gioia creativa. È così che vedo Freddie».
Nella sezione centrale sembra ci sia in corso una sorta di battaglia, con l’eroe che mette in gioco corpo e anima e ha una “mostruosità” alle calcagna. I testi intensi sono almeno in parte smorzati dalla vocalità giocosa di Mercury, dai suoi intermezzi operistici assurdi e allegri. Da una bozza manoscritta della canzone recentemente battuta all’asta, scarabocchiata a matita sulla carta di una compagnia aerea, si intuisce che “scaramouche”, “Figaro”, “Galileo”, “magnifico” e “fandango” derivano dalla ricerca di parole italianeggianti o associate all’opera, più per il suono e la rima che per il significato. Mercury ha annotato anche altre opzioni come “belladonna”, “castanetta” e “barcaraola” (probabilmente intendeva “barcarola”). Senza quel contrappunto giocoso forse non si sarebbe permesso di aprire uno scorcio nell’abisso nel passaggio che lo precede e che sfugge a molti: «A volte vorrei non essere nato».
Mercury affermava con orgoglio d’aver fatto un po’ di ricerche sull’opera per scrivere la canzone, senza però entrare nei dettagli. «Bohemian Rhapsody non è venuta fuori dal nulla», diceva. Grazie alle lezioni di piano prese da bambino conosceva la musica classica e anche il titolo della canzone fa riferimento a quel mondo. I fogli battuti all’asta mostrano che aveva preso in considerazione e poi cancellato il titolo scherzoso Mongolian Rhapsody, quasi certamente un rifermento giocoso alle Hungarian Rhapsodies di Franz Liszt (quando Bugs Bunny in frac si siede al pianoforte per eseguire la Rapsodia ungherese n. 2 nel leggendario cortometraggio del 1946 Rhapsody Rabbit, inserisce un riferimento al personaggio di un’opera di Mozart: Figaro).

Freddie Mercury, Ridge Farm, luglio 1975. Foto: Watal Asanuma/Shinko Music/Getty Images
Mercury era consapevole dell’unicità di quel che stava ideando: «Se ascolti bene la parte operistica, non somiglia a nient’altro ed è precisamente quel che vogliamo. Ma non ci prefiggiamo di essere eccessivi, è una cosa che abbiamo dentro». A momenti – magnifico! – la canzone diventa comica con un senso del camp autoironico che non ha, per fare un esempio, un pezzo solenne come Stairway to Heaven. «Il senso dell’umorismo in tutto ciò che fai è salutare», dice May. «E comunque non significa che non sei serio».
«Pensavamo: un po’ è ridicola, quindi avanti così», aggiunge Taylor. «Ci siamo divertiti col suo carattere assurdo».
Brian May aveva in testa un capolavoro, ma non riusciva a farlo uscire come voleva. A metà del 1975 ha iniziato a scrivere un lungo viaggio prog dalla struttura intricata, effetti vocali stravaganti e picchi esplosivi. E non era Bohemian Rhapsody. Nelle prime fasi di lavorazione di A Night at the Opera, i Queen si sono trasferiti a Ridge Farm, a un’ora da Londra, per concentrarsi sulla scrittura. Si mettevano alle spalle un contratto di management che li aveva lasciati poveri e indebitati, nonostante il successo di Killer Queen del 1974.
«Eravamo incredibilmente poveri», dice May. «La gente pensava che vivessimo nel lusso e invece non avevamo nulla». Racconta che l’ex manager della band Norman Sheffield cavillava sull’acquisto di nuove bacchette di Taylor e si rifiutava categoricamente di comprare a Mercury un nuovo pianoforte. Reid, il nuovo manager, ha convinto la EMI ad anticipare il denaro necessario affinché la band potesse creare musica per la prima volta senza porsi limiti. I Queen si sarebbero occupati della musica, lui dei vecchi contratti. Nel suo memoir, Sheffield sosteneva che la band stesse per ricevere comunque un compenso sostanzioso e che se n’era andato perché Mercury era impaziente. Il cantante lo ha attaccato in Death on Two Legs, su A Night at the Opera: “Mi succhi il sangue come una sanguisuga”. Il manager ha intentato causa per diffamazione, rapidamente risolta.

Brian May, Ridge Farm, luglio 1975. Foto: Watal Asanuma/Shinko Music/Getty Images
A Ridge Farm, May continuava a lavorare affinché Prophet’s Song fosse all’altezza delle sue ambizioni. Era un avvertimento rivolto agli “abitanti della terra”, ispirato a un sogno apocalittico, che alla fine durerà due minuti più di Rhapsody. May era reduce da un’ulcera, si sentiva come bloccato, né aiutava il fatto che uno dei suoi compagni in quel momento aveva molta più fortuna di lui. I Queen sono infatti una delle poche grandi rock band in cui ogni singolo membro ha scritto hit, non senza qualche conflitto. «Eravamo ovviamente molto competitivi tra di noi», dice May in modo pacato. «Sentivo Freddie che batteva sul piano le note di Bohemian Rhapsody. Eravamo tutti in stanze diverse a scrivere i nostri pezzi, ma lui aveva il pianoforte in cortile, all’aperto, e lo sentivo picchiare sempre più forte, il pezzo diventava sempre più complesso, sempre più frenetico. E io pensavo: ahhhhh, ho questa visione per Prophet’s Song, ma non riesco a darle vita. È stata una fase difficile per me».
May me lo racconta in una dépendance simile a un garage nella sua tenuta di campagna, non lontano da quella di Taylor. È seduto a un tavolo di legno piuttosto semplice, in una stanzetta che, giura, è più grande dell’appartamento in cui viveva con la sua ragazza poco prima di registrare A Night at the Opera. Alle pareti ci sono foto a tema astronomico e targhe che celebrano i traguardi di vendita di We Will Rock You e del Greatest Hits del gruppo. I capelli grigi ma sempre ricci e folti sono bagnati per via di una nuotata mattutina. «Ho avuto alcuni problemi fisici», dice alludendo senza enfasi alcuna all’ictus che lo ha colpito ad agosto 2024 e che ha temporaneamente compromesso il suo modo di suonare. «A quanto dicono fare esercizio fa un’enorme differenza».
Sul giubbotto di May c’è una spilla che commemora il sorvolo di Plutone da parte della sonda spaziale New Horizons nel 2015, a cui – incredibile, ma vero – ha contribuito con l’analisi dei dati. Nel 2007 ha infatti completato il dottorato in astrofisica, decenni dopo aver scandalizzato la famiglia per aver abbandonato gli studi per dedicarsi a tempo pieno ai Queen. «Mio padre mi disse che stavo buttando via la mia vita». E la pensava ancora così nel 1975, aggiungendo una certa pressione alla realizzazione di A Night at the Opera. Per dirla con Taylor, «era il momento dell’o la va o la spacca».
May s’illumina quando gli confesso il mio amore per Prophet’s Song, che in effetti ha sempre avuto estimatori incluso Mercury che l’ha citato come possibile singolo. All’epoca Rolling Stone aveva un rapporto complicato con i Queen – nel 1979 il brillante Dave Marsh è arrivato a definirli «la prima vera band fascista del rock», col senno di poi un’esagerazione sconcertante a proposito di We Will Rock You – ma la nostra recensione di A Night at the Opera era positiva. Curiosamente, non menzionava per niente Bohemian Rhapsody. Citava però Prophet’s Song quale miglior brano dell’album. «È tutto un altro mondo, quella canzone» dice May. «Non ha mai ricevuto grandi attenzioni per via del colosso che le stava accanto».

May, Taylor e Mercury registrano ‘A Night at the Opera’ allo Scorpio Sound, 1976. Foto: Watal Asanuma/Shinko Music/Getty Images
Mentre orecchiava la nascita di Bohemian Rhapsody, May non poteva fare a meno di sviare l’attenzione dal suo pezzo per rivolgerla a quello di Mercury. Nella sua testa iniziava a immaginare orchestrazioni e assoli di chitarra. «L’idea per la parte strumentale di Rhapsody cresceva mentre ascoltavo Freddie che sviluppava la canzone. Non pensava in modo lineare e per me era più facile suonare sulle sue canzoni che sulle mie, perché erano particolarmente stimolanti».
Il riff pesante e sinuoso dopo la sezione operistica, quello che avrebbe regalato alla canzone una delle sue tante seconde vite quando Mike Myers e Dana Carvey ci hanno fatto headbanging in Fusi di testa nel 1992, è un’invenzione di Mercury. A May non viene naturale suonarlo. «Bohemian Rhapsody non è mai facile da suonare, nemmeno dopo tutti questi anni», ammette. «Devo restare vigile, altrimenti deraglio».
Per dare il via alle registrazioni i Queen si sono poi trasferiti ai Rockfield Studios, in un’altra fattoria, ma in Galles. Le tracce base di batteria, basso, pianoforte sono state messe giù rapidamente. Mercury ha inserito nelle parti di pianoforte le melodie operistiche, mantenendo il carattere percussivo. «Dimenticate i costumi ridicoli e lo showman», dice Taylor. «Prima di tutto, Mercury era un musicista fuori dal comune. Solo che questo aspetto veniva completamente oscurato dal suo ruolo di frontman sopra le righe».
La band è poi passata da uno studio all’altro a Londra, una scelta che ha contribuito ad alimentare il mito secondo cui A Night at the Opera sarebbe l’album più costoso mai realizzato. Reid, che lo sa con certezza, smentisce: «Non c’è stato alcuno spreco. Non buttavano via i soldi… Sono sicuro che i Rolling Stones hanno speso molto di più».
Per fortuna dei Queen, negli studi non si pagava in base al numero di overdub. «Con le nostre tre voci abbiamo ricreato l’effetto di un coro di 160-200 persone», ha detto Mercury, che in qualche modo aveva in testa tutto l’arrangiamento e si era annotato al massimo qualche parte armonica. Hanno lavorato sulla sola sezione operistica per tre settimane di fila, weekend compresi, col produttore Roy Thomas Baker (scomparso all’inizio di quest’anno) e con l’ingegnere del suono Mike Stone, anch’egli poi venuto a mancare. «Presente le parti cantate solo in certi punti e che poi scompaiono?», dice Gary Langan, assistente ingegnere alle session. «Per me è inconcepibile riuscire a tenere tutto quanto in testa».
«Sembrava non finire mai», racconta Taylor. «Si era deciso che tutti e tre dovessimo cantare ogni parte per dare al suono spessore e corpo». Le eccezioni, come mostra anche il biopic Bohemian Rhapsody, erano i “Galilei” più acuti che solo Taylor riusciva a gestire. Il metodo ha portato il batterista a fare una sfuriata. Secondo Langan, la scena nel film è addirittura ridimensionata. «Ha perso davvero la testa» racconta. «Era furioso, ben oltre quello che si vede nel film».
A parte questo, i momenti di vera tensione riguardavano soprattutto l’eccessiva lunghezza del brano rispetto a un singolo tradizionale. «Fred difendeva a spada tratta i sei minuti di durata, naturalmente», ricorda Langan. «E una parte della band che diceva: “Sai cosa, Fred? Forse stavolta hai esagerato”». Taylor ricorda che Deacon ha tentato di accorciare il brano portando una versiona tagliata che però non ha convinto gli altri.
La band temeva la reazione della casa discografica, ma a differenza della scena del film con la comparsata di Mike Myers nei panni di un dirigente sprezzante, non c’è stato alcun confronto. «C’erano due o tre addetti alla promozione che dicevano che secondo loro era troppo lunga», racconta Reid. «Alla fine però hanno accettato la nostra versione». Alcune delle obiezioni più forti, in realtà, sono arrivate da Elton John: «Disse: “Ma siete fuori di testa? Non sarà mai una hit. È troppo lunga!”. Era categorico».
L’ultima innovazione è stata girare un videoclip per la canzone, una mossa rara nel 1975. Ci hanno lavorato solo quattro ore agli Elstree Studios, gli stessi in cui un anno più tardi è stata filmata una buona parte di Star Wars. Ancora una volta, Taylor non era particolarmente felice: «Dovevo stare a torso nudo e cosparso di olio per bambini. Ed era tipo l’una e mezza di notte».

I Queen alla Ridge Farm nel luglio 1975. Foto: Watal Asanuma/Shinko Music/Getty Images
May ha registrato le parti di chitarra che sono state poi sovrapposte con la Red Special, lo strumento che aveva costruito da adolescente insieme al padre, usando legno proveniente da un antico camino. Dopo l’intervista, mi porta nel suo home studio e gli chiedo della chitarra. «Vuoi vederla?», dice e manda un assistente a prenderla. Pochi minuti dopo arriva: May pizzica qualche accordo e intanto parla dell’influenza di Pete Townshend degli Who. «È una vecchia e buona amica». Me la mette fra le mani. È pesante, fatta di legno denso ed è carica di storia, ma trovo il coraggio di suonare le prime note dell’assolo di Bohemian Rhapsody, sentendo le dita posarsi sugli stessi punti della tastiera dove le ha messe May. Lui alza le sopracciglia e ride: «Ah, bene» dice. «Potrebbe funzionare».
Dal 2011 i Queen hanno girato il mondo più volte con Adam Lambert alla voce. E hanno una buona notizia per i fan. «Non credo che la band sia finita», dice Taylor. «Non ci sarà un tour d’addio o qualcosa del genere perché in realtà non lo è mai, no?». Non hanno ancora pubblicato nuova musica dei Queen con Lambert, ma May dice che l’idea «è sempre presente. Non molti lo sanno, ma siamo stati in studio con Adam a provare delle cose. Finora non si è concretizzato nulla. Alcune cose sono destinate a concretizzarsi, altre no».
May è stanco della vita on the road, ma vuole ancora esibirsi. «Ho fatto 50 anni di tournée e una parte di me pensa che può bastare così. Non mi piace l’idea di svegliarmi in una camera d’albergo e sentirmi intrappolato. Di recente sono successe cose a casa, alla mia famiglia, ero via e non potevo tornare. Mi ha toccato nel profondo questa cosa, mi ha fatto pensare che non so se voglio fare ancora questa vita. Ho la sensazione di aver rinunciato troppe volte alla mia libertà. Perciò al momento non voglio più fare tournée vere e proprie. Però voglio comunque suonare dal vivo. Voglio ancora innovare».
In quest’ottica, May ha in mente una residency dei Queen allo Sphere di Las Vegas. È rimasto impressionato dagli schermi a 360 gradi e dalle altre innovazioni tecnologiche quando ci ha visto gli Eagles. «Sono molto interessato alla Sphere. Ha messo in moto dei pensieri. Ero lì a guardare gli Eagles e mi dicevo: dovremmo farlo anche noi, le cose che potremmo portare qui sarebbero strepitose. Quindi sì, mi piacerebbe. Ne stiamo parlando».
Assente ancora una volta da queste conversazioni è John Deacon. Da sempre il più riservato dei Queen, si è ritirato a vita privata dopo la morte di Mercury. Non rilascia interviste da decenni e non parla per niente coi suoi compagni di band, nemmeno di cose private. «Per me e per Roger è dura, ma lui non vuole e lo rispettiamo», dice May. «Vuole restarne fuori. È comunque ancora parte del destino della band. Se dobbiamo prendere decisioni importanti, viene sempre consultato, ma attraverso il management o il nostro contabile. Non parliamo direttamente ed è un peccato, ma sappiamo che abbiamo la sua benedizione e questo è importante».

Mercury agli Scorpio Sound di Londra, settembre 1975. Foto: Watal Asanuma/Shinko Music/Getty Images
Perfino Mercury in qualche modo sembra ancora presente nelle loro vite. «Brian e io spesso pensiamo che sia lì, nella stanza, in un angolo», dice Taylor. «Sappiamo esattamente cosa direbbe e cosa penserebbe anche se sono passati tanti anni da quando lo abbiamo perso». Ancora oggi, Mercury appare in sogno a May. «Sono sempre sogni molto prosaici», spiega. «Non è mai una sorpresa che sia lì, non penso mai che non dovrebbe esserci. È come se facesse ancora parte della mia vita, come è sempre stato».
A volte Mercury sminuiva con leggerezza l’importanza della sua musica, sosteneva che nulla di ciò che aveva fatto meritasse di durare, nemmeno Bohemian Rhapsody. «Era solito dire: “Oh, la mia arte è come la carta del fish and chips”», ricorda May. «Ricordi quella citazione? Diceva: “È usa e getta”. Ma mica lo pensava davvero, non fino in fondo». Sospira, pensa all’amico e ribadisce: «Non Freddie».
Da Rolling Stone US.