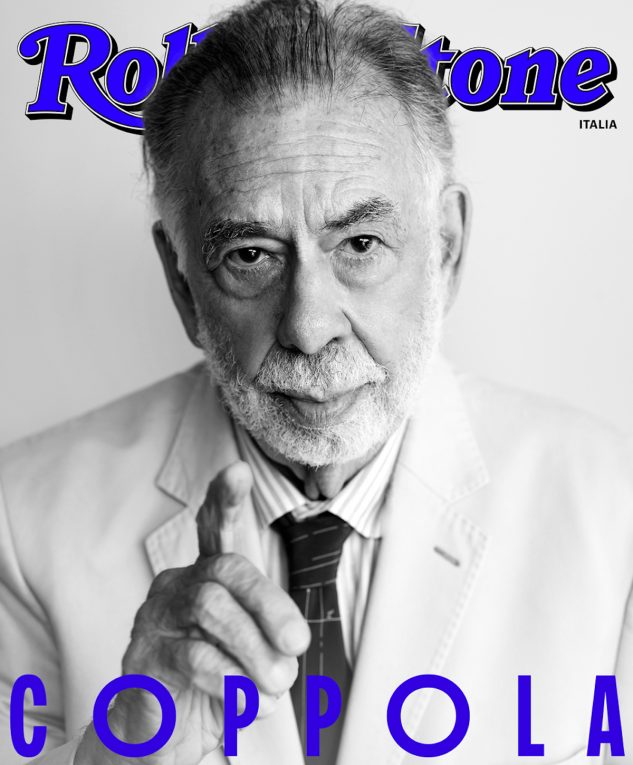I Placebo alla fine del mondo
Si sentivano come scimmie ammaestrate mandate in giro per il mondo a intrattenere il pubblico suonando sempre le stesse hit. Hanno fatto tabula rasa e ora cantano e parlano di un mondo che si sta autodistruggendo, di sorveglianza, del desiderio di scomparire. Brian Molko e Stefan Olsdal raccontano ‘Never Let Me Go’
Foto: Mads Perch
Nascosto dietro una coltre di fumo di sigaretta e d’incenso, Brian Molko vuol sapere se ho visto qualche foto recente di Chernobyl. Il tavolo che ci separa è pieno di tazze di caffè nero e la stanza – uno studio accogliente a East London, proprio sotto la stanza che ha affittato durante il lockdown per scrivere – sembra più il covo di un hippie che un posto dove ci si aspetterebbe di vedere il frontman dei Placebo. La luce a soffitto è spenta, le lampade al minimo, i divani coperti di cuscini colorati. Sono le 11 del mattino. «Brian fumerà», mi è stato detto prima di iniziare.
«La natura se l’è ripresa, gli animali sono tornati», dice il cantante, seduto a gambe incrociate con una sigaretta tra le dita, la stessa aria elegante che aveva nelle foto di metà anni ’90. «E sai perché? Non ci sono esseri umani. È così che immagino il mondo tra un millennio: un pianeta dove gli animali possono nuovamente prosperare, dopo che noi uomini abbiamo fatto di tutto per distruggerlo in nome del profitto».
Temi come il disastro ecologico, la piaga del capitalismo, la disillusione nei confronti dell’umanità ricorrono nella nostra conversazione e sono al centro dell’ottavo album in studio dei Placebo, Never Let Me Go, che in copertina ha una spiaggia fatta di strani ciottoli colorati. Molko l’ha ideata dopo aver letto di una spiaggia nella California settentrionale. Per anni è stata utilizzata come discarica. Ci buttavano di tutto, dai piani cottura alle automobili, finché a fine anni ’60 non è stata pulita. Durante la bonifica, si è scoperto che il vetro era stato levigato dalle onde dell’oceano, creando il caleidoscopio di colori che oggi è sulla copertina del disco.
«È una storia bellissima sulla resilienza della natura», dice Molko. «E anche su come gli uomini cagano dove mangiano. Distruggiamo i luoghi in cui abitiamo. Siamo l’unica specie a farlo. Ma con il tempo e la nostra assenza, la natura si darà una ripulita».
Never Let Me Go, che uscirà il 25 marzo, è il primo album dei Placebo in quasi dieci anni. Prima che il Covid fermasse il mondo, gli intervalli di tempo tra i dischi erano spesso occupati da tournée. A quella per il precedente Loud Like Love (2013) ne è subito seguita un’altra per le celebrazioni del ventennale della band. Per la gioia di un pubblico di adolescenti goth, adulti disadattati e millennial che hanno imparato il significato di “special K” e “burger queen” grazie ai testi di Molko, quei concerti erano pieni di hit come Nancy Boy e Pure Morning, canzoni che il gruppo non eseguiva da un decennio. Poi, dopo cinque anni on the road, i Placebo si sono ritrovati di fronte a un muro che li ha quasi disintegrati.
«L’esperienza del tour mi ha quasi portato a rinunciare a fare il disco», dice Stefan Olsdal, co-autore e polistrumentista. «Mi sembrava che ci stessimo suicidando lentamente, non sapevo quanta vita ci fosse ancora nella band. Non ero mai stato tanto scoraggiato».
«Abbiamo la tendenza a fare tutto quello che ci viene chiesto, non importa che impatto potrebbe avere sul nostro benessere fisico e mentale, così abbiamo continuato a suonare», aggiunge Molko. «Alla fine mi sentivo come una scimmia ammaestrata che veniva spedita in giro per il mondo. Ero scollegato dall’anima dei concerti».

Foto: Mads Perch
I Placebo giocano in un campionato a parte da quando sono emersi a South London nel 1994 con il loro suono sghembo e il look androgino. Le prime canzoni parlavano di rabbia giovanile, disfacimento psichico, abuso di droghe e confusione sessuale, sempre con la stessa aria tragica e una certa pulsione desiderante. Il loro suono era allo stesso tempo malinconico e urgente, suonavano velocemente perché erano ansiosi di arrivare chissà dove.
Influenzati dal post punk britannico e dalla new wave, oltre che da band di rock sperimentale come Sonic Youth e Velvet Underground (Molko si è iscritto al Goldsmith College dopo aver scoperto che ci era andato John Cale), i Placebo sono saltati fuori mentre l’edonismo degli anni ’90 esalava l’ultimo respiro. Il debutto omonimo, scritto in buona parte in una casa popolare di Deptford e pubblicato nell’estate del 1996, è arrivato al quinto posto della classifica del Regno Uniti e ha catapultato la band sotto i riflettori, nel pieno del picco commerciale del Brit pop. In quel mare di gruppi che sfoggiavano look sportswear, i Placebo e i loro lucidalabbra, le magliette aderenti, le lingue avvolte su parole proibite come un capello tra le dita erano decisamente fuori posto, lontani da tutto ciò che di macho e sterile c’era nella società britannica.
Erano alieni anche per la controcultura dell’epoca. La loro non era la ribellione dei rave, delle camicie di flanella, dei Brit Awards accettati con la sigaretta in mano. La loro ribellione era nel trucco, nel cantare di sesso queer su un muro di suono potente che ricordava i My Bloody Valentine. Era musica che veniva dallo stomaco, finita nel mainstream grazie alla forza brutale della scrittura.
«È quando eravamo piccoli che non ci sentiamo accettati», dice Olsdal. «Abbiamo cercato un posto dove sentirci così, fino a quando non lo abbiamo inventato noi».
La longevità dei Placebo è in parte spiegata dalla partnership creativa fra i due fondatori, Molko e Olsdal, che hanno superato i 40 anni d’età e collaborano da un quarto di secolo. Viene in mente l’espressione spiriti affini. Gli studi musicali classici di Olsdal e la sua passione per gli arrangiamenti compensano l’approccio più astratto di Molko (soffre d’insonnia dall’adolescenza e perciò gli capita spesso di scrivere in uno stato di semi-allucinazione e privazione di sonno: «Così facendo si manifesta una strana sensibilità», spiega, «non so perché, ma le melodie arrivano quando mi sento più debole»). I due si somigliano: parlano lentamente, sono un po’ timidi, condividono l’amore per gli outsider del rock (PJ Harvey, Björk, Grace Jones, Bowie) e un grande rispetto per quello che hanno costruito assieme.
Molko e Olsdal hanno frequentato la stessa scuola in Lussemburgo (Molko è nato in Belgio ed è cresciuto in un paesino rurale; Olsdal a Göteborg, in Svezia, ma si è trasferito da piccolo), ma si sono incontrati solo una volta trasferitisi a Londra, davanti a una fermata della metro.
Hanno iniziato a scrivere come duo, usavano tastiere economiche e chitarre senza tutte le corde. Robert Shultzberg, un amico d’infanzia di Olsdal, ha iniziato a suonare la batteria per loro nel 1994, ma ha lasciato poco dopo l’uscita del primo disco. Da allora, c’è stato un ricambio continuo di batteristi. L’ulitmo, Steve Forrest, ha mollato qualche anno fa.

Foto: Kevin Westenberg
Arrivati alla fine del tour per il ventesimo anniversario, i Placebo erano davanti a un bivio: scrivere un altro disco o smettere. Erano stanchi e disincantati, un sentimento che Molko ha combattuto con tutte le forze. «Basta stronzate, Brian», si è detto. «Concentrati, dai».
Per scrivere Never Let Me Go, Molko e Olsdal si sono ritrovati esattamente nel punto in cui erano partiti: da soli, circondati da strumenti (questa volta un po’ più costosi), pronti a giocare col rumore.
Molko voleva liberarsi dall’amarezza che il tour gli aveva lasciato dentro. «Volevo fare qualcosa con una certa brutalità, nel suono o nei testi», dice facendo riferimento a uno dei suoi dischi preferiti, Yeezus di Kanye West, come un esempio di musica commerciale portata all’estremo. È venuto fuori un disco più «ascoltabile» del previsto. Con le sue 13 tracce di rock metallico, post punk e splendide melodie di pianoforte, Never Let Me Go è il migliore album dei Placebo da molti anni a questa parte.
La traccia d’apertura Forever Chemicals spiazza subito con un suono difficile da definire. Si tratta di una serie di note, quasi campane da un futuro abitato da cyborg (è un loop di batteria passato in un arpeggiatore e poi distorto). È la prima cosa che hanno scritto. «Quel loop è quasi una dichiarazione d’intenti», dice Molko. «È melodico, catchy, ma anche brutale. Scriverlo è stato il modo per chiarire subito le nostre intenzioni».
È una tensione che si percepisce in tutto l’album, che sembra sempre l’orlo di un precipizio in bilico fra intimismo e paranoia. Il primo singolo Beautiful James racconta di un rapporto sentimentale fuori dai confini eteronormativi. Lo spunto per Surrounded by Spies viene da certi vicini di casa di Molko che lo spiavano. La canzone s’è poi trasformata in un pezzo sulle moderne forme di sorveglianza. «Vaghiamo come sonnambuli per la città e neanche ci accorgiamo che i nostri spostamenti possono essere seguiti dalla soglia di casa fino alla destinazione», dice Molko. «Mi sono detto: se i miei bravi vicini possono farlo, a che punto si può arrivare? È la versione micro di un fenomeno macro».
Chemtrails sembra quasi una risposta a tutto ciò, è una fantasia su sparire della società dopo essere stato “visibile troppo a lungo”, mentre Went Missing immagina una persona che “sparisce per vivere”. In tutto il disco c’è un senso di strisciante paranoia, ma c’è pure una sensazione di risoluzione.
Never Let Me Go è stato scritto a singhiozzo, in parte prima del Covid, il resto tra i lockdown che ci sono stati nel Regno Unito e che hanno concesso ai musicisti la rara opportunità di mettere la famiglia prima della band (e, nel caso di Molko, di spararsi tutte e dieci le stagioni di Curb Your Enthusiasm). E così le restrizioni che hanno interferito col processo creativo hanno anche dato l’opportunità di far sedimentare le idee e riascoltare le canzoni con orecchie nuove. Lo si percepisce nell’album, dove ci sono più silenzi del solito e il suono è stratificato e inusuale.
Buona parte dell’album è nato nello studio casalingo di Olsdal, dove la band s’è destreggiata tra laptop, pedali, cavi e tastiere a tal punto che la forma dell’album è stata dettata da quello spazio fisico tanto quanto dalle idee astratte. «È stato come cucinare con gli ingredienti che si hanno in casa. Siamo uno di quei gruppi che si divertono coi suoni», dice Olsdal sorridendo.
Il senso di sperimentazione emerge anche dal lato visivo. La copertina è pixelata su un lato, come se fosse un’immagine che fatica a caricarsi. Il video di Surrounded by Spies è girato dal punto di vista delle camere a circuito chiuso. Per la prima volta appaiono nell’artwork (dei singoli Beautiful James e Surrounded by Spies) i visi dei musicisti, ma sono distorti. I volti di Molko e Olsdal non si vedono mai chiaramente, un riferimento al tema della sorveglianza con immagini che sembrano prese da videocamere (da questo punto di vista Londra è la città più controllata al mondo, Cina esclusa) o da parte dei vicini. Ma è anche una scelta decisamente pratica.
«Credo nasca dalla nostra innata timidezza», ammette Molko. «Era da quattro o cinque anni che non facevamo un servizio fotografico e ci siamo ritrovati in un mondo in cui nessuno più diffonde immagini di sé stesso senza manipolarle. Tutti ci nascondiamo, tutti proiettiamo un’immagine non veritiera di noi stesso. Abbiamo portato quest’idea al limite. È un commento sull’estetica imperante».

Foto: Mads Perch
Il disco nasce dal desiderio di fare qualcosa di completamente diverso da Loud Like Love, lontano dal materiale suonato in vent’anni di attività concertistica con cui Molko in particolare ha un rapporto conflittuale.
«Tutte le volte che mi capita di riascoltare le mie vecchie cose non riesco a non pensare a quel che avrei potuto fare meglio, per varie ragioni: lo stile di vita, l’arroganza, il distacco dalla realtà, l’idea che qualsiasi cosa facessi fosse geniale. Avevo quel tipo di spavalderia e sicurezza indotta dalle droghe negli anni ’90 e nei primi 2000», spiega. «Ora guardandomi indietro non possono che rimpiangere il fatto di non essere stato più lucido e presente».
È perciò sorprendente che l’album abbia origini non verbali. Quando Molko s’è imbattuto nell’immagine della spiaggia l’ha portata a Olsdal, ed è allora che Never Let Me Go ha iniziato a prendere forma. Non come suono o concetto, ma come sensazione. Dopo averla vista, Olsdal si è sentito sollevato.
«Mi ha trasportato in uno spazio dove il tempo non esiste, dove gli esseri umani non esistono e la natura ha fatto il suo corso», spiega. «Nessuno che interferisce, nessun bagaglio, niente storia, zero problemi. Fare tabula rasa dell’ultimo album, che era stato piuttosto problematico: ecco cosa rappresentava quell’immagine».
Per Molko, che soffre di depressione da cambiamento climatico ed è talmente angosciato dalla situazione politica del Regno Unito da volere riottenere la cittadinanza europea, l’immagine rappresenta anche il mondo in cui vede l’umanità. «La nostra ossessione per la ricchezza ci porterà all’estinzione», dice con un sorrisetto cinico. Aggiunge che non vuole essere preso troppo sul serio perché «abbiamo bisogno di speranza». Ma comunque sogna di fare come Lord Lucan e scomparire, un po’ come il protagonista di Went Missing.
«Sento sempre più il bisogno di silenzio e pace per esprimere la rabbia». E così all’inizio del 2021 ha lasciato Londra dopo tre decenni per trasferirsi in un luogo sonnecchioso da qualche parte in Europa. «E magari fra dieci anni mi ritroverete su un’isola con il mio pezzo di terreno, sarò il tizio che si fa la doccia con l’acqua piovana e che coltiva l’orto. Ecco come voglio diventare».
Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone UK.