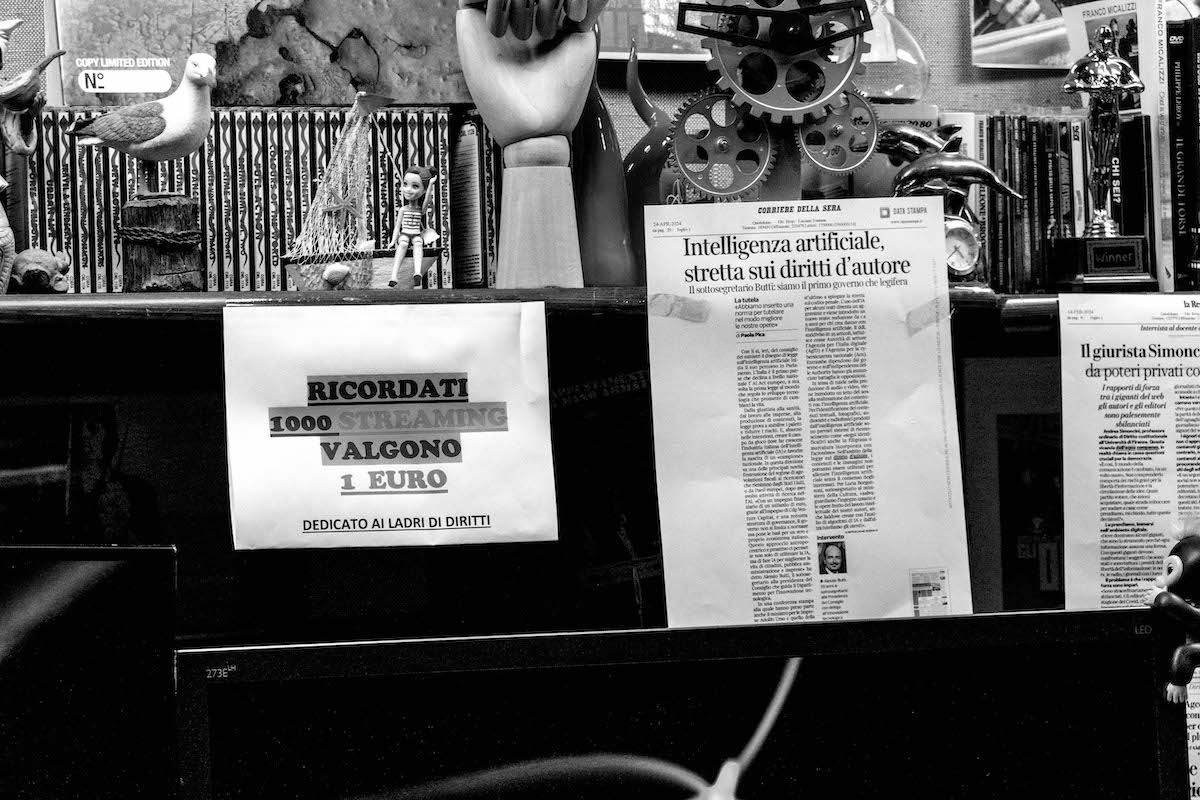Franco Micalizzi è uno dei principali compositori di colonne sonore degli anni ’70 e ’80. Una generazione dopo Morricone e Piccioni, la sua opera è legata ai film di Bruno Corbucci e Umberto Lenzi, autori degli spaghetti western e dei poliziotteschi che hanno caratterizzato il cinema di genere italiano. La sua musica però ha più vite, è stata usata nei film di Quentin Tarantino, nelle musiche di importanti rapper americani, in serie tv contemporanee come Curb Your Enthusiasm.
Nasce a Roma nel 1939. Cresce nell’immediato dopoguerra, il Paese martoriato dai bombardamenti, le famiglie decimate dai combattimenti e dalle deportazioni.
«Sono nato mentre scoppiava la guerra, ne sento ancora il sapore brutto, la sensazione mortifera che porta. Nell’immediato dopoguerra vedevo quei documentari sui lager con migliaia di corpi presi con la pala e ammucchiati uno sull’altro. Immagini che non ti togli più dagli occhi, dalla testa, dal cervello. Sento che c’è qualcuno che ancora dice “Però quando c’era lui…”, ma come si fa a dire che ha fatto qualcosa di buono? Ha fatto l’italiano, purtroppo quello degenere. Ma non è vero che il cattivo vince sempre. Non solo nei film western, anche nella vita vince quello in gamba, quello che ha il cervello e che riesce ad avere pietà degli altri. La guerra è mancanza totale di pietà. Sbarcati ad Anzio quando c’erano ancora i tedeschi, sono morti migliaia di ragazzi americani. Ci hanno salvato, ci hanno dato il Piano Marshall, la possibilità di venire fuori dalla dittatura e ricominciare. Hanno portato la democrazia che è il bene principale. Come fai a non essergli grati? Dopo la guerra hanno vinto sul mondo, per la musica, per il cinema, per tutto quello che era arte. Cinema meraviglioso, musica meravigliosa».
Martin Scorsese, malato gravemente di asma da piccolo, prese spunto dalla realtà che vedeva dalla finestra della sua stanza dove era confinato, per buona parte dei suoi film. Come per molti altri artisti, la vena creativa di Micalizzi parte da una grave malattia infantile.
«Da bambino ho avuto un morbillo che si è trasformato in una polmonite, febbre a 43, l’unica cosa che poteva salvarmi era la penicillina. Una siringona di vetro e acciaio con un ago lungo e largo. Il liquido entrava e bruciava, dei dolori tremendi. Era una tortura, ma era anche il progresso che mi ha salvato la vita. Sono stato un anno a casa, ho perso un anno di scuola, la quinta elementare, dovevo andare in prima media e sono rimasto lì. Guardavo fuori dalla finestra e vedevo il fumaiolo del Policlinico, una grande torre da cui usciva un gran fumo la mattina».
«Fino ad allora ero un bambino non felicissimo, vedevo tanti problemi, mi sentivo un po’ inferiore, me lo ricordo ancora. Però la guarigione era come se mi avesse sanato tutto. Tutte le paure, quelle brutte cose non le sentivo più addosso. Ho sentito che potevo prendere possesso della vita, ne ero padrone. Finalmente sono tornato a scuola, ho fatto gli esami di ammissione e sono andato benissimo. Ricordo che scrissi un tema, rendendomi conto che avevo scritto delle cose belle. Si aprì come una porta poetica dentro di me, qualcosa che non conoscevo fino a quel momento. A scuola prendevo bellissimi voti per i temi. Due giorni dopo il compito in classe di italiano, quei fogli protocollo che si piegavano in due, con i commenti accanto. La professoressa disse: “Cari ragazzi, oggi è un giorno molto speciale, voglio dirvi che tra di voi è seduto un personaggio che sono certo farà una carriera bellissima”. Sentii naturalmente dell’orgoglio. Era la prima volta in vita mia che sentivo di avere un futuro».
«Volevo fare lo scrittore, il giornalista, ma adoravo la musica. Mi chiudevo nel salone dove accendevo la radio… Il salone nelle famiglie veniva tenuto al buio, perché se no si rovinavano le cose… Rimanevo lì al buio, da solo ascoltando la musica e sopratutto i drammi radiofonici. Avevo un compagno di banco un po’ burino, uno che studiava poco, che suonava la chitarra, e sono andato a trovarlo a casa. Era bello vedere come si faceva a suonare, “ti dispiace se mi dici la posizione?”, e in poco tempo mi sono impadronito di quella chitarra, cazzo che bello! Da lì ho capito che si può fare musica. A mia madre dissi: “Fatto questo esame, non voglio riprendere la scuola. Sono già in grave ritardo. Da domani voglio fissare la prima lezione di musica”. I miei genitori, anche se spaventati, sono stati bravissimi e mi hanno supportato, e dal giorno dopo ho cominciato a studiare musica. Era un po’ una rottura di scatole perché con la musica fino a quel momento era un godimento e basta. C’era da lavorare: gli intervalli, il solfeggio…».

Foto: Gabriele Micalizzi/Cesura
Micalizzi comincia a suonare ai tè danzanti nei locali di Roma della dolce vita insieme a musicisti che plasmeranno la musica italiana.
«Suonavamo alle Grotte del Piccione, in via della Vite, un locale molto centrale, dove passava mezza Roma, al Capriccio e al Piccione. Era bella quella Roma di notte, la città del jet-set. Era piena di questi locali. Noi andavamo alle feste danzanti del sabato pomeriggio, con il gruppo che col quale suonavo prendevamo 1500 lire. In una di queste feste vidi mia moglie, che era una ragazzina. Una ragazza favolosa, lo devo ammettere. C’era una foto qui sulla parete del mio studio, ma me l’ha tolta. Noi litighiamo, e lei mi toglie le foto. Poi dopo facciamo pace, ritrovo la foto e grido: “Sei bellissima!”. Lei ballava che era una meraviglia, andavano i pezzi sudamericani che avevano dei passi molto impegnativi, ma io non ho mai imparato perché i musicisti sono negati a ballare, lo sanno tutti. Suonano perché sanno che non sanno ballare. L’ho notata, ho visto ’sta spallina che cadeva e lei che se la rimetteva a posto. Aveva un vestito di quelli con la gonna a palloncino, che si usavano all’epoca. Me ne innamorai subito».
Micalizzi comincia a suonare con l’orchestra di Robby Poitevin, un francese che ha lavorato con Dizzy Gillespie, Benny Goodman e che componeva anche musica da film (Quella carogna dell’ispettore Sterling e Tecnica di un omicidio).
«Un giorno mi chiama uno con un forte accento francese: “Franco? Ciao, sono Robby. Sai, ti ho visto ai tè danzanti, e siccome noi stiamo formando un gruppo volevo sapere se vuoi venire con noi in tournée”. Gli dissi di sì, senza neanche pensare. Sentivo che era destino, la vita mi diceva che era la cosa giusta da fare. Sono andato a suonare con loro. Con noi c’era Flavio Carraresi, che allora era un batterista molto in vista, un serio jazzista milanese, generosissimo. Al tempo andava il cantante urlatore, Tony Dallara, e altri grandi nomi come Modugno, Jimmy Fontana. C’era il finto basso, cioè non sapendo suonare il basso facevano “pum, pum pum”, davano ’sta botta e davano l’idea che suonassero. Avevamo il finto basso, batteria, chitarra, pianoforte e andava molto bene, addirittura con delle richieste dall’estero che dovemmo rifiutare. Eravamo ragazzi, due erano pariolini, me li ricordo ancora, con gli spacchi dietro le giacche, con la cravatta e le scarpe inglesi, molto grosse. Robby era un bravo pianista, che mi ricordava Petrucciani. Aveva l’orecchio assoluto. Gli dicevo: “Senti questa Robby, cos’è?”. Si-do-re bemolle, e ci azzeccava, da pugni sul muro! E noi invece dovevamo studiare».
«Per dire come eravamo combinati, quando siamo arrivati a Milano non è che avevamo i soldi in tasca, avevamo gli spicci. Dovevamo arrangiarci per mangiare. Una volta entrammo in un ristorante, ci sedemmo e cenammo. Al momento del conto, dicemmo: “Guardi, noi abbiamo un contratto con la Ricordi e a breve ci daranno un anticipo”. E ci fecero credito finché non riuscimmo a saldare il debito. Chi lo farebbe oggi? Si fidarono di questi ragazzi messi un po’ così… La parola, il rapporto umano, valevano. Adesso non ti fidi più».
«Nanni Ricordi fu il primo che iniziò a occuparsi della cosiddetta musica nuova. Sentimmo questo pezzo che diceva “c’era una volta una gatta…” con questa voce mite, all’inizio ci stranì un po’, perché venivamo da Sinatra e dai grandi crooner. Invece riconosco a Gino Paoli di aver fatto dei pezzi molto, molto belli. Poi ricordo che una volta, mentre stavo suonando, vidi Sergio Endrigo sotto che su un appoggio di fortuna firmava il contratto con la Ricordi. C’era un livello alto, penso a un pezzo come Io che amo solo te. Si tratta di essere perfetti, con accordi precisi su una cosa semplice: se ci riesci puoi arrivare a chiunque. Se trovi le proporzioni giuste, ti accorgi che il pezzo ti trasporta, te dice “annamo!” e non ti fermi mai. E quando fai un pezzo che può durare nel tempo, per me hai raggiunto la perfezione».




Foto: Gabriele Micalizzi/Cesura
Nasce il suo primo figlio e Micalizzi trova lavoro alla RCA.
«Incontrai Gianni Meccia in una serata folle in cui dieci persone suonavano a un veglione di Capodanno. Bastava che uno avesse una chitarra e ti prendevano e guadagnavi 10mila lire. Erano persone sconosciute, sono tutti diventati produttori e autori di cantanti famosi. Fra di loro c’era un pazzo che si chiamava Gianni Meccia: suonava la chitarra, con un sorriso incredibile, e cantava Odio tutte le vecchie signore, oppure Il tarlo, ed era veramente una novità. Lui fu il primo cantautore italiano, nel senso che il termine cantautore prima non esisteva, fu inventato per definire lui. Faceva questi pezzi con due accordi, Il barattolo o Il pullover. Ennio Melis, il direttore generale della RCA, decise di far uscire Meccia come primo disco italiano della società. Avevano degli studi bellissimi sulla Tiburtina, una cattedrale nel deserto, un sogno per un musicista, un posto dove fare un disco, dal provino fino alla macchina dove lo stampano: un paradiso. E sono riuscito, rompendo le scatole, a farmi assumere come assistente musicale. A livello musicale, il mio era il compito più basso».
«Morricone l’ho conosciuto lì la prima volta, il primo giorno, fresco di assunzione. C’era lui che faceva una base per la Pavone e Gianni Morandi, per un pezzo che avrebbero poi fatto in studio. Molti musicisti hanno avuto l’intelligenza di capire che erano a contatto con uno del suo spessore. Gente come Luis Bacalov, altro musicista notevole, pianista, se penso all’arrangiamento di Io che amo solo te di Endrigo, guarda ci vuole un gusto… Era un momento di grande invenzione. Lavoravano col cuore, volevano solo fare musica. Forse Ennio più di tutti. Quindi improvvisamente ti ritrovi a contatto con personalità come Morricone e Bacalov, e poi tutti i giorni c’erano musicisti, registi… Ho conosciuto Angelo Lavagnino, lui faceva le musiche per i film di Totò. Divenne un grandissimo amico, mi raccontava di tutto, mi dava i consigli giusti, mi diceva: “Franco, nel cinema la musica è come l’aria: te ne accorgi soltanto quando manca e quando è cattiva”».
«Con Morricone diventammo amici. All’inizio facevo l’assistente musicale ai suoi film, cercavo di fissare la registrazione migliore, se andava rifatta o se c’erano degli errori di esecuzione. Mi piaceva sempre quello che scriveva. Alcuni musicisti erano meglio come compositori e altri come arrangiatori, Ennio tutti e due. E mi divertiva la sua grafia, le partiture di Morricone le riconosco tutte. Avevamo un buon rapporto. Lui però era molto egocentrico, quando uscivamo nelle pause mi guardava con la sigaretta e questi occhiali spessi con gli occhi da pazzo: “Franco, ma a te chi ti piace di più? Io o Piccioni?”. E io: “Ah Ennio, eddai!”. E poi ritornava il giorno dopo: “Quindi?! Hai deciso?”. Voleva mettermi in difficoltà. Lui era già un grosso nome, io ero l’assistente musicale che prendeva lo stipendio. Se Morricone avesse parlato male di me magari mi avrebbero licenziato, ero solo un sottoposto. Voleva capire che tipo fossi, se facevo il lecchino o no, ma io ero sincero. Questa rivalità fra lui e Piero Piccioni si sentiva un po’. Ma alla fine non c’entrano niente l’uno con l’altro. Piccioni ha fatto film importanti con Sordi, grandi successi, ha fatto cose molto carine, alcune anche ben scritte».
Nel 1970 riceve l’incarico di comporre la sua prima colonna sonora per il cinema. Si tratta di uno spaghetti western ma in versione comica, con due attori allora pressoché sconosciuti, Bud Spencer e Terence Hill.
«Il produttore era uno grosso che veniva dal pugilato, era anche stato campione italiano. Mi faceva molta simpatia e andavamo spesso a pranzo insieme. Gli ho rotto le scatole per settimane: “È un filmetto piccolo, fammi il piacere”, e alla fine fra una pastasciutta e un mezzo litro di vino, l’ho convinto. Era un film piccolo. “Che cosa va di moda adesso, il western? Facciamone uno con le passeggiate a cavallo alla Magliana, giriamo lungo il Tevere, eccetera…”. Come diceva Hitchcock, la gente vede solo quello che tu inquadri. Basta che tu inquadri stretto, evitando i palazzi di Roma, e sono due che camminano lungo un fiume nel West, il campo dei Mormoni in Abruzzo, i saloon sono quelli costruiti dove ci hanno fatto già dieci film western, cambiano solo un po’ di arredi».

Foto: Gabriele Micalizzi/Cesura
Il film riscuote un successo strepitoso sia in Italia che all’estero, decretando l’ingresso di Micalizzi nel novero dei più importanti compositori italiani di colonne sonore. Il tema di quel film è tuttora uno dei brani più famosi di Micalizzi. Verrà utilizzato su Django Unchained da Quentin Tarantino per la sequenza finale e i titoli di coda. «Tutti gli artisti hanno la loro Yesterday. All’inizio dici: ammazza, ottimo ’sto pezzo che ho fatto, poi ti riconoscono sempre per quello, vogliono solo quello, e alla fine magari non ti piace più».
Ovidio Assonitis è stato uno dei più prolifici produttori di film di genere degli anni ’70. Greco-italiano nato in Egitto, negli anni ’60 distribuisce oltre 600 film nel mercato del Sudest asiatico, per poi cominciare a produrre e dirigere film di genere ispirati dai successi più famosi del cinema americano, come Tentacoli (dopo Lo squalo) o Stridulum (dopo L’esorcista), ingaggiando attori americani come John Huston, Shelley Winters, Henry Fonda. Nel 1982 produce Piraña paura, il debutto alla regia di James Cameron. Assonitis licenzia il regista dopo poche settimane di riprese, dirigendo e firmando in prima persona il film. Con L’ultima neve di primavera inaugura un filone di successo, quello dei “film strappalacrime”.
«Ovidio era un pazzo. Mi raccontava due film al giorno. Era sempre alla ricerca del colpaccio. Aveva un direttore della fotografia, Roberto D’Ettorre Piazzoli, che era di una bravura… sai quelli che hanno il senso dell’inquadratura, che trovano sempre il colore giusto. Sembrava un film fatto dagli americani, e sarà costato dieci lire. Il regista del film, Raimondo Del Balzo, non aveva il fisico, l’anima, il carisma che doveva avere un regista. Non gli ho mai sentito dire un’idea, una cosa, avevo come l’impressione che avesse dato dei soldi per dirigere il film e Ovidio non guardava in faccia a nessuno. Diceva: “Voglio fare un grandissimo successo, un sacco di soldi, ammazzo pure mia madre se necessario, non me ne frega niente”, questa era la sua mentalità. Voleva mettermi in concorso con altri autori, ma a me non andava. Però, non avendo molte cose da fare, una sera prima di cena mi misi al piano e vennero istintivamente delle note. Non mi fecero sapere niente e pensai che non avessero avuto il coraggio di dirmi che non andava bene, quando invece scoprii che stavano girando e durante le riprese, per creare l’atmosfera con gli attori, mettevano il pezzo che avevo composto».
«La scena finale è girata sulla ruota di un luna park, dove pian pianino questo bambino malato muore fra le braccia del padre. La ruota gira, bellissima, le immagini di questo bambino, e con la mia musica subito stai male, piangi. È matematico. Nel manifesto Assonitis aveva fatto scrivere: “Peccato papà non rivederti più”. Ma si può essere più cattivi di così? Mia moglie conosceva il film a memoria, al cinema vedo una persona che esce dalla sala di corsa, in lacrime: era lei! Il produttore organizzò una proiezione privata per i tre critici più famosi di quegli anni. Mentre vedevano il film noi fuori ci siamo messi a chiacchierare e finito il film loro escono, con gli occhi gonfi e il viso praticamente deformato dal pianto. Erano incazzati, molto incazzati. Ci hanno detto, serissimi: “Non si fanno queste cose. Queste sono coltellate date al pubblico”. Era troppo incisivo. Li avevamo fatti piangere per forza».
«Ha pianto tutto il mondo. In Brasile è stato un successo incredibile, in Argentina il brano è stato in classifica per un anno. Una sera ero a casa da solo, mi stavo facendo una pastasciutta e avevo la radio accesa. Il programma era I dischi caldi, che era la classifica dei più venduti, e quella settimana la mia musica aveva debuttato al terzo posto. Ero talmente in confusione che non ho mangiato più niente. Una volta ricevo una telefonata, non parla nessuno e sento in sottofondo il disco dell’Ultima neve di primavera che andava. Penso: sarà la solita ammiratrice. Era la mia professoressa delle medie. Non aveva il coraggio di di parlarmi, ma voleva dirmi vedi che avevo ragione ad aver puntato sulla musica. Poi mi ha parlato: “Franco, ormai sei grandicello…”».
Negli anni ’70 in Italia si producono centinaia di titoli. Molti di questi film, oltre ad avere un incredibile successo in patria, vengono esportati in tutto il mondo. Il giallo, il western, l’horror e il poliziottesco italiano sono poi stati riscoperti dal cinema americano. Quentin Tarantino ha usato numerosi brani di Micalizzi nei suoi film, fra cui il tema di A mano armata per Death Proof.
«A un giovane direi di vedersi i grandi classici. In America studiano Ladri di biciclette, Miracolo a Milano. C’è quella corsa di Anna Magnani quando le sparano i nazisti in Roma città aperta che posso vedere un miliardo di volte e ogni volta provo una forte emozione. La spudoratezza della morte, lei per terra con le calze nere e la coscia bianca che compare. Credo che abbiano girato la scena una volta sola. La Magnani era un personaggio difficile, una persona molto prepotente, ma come attrice ti prendeva per il collo, ti scuoteva».
«Il nostro cinema era fatto con pochi soldi. Certe scene dei film polizieschi a cui lavoravo agli americani sarebbero costate miliardi, noi ce la cavavamo con poche lire. Su Napoli violenta c’è una sequenza di un funerale che mi fa venire in mente quelle scene del neorealismo. C’è il mercato, vero, con i suoi colori, e dall’altra parte arriva un funerale napoletano, di quelli con il carro con i cavalli neri e le piume, e una fila lunghissima di persone. La vita del mercato e un morto chiuso in una bara. Mentre passa il corteo funebre si vedono i protagonisti del film che scappano, si intrufolano nella fila. E io chiedo al produttore: “Ma come avete fatto questa scena così ricca, così complicata?”. Sapevano che ci sarebbe stato un funerale, hanno contattato la signora del terzo piano e per 300mila lire hanno messo la macchina da presa sul terrazzo. Vedi l’inventiva? Il colpo d’occhio? Non c’è niente di peggio di un funerale vero, le persone non recitano. Gli stessi americani bravissimi certo, organizzatissimi, ma una scena simile sarebbe costata tantissimo».
«Anche gli inseguimenti erano tutti veri. Mettevano la macchina da presa su una motocicletta davanti all’automobile e partivano. Una volta è finita con una vera macchina della polizia che inseguiva la polizia finta. Metà dagli stunt che facevano questi inseguimenti spesso facevano le rapine vere, la violenza era vera perché era gente di malavita, che la sera dopo le riprese si ubriacava nei night e tornava il giorno dopo sul set pieni di lividi».

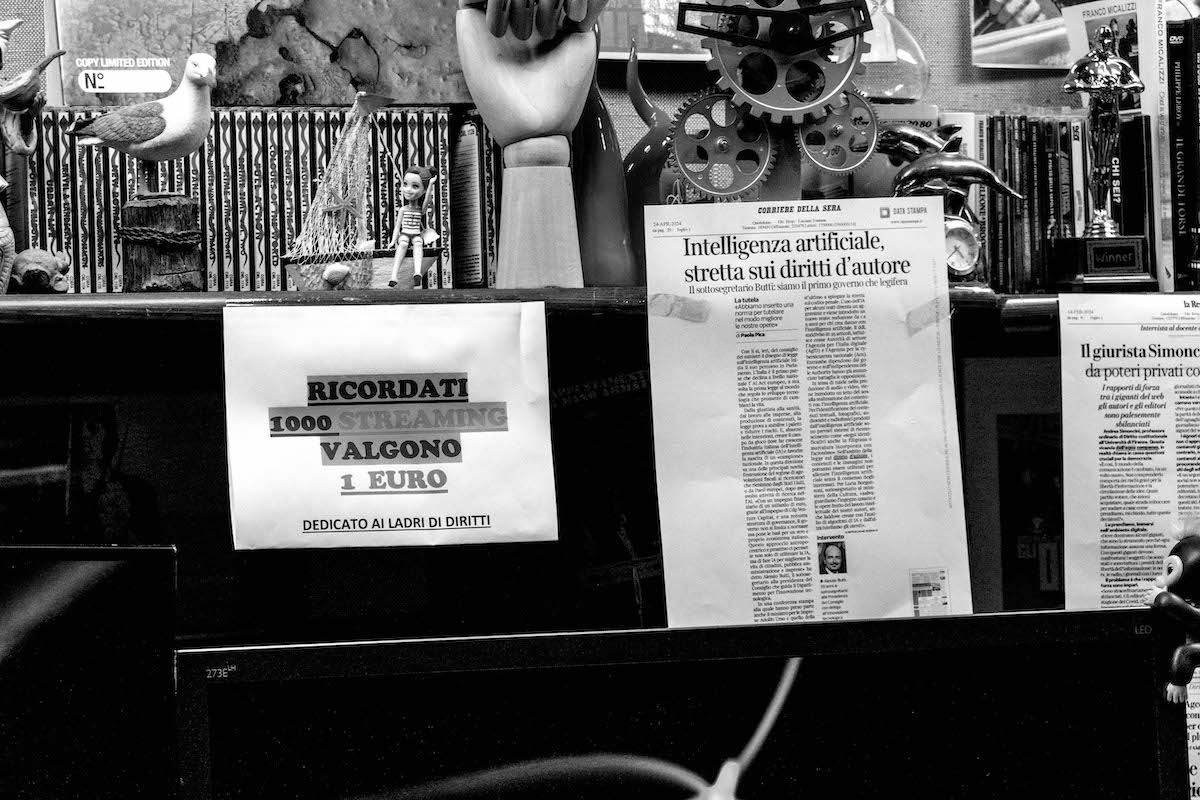
Foto: Gabriele Micalizzi/Cesura
Il successo dei film di genere italiani deriva anche dalla particolarità dei temi musicali. I film venivano girati in fretta, per approfittare del successo del film precedente o del campione d’incassi americano a cui si ispiravano. I produttori davano grande libertà ai compositori.
«Secondo la SIAE, e tutto sommato è vero, gli autori del film sono il regista e il musicista. Sono quelli che veramente incidono sulla materia, perché gli sceneggiatori preparano la storia ma poi non sono nel film, cioè non incidono sulla pellicola. Qualcuno ha preso questa cosa scritta e l’ha realizzata. In realtà ci sono infiniti aiuti, dal direttore alla fotografia ai costumisti, gli arredatori, gli stunt… C’è anche il montaggio, che per me è il terzo autore del film, il passaggio autoriale che può cambiare il tono della scena. Riguardando l’azione, però, ti accorgi che ti manca qualcosa: “Ci fosse un po’ di musica sotto…”. Nel cinema si è capito subito che l’immagine da sola non poteva vivere. Dai tempi del film muto sotto l’azione c’era la pianola: si sentiva il bisogno di qualcosa che desse profondità a queste immagini in bianco e nero. Se tu in certe sequenze molto belle girate da Sergio Leone gli togli la musica e rivedi la stessa sequenza, dici: “Che cagata”! Perché è vero, nessuno ha coscienza che c’è la musica in quel momento».
«Io poi sono tremendo nella vita. Sei così presuntuoso, mi dicono. Meno male! Nel nostro ambiente, se non sei almeno un po’ presuntuoso non combini nulla. Con tutti quelli che ascoltano quello che fai devi essere convincente, perché se non difendi la tua opera in qualche maniera… C’è una frase di Leonardo che mi piace molto: siamo come degli insetti dentro un quadro. C’è qualcuno che si accorge di essere nel quadro e ha il dovere di esserne il protagonista, mentre gli altri fanno solo gli insetti, cercano l’uscita ma non la trovano e si muovono finché muoiono».
«Ogni tanto ti capita di lavorare con un regista che non capisce un cazzo di musica, scusami la parolaccia, e a volte il produttore è peggio. Il produttore di Trinità venne in studio e disse: “Fammi sentire quella cosa che fanno lì, quel passaggio…”, e mimava… “Quale, di chi?”. “Non so, i violini, no, no, no, come si chiamano i violini grossi?”. “Dici i contrabbassi?”, e non capivo… Alla fine voleva i violoncelli…».
Oltre a comporre per il cinema, Micalizzi crea anche colonne sonore per le versioni italiane di alcuni cartoni animati giapponesi. La libertà compositiva per questi progetti gli dà la libertà di sperimentare. La più famosa è la sigla finale di Lupin III, cantata da Irene Vioni e accompagnata dall’orchestra di Liscio di Castellina-Pasi.
«Si vede che la fame mi aiuta, mi ricorda che bisogna mangiare e quindi bisogna lavorare bene. Stavo di nuovo in cucina a cucinare degli spaghetti ed è venuta fuori questa idea per Lupin. Io non è che amassi il liscio, amavo moltissimo la musica francese. Conoscevo il liscio di Casadei e conobbi in sala di incisione Castellina-Pasi. Andai a trovarli a Cattolica e avevano imparato il pezzo alla perfezione, lo avevano già arrangiato e a modo loro. Bellissimo. Al liscio riconosco una caratteristica degna e non trascurabile: quello che facevano rispondeva a uno stile popolare ma corretto, suonato benissimo».
Assonitis assolda Micalizzi per il suo nuovo film, di cui curerà anche la regia: Stridulum. Un progetto importante, girato negli Stati Uniti con un cast di star: John Huston, Glenn Ford, Shelley Winters, Sam Peckinpah. È un mix fra L’esorcista, Il presagio, Incontri ravvicinati e i film visionari di Alejandro Jodorowsky. È l’occasione per Micalizzi di registrare negli Stati Uniti.
«Per me era un’emozione. Non dormivo la notte pensando a quello che avrei dovuto fare l’indomani. Chiesi di trovarmi musicisti bravi, ma mi accorsi subito che non c’era bisogno di dirlo. Una grande orchestra, tanti tromboni, dei contrabbassisti grossi così, e ci vuole fisicità per il contrabbasso. C’era pure un jazzista famoso al sax che stava lì incazzato nero perché doveva registrare per un italiano. Erano tutti incredibili e capivano al volo cosa fare. Vabbè, allora ragazzi, bene, partiamo: alla prima prova venne suonato subito di impatto, meglio di come mi auguravo che potesse venire. Sentii un piacere, ma tu non lo puoi capire il piacere, proprio un piacere fisico. C’era Warren Wilson, che in Bargain with the Devil cantò benissimo. Io gli volevo dare uno stile un pochino più vicino quasi allo spiritual, invece lui l’ha fatta funky da morire. E il clavinet! Sono stato il primo ad averlo, sono andato in un negozio, e questo non capiva cosa fosse. Poi ha cominciato a guardare i cataloghi, e finalmente me lo hanno ordinato dall’Austria. Ha un suono che mi piace moltissimo, perché è efficacissimo, in certe cose è molto funky, su certe tonalità lo senti pieno di ironia e cattiveria».

Foto: Gabriele Micalizzi/Cesura
Stridulum, intitolato The Visitor negli Stati Uniti, non fu un gran successo, ma divenne negli anni un film di culto, tanto da uscire di nuovo al cinema del 2013 per la Drafthouse, una delle più famose case di distribuzione di film d’arte degli Stati Uniti.
Nel tema principale di Stridulum si sentono dei suoni simili allo scratch, che ancora non esisteva, fatti con il sintetizzatore. Le composizioni di Micalizzi sono state usate dai più famosi produttori e artisti dell’hip hop: Gang Starr, Tyler The Creator, Kendrick Lamar, Danger Mouse, MF Doom, Slaine, Kool G, Ill Bill e numerosi altri.
«Il primo fu un rapper americano che si chiamava Cassidy. Suona il telefono di notte, è un italiano che fa gli orologi in America e mi parla di un rapper che vuole usare un campionamento da un mio pezzo, ma non riesce a pronunciarlo bene… Afiano (Affanno, ndr). Vuole sapere se sono d’accordo. Gli dico di mandami qualcosa, che lo voglio ascoltare… All’inizio mi divertiva molto l’idea perché sentivo la novità di questa cosa, di questi che lo facevano allora. Gli afroamericani hanno cambiato la musica di questo secolo. Questi africani trasportati negli Stati Uniti a contatto con la cultura bianca hanno immesso una novità deflagrante, più di Mozart e più di Bach».
Nel 2006 Micalizzi partecipa al progetto Gli Originali, suonando con la sua Big Bubbling Band insieme ad alcuni dei migliori rapper italiani, fra cui Colle Der Fomento e Kaos.
«Il rap è una cosa nera. Ha la sofferenza, i problemi, il razzismo, la schiavitù sulle spalle: sono stato incatenato, sono stato frustato. Quando Frank Sinatra suonava, i suoi orchestrali li buttavano in un altro albergo. Sono stati oggetto di un razzismo, di una discriminazione che noi non abbiamo mai sofferto. È una musica di protesta vera. Noi invece facciamo sempre la musica per lo Zecchino d’oro oppure questi che cercano di corrompere o stupire il borghese. I neri hanno tanto da dire, ma te che c’hai da di’? De tu madre che te porta la colazione con due cornetti… Tu vivi un benessere che non giustifica tutta questa rabbia. Ma Gli Originali fu una bellissima esperienza, con la scuola dell’hip hop italiano degli anni ’90 che ancora non si era sputtanata, c’era un modo diverso di dire le cose».
Oltre alle colonne sonore, Micalizzi compone anche sonorizzazioni, colonne sonore ipotetiche che poi vengono scelte dai produttori per musicare sceneggiati o documentari per la tv, un processo creativo opposto rispetto a quando c’è un committente per un film specifico.
«Ne ho realizzate alcune. È stato un periodo molto produttivo e sono suonate benissimo. In più potevi fare quello che volevi e portavano ottimi guadagni. Nel film parti dal montaggio e ti immagini una musica. Però non devi mai uscire dalla storia, se a un certo punto c’è una scena che non c’entra nulla e ti viene da fare una musica completamente diversa, tu devi fare in modo che abbia a che vedere con il resto del film. Non puoi uscire dallo spirito di quel film quindi deve aleggiare il tuo stile, la tua poetica. Deve essere un flusso continuo. Con le library ho potuto fare musica di tutti i generi, dal minuetto alla sinfonica. Mi divertivo a cambiare genere ad ogni pezzo. Ho chiesto anche a molti altri compositori, quelli bravi, di scrivere delle cose. E sono stati felici perché le cose sono andate bene. Se li senti, non c’è un pezzo che si possa criticare».
«A volte sento dei pezzi, di cui tesso delle lodi incredibili, poi mi ricordo che è un pezzo mio, e magari sono passati trent’anni. Metti la musica nel momento giusto del film, e magari nessuno ci fa davvero molto caso. Riguardando l’azione, però, ti accorgi che alla scena mancherebbe qualcosa se non ci fosse esattamente quella musica sotto. L’horror vacui del silenzio. Ma è facile anche peggiorare la scena, ad esempio quando di musica ce n’è troppa. Oppure quando è mixata male».


Foto: Gabriele Micalizzi/Cesura
Le colonne sonore venivano incise in pochi studi di registrazione specializzati, dove si incrociavano continuamente i grandi compositori di quegli anni, che lavoravano spesso con gli stessi musicisti.
«Il Rinascimento o altre epoche analoghe non sono avvenute per caso. Vi sono delle personalità geniali che agiscono nel campo dell’arte, ma è la dimensione umana che li mette in contatto. L’arte ha bisogno di comunanza, anche di criticarsi l’uno con l’altro. Oggi con lo smart working, che facciamo anche noi artisti all’80%, abbiamo perso totalmente il contatto. Io ho bisogno fisicamente di parlare, di sentire le vibrazioni che mi arrivano addosso. Le cose che ci diciamo al telefono sono completamente diverse da quelle che diremmo se ci fossimo guardati negli occhi».
«Il genere popolare si può fare benissimo, ma oggi vedo molta provocazione, molti personaggi, molta estetica. Si creano emozioni attraverso i comportamenti distruttivi. Ma dov’è lo stile? Dove l’idea? Dov’è la creatività? Parlerei di musica con i colleghi, ma ormai non ci sono più. Quando si deve fare una riunione del sindacato compositori, si va al camposanto, e faccio presidente Morricone! Io sono un sopravvissuto ed è una cosa un po’ così, ti trovi solo e quando dici una cosa non ti capiscono, gli altri non sanno di che parlo».
«Perché? Eh, non lo so. Troppe cose mi devo chiedere. So di non sapere. Lo diceva Socrate, lo dico pure io. E l’unica verità assoluta, non sappiamo niente. Con tutto che siamo andati lontani nello spazio. Non so se capiremo mai. Io poi sono convinto che si vive sempre, la vita è già tutta fatta. Il tempo è un’illusione, perché non esiste. Quando una cosa è fatta, il tempo, il cinema, la musica formano come degli anelli come quelli del doppiaggio, per cui la scena esiste tutta già fatta. Però tu la metti davanti all’obiettivo, parti col motore e vedi che ha uno svolgimento, segui un copione già scritto. La vita è una commedia. Tu sei già codificato, e devi recitare la tua parte».