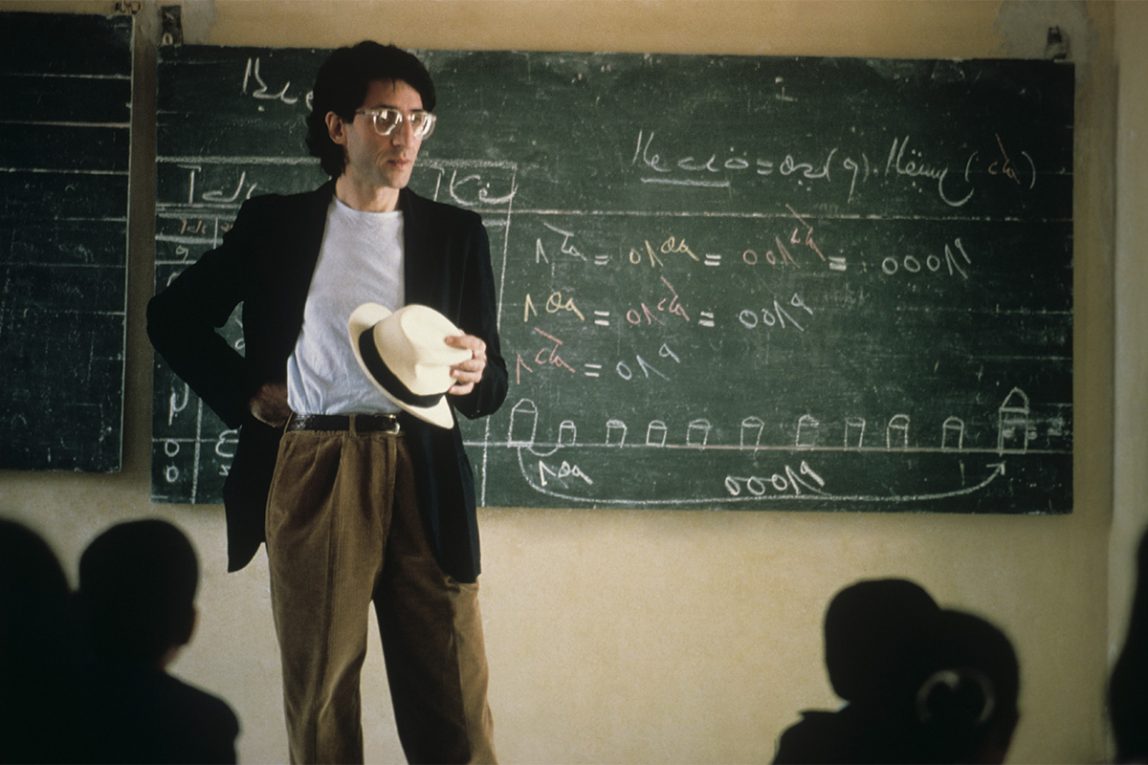Alla fine della nostra conversazione, fatta ciascuno a casa propria, Eugenio Finardi mi domanda se ho FaceTime. Gli ho appena confidato, a margine di una lunghissima chiacchierata, che sento un profonda mancanza della primavera milanese che quest’anno, come tanti, non ho potuto vivere. Attiva l’app e con la fotocamera rivolta all’esterno mi fa vedere quello che, dall’alto del suo balcone, si vede dal suo appartamento in zona San Siro, che si trova vicinissimo all’Ippodromo, e chiude la nostra chiacchierata salutandomi da un mare di foglie verdi, alberi rigogliosi e canti di uccellini sul far del crepuscolo.
Eugenio Finardi, e non lo si capisce solo dall’empatia sottile e insieme profonda di questo piccolo gesto, è un gentiluomo, lo è nei confronti della vita e dell’arte come solo sanno esserlo i lottatori, quelli che anche se il perno intorno a cui ruota la lotta, nel tempo, sembra cambiare, riescono a non perderlo comunque mai di vista e, al contempo, a non cambiare la propria indole combattiva. Il suo nuovo brano in uscita venerdì 15 maggio si intitola Milano chiama (qui sotto in anteprima per Rolling Stone), è quello che lui stesso definisce un canto di lotta contro un nemico, il virus, che non è un uomo e che ci richiama a stare tutti uniti, vicini, in grado di creare un filo che ci tenga attivi e gli uni affianco degli altri ovunque nel mondo, come in un chiamarsi e rispondersi continuo da poli opposti, tenendo ben presente un nuovo senso di comunità e una nuova libertà collettiva.
Questo nuovo pezzo, il primo di una serie scritta e composta durante il lockdown, è l’occasione per fare una lunga chiacchierata con uno dei più grandi musicisti della storia del rock italiano, anche se parlare di rock, in fondo, è nel suo caso davvero riduttivo, perché Finardi ha un’intelligenza e un approccio musicale poliedrici e ricchissimi, ha attraversato la contestazione, il rock, la sperimentazione elettronica, il jazz, e poi il fado e la classica. Una moltitudine di mondi, corrispondente alla ricchezza del suo sguardo e dei suoi interessi.
Come stai passando questo tempo a casa?
Costruendo chitarre, assemblando chitarre quasi come una disciplina zen. C’è questo strumento che adoro e che non sono mai riuscito a dominare, a fare mio perché se mi chiedi di cantare riesco anche a cantarti l’Aida a testa in giù, ma per il resto suono tanti strumenti tutti male. Dunque sono andato alla fonte, ho smontato e rimontato la mia prima chitarra, poi ho provato a costruirne una, poi ho cominciato a modificarle, sono arrivato a quell’età in cui si ha voglia di usare anche le mani, per costruire, per fare: l’homo faber, no? È come far crescere un giardino, alcuni costruiscono mobili oppure dipingono – cosa che peraltro vorrei fare un po’ anche io in queste giornate.
Questa delle chitarre da assemblare è una passione nata in quarantena o da prima?
Ce l’ho da un anno, anzi, da un anno è diventata un’attività, diciamo un hobby vero e proprio, ma diciamo che è nata dopo i 65 anni.
E come stai?
Per me, personalmente, è un periodo molto bello, certo lo possiamo dire tra virgolette, ma diciamo che questa quarantena è stata una vacanza. Non nel senso normale in cui si intende questo termine ma proprio nel senso di vacare, di svuotare. Ne parlavo col mio carissimo amico, il compositore Carlo Boccadoro: dicevamo che nel primissimo periodo di quarantena, nel primo mese, è stato difficile anche scrivere talmente tanto era il silenzio da ascoltare. Non eravamo abituati a quel silenzio, né a quell’introspezione e men che meno a quello stare continuamente tutti insieme in casa sempre, in contemporanea. Vivo con mia moglie, mia figlia, mia suocera e un golden retriever di 7 mesi che distrugge tutte le ciabatte. Siamo impegnati a mettere le scarpe dove lui non può arrivare per non farcele distruggere.
A un certo punto della tua Milano chiama dici “esser comunità nella libertà / da sempre questo è stato il mio sogno”: cosa significa essere comunità nella libertà, in questo specifico momento storico che stiamo vivendo?
Siamo stati letteralmente costretti a imparare cosa vuol dire in questo periodo. Si dice sempre che la libertà di uno finisce quando inizia la libertà dell’altro e altri luoghi comuni e la verità è che quando si è fortunati e liberi come lo siamo noi non si pensa mai veramente, poi ci si trova costretti insieme ad altri, e allora si inizia a pensarci di più.
Io ho la fortuna di essere costretto in un appartamento in cui volendo c’è una stanza per ognuno, ma so di essere davvero privilegiato e penso a chi si ritrova a condividere due locali magari standoci in nove. Ora comunque siamo tutti costretti, in qualunque condizione sociale e con difficoltà diversissime, a convivere e la nostra libertà è stata messa a dura prova; al tempo stesso siamo stati costretti a scoprirci all’altro, a convivere anche con chi magari neppure conoscevamo, tipo i vicini di casa. All’inizio della quarantena quando c’era quella cosa alle 6 di sera di mettere della musica sui balconi, io che vivo in un palazzo abbastanza isolato, ho conosciuto vicini con cui non avevo mai parlato prima. Ci parlavamo improvvisamente dalle terrazze.
Io credo che l’Italia abbia saputo dimostrare di saper avere un forte spirito comunitario in questo momento. Ora, nelle fasi che verranno, avremo una tangibile prova di cosa e di quanto significa la libertà dell’individuo singolo rispetto al resto della società. Ora verificheremo se come individui riusciremo a strutturare davvero la nostra libertà insieme a quella degli altri. Dal punto di vista antropologico e sociale è un momento interessante.
Hai la sensazione che stiamo vivendo un momento di portata storica, una cesura, un momento di vero e proprio passaggio anche rispetto alle abitudini?
Sì, negli anni scorsi c’è stato il movimento #MeToo, ha cambiato le coscienze e lo sguardo, ora guardiamo un film degli anni ’50 e ci pare incredibile vedere come veniva trattato il ruolo femminile allora e non ci si può credere. Ci sarà questo new normal in cui forse le folle smetteranno di esistere. Io per esempio, alla mia età, con la pressione alta, al pensiero di salire su un aereo non mi sento molto tranquillo, ecco.
Hai paura? Ne hai avuta?
No, all’inizio no e devo dire che non ho una paura sorda, ho la consapevolezza del fatto che ci troviamo davanti a qualcosa di molto pericoloso. La mia canzone è un canto di battaglia perché il nemico è forte e non è un uomo questa volta. E poi ci troviamo di fronte a un evento globale, la globalizzazione al suo massimo compimento: quello delle malattie. Questo ci fa anche pensare alla necessità di trovare un equilibrio tra le comunità che abitano il mondo.
Nel tuo pezzo parli anche di Bergamo, uno dei luoghi più drammaticamente colpiti dall’emergenza e la città dove hai le tue origini paterne.
Sì, Bergamo, dove ho parecchi parenti medici anziani, è l’origine del ramo italiano della mia famiglia. Nel pezzo volevo che uscisse anche una certa fierezza, sono molto fiero, passo le notti a guardare Fox, CNN, BBC, Al Jazeera e tutto quello che si può vedere in inglese ed è stato incredibile vedere com’è cambiata la percezione dell’Italia, all’inizio eravamo i soliti scemi, ora siamo il modello, ci guardano per l’esperienza acquisita.
Tu hai vissuto la musica per decenni, dagli anni ’70 a oggi e hai dunque visto modi di aggregarsi diversissimi. Come ti poni, da artista, da musicista, di fronte a quello che verrà? Se pensi ai concerti riesci a immaginare modi alternativi di viverli?
Da musicista sono naturalmente anche preoccupato per la categoria, siamo una delle categorie meno difese e più colpite lavorativamente ed economicamente, io penso ai musicisti ma soprattutto ai tecnici, a chi lavora intorno al lavoro dei musicisti: siamo tutti precari per definizione e per natura. Penso anche al teatro, al cinema, ai concerti.
Parlando di concerti devo dirti che in realtà nei decenni io ho visto un addensarsi dei corpi sempre crescente, se guardiamo i filmati di Woodstock vediamo come tutti avessero dello spazio intorno, in molti stavano seduti, ascoltavano, si cantava, si ballava, ma non esisteva quell’idea del corpo appicciato strutturalmente a un altro corpo durante un concerto. Ora se guardi il Coachella vedi questa densità incredibile. Io quando devo andare in un bar all’ora dell’aperitivo e c’è grande folla non amo farlo, mia figlia invece, che ha 20 anni, sente tantissimo la mancanza di questa abitudine dei corpi appiccicati. Io penso che con questa smania dei grandi eventi un po’ esagerando. Proprio qualche giorno fa ripensavo a Parco Lambro e mi dicevo che forse la soluzione potrebbe essere quella di riprenderci un pochino i prati e certe piccole distanze, la musica si può ascoltare benissimo anche così.
La tua quotidianità, intanto, è molto cambiata?
A me non è cambiato granché ora, sono un tipo notturno, mi piace fare la spesa alle 14 quando non c’è nessuno solo perché non posso farla di notte, una delle poche cose che mi piacevano quando stavo in USA era questa cosa di uscire di notte e andare a fare la spesa in solitudine. Una volta ho fatto la spesa alle 3 della notte di Natale, c’era questo sikh alla cassa, solo io e lui, per me era bellissimo.
Il tuo nuovo pezzo ha una voce che parte dall’Italia: tu l’Italia l’hai scelta, cantavi questa scelta in Dolce Italia, nel 1987, scritta se non sbaglio a Boston dove hai le tue radici materne
Sì, io sono una delle persone che si è mossa di meno dall’Italia in assoluto credo, avevo la mia famiglia negli Stati Uniti ma di fatto sono sempre stato qui e la più lunga migrazione che ho fatto è stata a Carimate, a 30 km a nord di Milano dove ho vissuto per 10 anni. L’America è un Paese diverso, strano, anche nel gestire le emozioni, un Paese dove si domandano “Are we dating?”. In Italia si esce e poi si sta insieme, lì è tutto molto formalizzato, anche nei riti, pensa che quest’anno è un dramma che non si faccia il prom, il ballo di fine anno. Dai, rendiamoci conto. L’Europa è proprio un’altra cosa e la preferisco, e parlo di una somiglianza europea anche tra Europe diverse: una volta ero a Key West a capodanno e sono finito in una casa con una festa solo di europei, c’erano russi, turchi, spagnoli, tutti lì insieme e non c’era nemmeno un americano, loro erano da un’altra parte. La mia dichiarazione d’amore in Dolce Italia, allora, era un po’ come quella di Cara Italia di Ghali, che secondo me è il 2.0 della mia Dolce Italia che poi era il 2.0 di Torna a Surriento.
Ti piace Ghali? E la trap?
Sì, Ghali è proprio uno che mi piace molto, e anche la trap mi piace, il rap mi infastidisce ormai perché sono diventato un po’ sordo e le parole così veloci mi scappano un po’ via. La trap, invece, ha una pulsazione, una riduzione ai minimi termini degli elementi necessari a comporre una canzone che trovo molto interessante.
Ti piace l’aspetto dei testi della trap?
Sì, mi piace proprio quella cosa lì, tipo ora stavo ascoltando Fiori di Chernobyl di Mr. Rain e mi piace molto, o Good Times di Ghali, mi piacciono i contenuti, e mi piace anche quella più dura, cattivona, con le parolacce, mi fa sorridere, mi diverte, roba tipo Trap God.
Sei d’accordo con quelli che dicono che la trap è un po’ il nuovo punk?
Mi sembra ci sia la stessa voglia di stupire, che poi è un po’ di tutte le generazioni ma alla fine io penso che dopo Iggy Pop cosa vuoi fare? Sembra un po’ tutto una ripetizione. Io cerco di ascoltare tante cose, di perdermi, alcune cose arrivano dai miei figli, altre le scopro sulle piattaforme, mi piace perdermi dentro ciò che non conosco e alla fine questo mi sembra un periodo in cui la musica in Italia è tutt’altro che ferma, mi sembra una fase per nulla vuota, in cui ci sono anche cose molto interessanti.

Finardi e il suo doppio. Foto: Francesco Prandoni/Redferns
Il pezzo ha nel titolo Milano, e Milano è sempre stata molto presente nella tua storia musicale.
Milano è il mio centro di gravità permanente, per me il centro del mondo è Piazza della Scala. Mia mamma era venuta a studiare alla Scala dagli Stati Uniti, nel dopoguerra, mio padre era un patito di musica, ho rischiato di nascere lì, mia madre era a un concerto estivo e sognava di partorirmi in loggione, poi sono nato di mattina presto e quindi nulla, ma il centro mentale del mio mondo è lì, per il resto ho avuto la possibilità di scegliere, e sono stato qui. Questa è una città che ne contiene molte, io potrei fare il tassista a Milano. Ora è una città che sta mostrando molta bellezza e molta forza.
Ne sei innamorato?
Sì, devo proprio dire di sì e poi sono proprio innamorato dell’Italia, la conosco benissimo, ho avuto la fortuna di viaggiare e scoprire questo Paese a fondo in questi anni perché sono stato in ogni angolo. Ci tengo sempre al fatto che non si confondano popolo e nazione con lo Stato italiano perché sono due cose molto diverse. Credo che come popolo e nazione siamo senza equivalenti, è come se avessimo una capitale ogni quaranta chilometri. Abbiamo una dolcezza, è proprio dolce l’Italia, una gentilezza… Pensa che ho a lungo sognato, quando passavo le estati a fare concerti, di avere con me una troupe di operatori, chessò, del National Geographic, che filmassero tutto, riprendessero quei luoghi e quei momenti. Avrebbero dovuto farlo, anche con quei gruppi tipo i Ricchi e Poveri che cantano in tutte le piazze italiane. Ora chissà quando torneremo a farlo. Due giorni fa avrei dovuto suonare in Sardegna, mi dispiace essermi perso il profumo di quelle ginestre.
Sempre a proposito di Milano, io amo il tuo pezzo, su Diesel, Si può vivere anche a Milano, impazzisco per quel momento lisergico “alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano”.
Eh sì, perché lì parlavo proprio di essere in acido alle 4 del mattino, a quell’ora all’epoca c’era pochissima gente in giro, quei versi, che forse poi ho scritto quando non era più estate, nascevano da un’immagine molto estiva, quel momento in cui d’estate inizia a finire la notte, c’è il presagio dell’alba e mentre scende la notte scende anche l’acido, il viaggio sta finendo e tutta la percezione della realtà cambia, smette di essere allucinatoria ma non è ancora completamente reale. Comunque ecco, ormai se parliamo di un mio viaggio lisergico parliamo di roba di 40 anni fa, è ora che me ne faccia un altro (ride, nda).
In questo pezzo eri stato meno esplicito ma in altri brani, come per esempio Scimmia, sei stato quasi scientifico nel raccontare la tua esperienza con la droga. Io la prima volta che l’ho ascoltata ero abbastanza piccola e ho avuto paura, mi sono proprio spaventata.
Hai avuto il giusto sentimento! Si vede che ha funzionato! L’eroina è una droga satanica, penso che sia proprio la vera espressione di satana, è ammaliante ed è il più grande pericolo. Il fatto che oggi ci sia questo nuovo boom dell’eroina è una grande delusione, perché quella è una terribile automedicazione per la depressione che poi alla fine è la causa, ed è nella causa, semmai, che c’è la cosa davvero più interessante da scoprire e sondare e cioè la mente umana. La marijuana è un’altra cosa, e se dovessi consigliare direi di farne uso tardi, diciamo dopo i 50 anni, è lì che ha senso, alla mia età ha senso… lo dice anche la Vanoni!

Foto: Fabrizio Fenucci
Viaggiando cronologicamente nella tua discografia ho la sensazione che il tuo tormento e la tua rabbia abbiano cambiato forma col tempo, forse anche sciogliendosi un po’ e trovo questo snodo nel tuo album Dal blu, che coincide con la nascita di tua figlia Elettra.
Vedi, per i samurai il sentimento più alto non è la felicità, che è effimera, ma è la malinconia consapevole perché coincide con la bellezza e con la conoscenza della sua caducità. Io sono sempre stata una persona molto tormentata e quello che chiamiamo qui tormento è in un certo senso la consapevolezza di non riuscire mai a essere “normale”, come tutti gli altri. Il primo pensiero quando è nata Elettra con la sindrome di down è stato “neppure questo mi è andato come a tutti gli altri”. Il punto è che io in qualche modo, con questo qui, con questo Eugenio, ci devo vivere sempre e a volte fa rabbia perché tu dici “io non voglio sentire queste cose, questo dolore” e invece le senti comunque. Una cosa di cui sono molto fiero è che non ho mai ceduto a facili conforti ideologici, a guru. Il mio conforto semmai è pensare: io penso, anche se a volte pensare è doloroso.
Non sei credente.
No, mai stato, mai. L’altro giorno ho cantato a mia figlia lentamente, analizzandolo, il testo di Hallelujah di Leonard Cohen ed è rimasta esterrefatta, lo cantano in chiesa… capito? Alla fine il vero conforto sono le canzoni, che ti arrivano all’orecchio quando ne hai bisogno, l’arte fa così, lo fa la musica, lo fa la letteratura: l’ha fatto Il giovane Holden e l’ha fatto Tutti Frutti di Little Richard, che se n’è andato pochi giorni fa.
E la politica? Tu hai fatto, anche artisticamente, parte del Movimento, oggi come vivi la politica e come parli di quel periodo, magari ai tuoi figli?
Oggi ripensarci e parlarne è complicato, allora come tutti ero avvolto da una semantica e da una dialettica specifiche, ora mancano proprio i termini. Per far capire come la politica fosse importante in ogni aspetto della nostra vita mi mancavano le parole per spiegarlo a mia figlia e le ho detto: “guarda, eravamo come i vegani” e lei ha detto “nooo! Così tanto?”. L’altra sera ho visto un frammento di una dichiarazione di un brigatista che stava parlando di quello che aveva vissuto e io sentivo proprio la sua difficoltà, la sua incapacità di ricostruire la forma mentis di allora, è come non riuscire a far funzionare un vecchio televisore perché non ci sono più i cavi, le valvole, i pezzi: mancano i gangli dialettici su cui strutturare il discorso.
Io comunque resto convinto per molti versi di quello che credevo allora, non sono mai stato un estremista, ero iscritto al PCI, ero considerato un estremista di destra da quelli che adesso mi considerano un estremista di sinistra. Non ho cambiato idea rispetto al fatto che un mondo più equo, più giusto, più responsabile civilmente sia necessario. Siamo troppi, ci stiamo riproducendo irresponsabilmente, stiamo distruggendo uno splendido pianeta, siamo il coronavirus del pianeta. Oggi essere rivoluzionari significa essere conservatori, cioè cercare anzitutto di conservare ciò che è rimasto di buono.
Come ti immagini questa rivoluzione?
Forse la soluzione potrebbe essere dare tutto in mano alle donne, certo, poi ripenso alla Thatcher e ho paura, ma io direi che prima di confidare nell’Intelligenza Artificiale potremmo liberarci anzitutto di tutto questo testosterone in eccesso. Credo che una certa politica viriloide, muscolare, di cui abbiamo esempi da Erdoğan a Putin, da Trump a Orban sia terrificante, aggressiva. Mi sembra di guardare dei mufloni che si incornano tra di loro. Io prima di andare a dormire guardo i documentari, ecco, loro mi ricordano questi animali che fanno la lotta tra loro e alla fine perdono tutti.
E a parte i politici mufloni, cosa ti fa rabbia oggi?
L’ignoranza della presunzione, la voglia di certezza, di assoluti, di cercare sempre un colpevole, mi fa rabbia chi non sa accettare che non sempre c’è una ragione, c’è una risposta. A me questa cosa l’ha insegnata Elettra, le cose accadono, non c’è sempre un perché, non c’è una colpa. Io penso che si debba iniziare a capire che l’irrisoluzione è la soluzione.
Come pensi al domani?
Io ho sempre vissuto con molta fretta e ora ci penso con paura perché è chiaro che il tempo che ho davanti è sempre meno. Ho sempre avuto fretta che arrivasse domani, anche la mia musica è sempre così, è sempre un po’ con le battute in avanti: se ascolti Pino Daniele lo senti com’è placido, io sono incalzante. Ora penso a tutta questa fretta, respiro e mi dico: va beh, cosa voglio fare? Costruire Stratocaster! Posso farlo e allora lo faccio. Vorrei avere un orto, ma per quanto nel verde io vivo a San Siro quindi niente, se comunque mi chiedessero se preferirei avere una gran villa al mare o una cascina con quattro cani e un orto, io vorrei proprio quella cascina e quell’orto che non avrò mai.