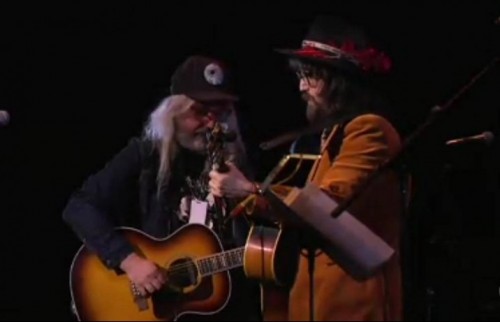Ho incontrato Cat Power la prima volta sei anni fa, per l’uscita di Sun. Ricordo quel giorno perfettamente, non soltanto perché lei era e rimane una delle mie artiste preferite, ma perché era la prima intervista che facevo per Rolling Stone. Quello che non immaginavo — a sei anni di distanza — è che anche lei si ricordasse di me. «Ci siamo già incontrate», mi dice, appena mi vede, «avevi i capelli più lunghi, però». È vero, ma temo comunque mi stia confondendo con qualcun’altra. Per fugare i miei dubbi aggiunge: «Stavamo in quel posto strano, rumorosissimo…». Era il Magnolia, a Milano, c’era il sound-check del Teatro degli Orrori. «E poi c’era quel ragazzo molto carino, tutto tatuato». Su questo i ricordi non coincidono, o forse non abbiamo gli stessi gusti in fatto di ragazzi carini.
Stavolta l’intervista è al negozio della Gibson a Berlino, siamo circondate da chitarre appese ai muri. Prima di cominciare, tira fuori dalla borsa una boccetta e comincia a cospargersi con una specie di unguento. «Lo fanno dei miei amici, a New Orleans, è un profumo al CBD. Lo sai che i cannabinoidi che stanno nella marijuana sono gli stessi che si trovano nel latte materno? Non è affascinante?». No, in efetti lo sapevo. Si rilassa sul divano con un sorriso che sembra tradire un effetto da cannabinoidi già all’opera.

Il tuo ultimo album, Wanderer, arriva dopo sei anno da Sun e sembra molto più vicino ai tuoi esordi: un sound minimale e un songwriting intimo. Come ci hai lavorato?
Sono cambiate molte cose in questi anni, sono stata male e ho fatto un figlio. Prima mi spostavo molto, mi portavo anche dietro l’attrezzatura per registrare, perché i pezzi nascono così, a un certo punto c’è qualcosa che interrompe la tua routine, senti una specie di fame, ed è insaziabile, una voce che ti dice: “Ehi, stop, sono qui, ascoltami!”. Allora mi metto alla chitarra, e cerco di ricordare quello che ho sentito. Lo provo un paio di volte, se riesco a farlo anche una terza vuol dire che la canzone c’è. Ma quando mio figlio aveva due mesi ed ero in tour, ho cominciato a capire cosa significasse essere madre, ho sentito il corpo che cambiava, che rispondeva alle sue esigenze. Per questo album ho affittato uno studio, l’ho chiamato la Pink House, è stato un processo più lento, più sedato.
Dov’era lo studio?
A Miami. Ci ho lavorato con un ingegnere del suono che viveva a Parigi, ci siamo visti a intermittenza, quando lui poteva e tra le poppate di mio figlio. La prima che ho scritto nella Pink House è il lamento su Woman, che è poi diventato l’ultimo pezzo su cui ho lavorato. Appena ho avuto il materiale, l’ho spedito a Los Angeles alla mia ex-etichetta ma loro, dopo Sun, volevano un disco di hit. Questo non è un disco di hit, non l’hanno amato, non lo volevano così. Avevo pure messo in mezzo un amico a farmi da intermediario, da manager, era un ex giornalista degli anni ’70, ha scoperto Fiona Apple, è stato a capo di un’etichetta importante, insomma era uno che ci stava dentro… È stato doloroso scoprire che non era amico. Ho dovuto proteggere me stessa, il mio lavoro, ma ho capito una cosa: che io sono un’artista e loro no.
E invece Sun è un disco in cui non ti riconosci più?
Assolutamente no, amo quel disco. Ci ho buttato il sangue. Ho fatto tutto io, ogni cazzo di suono, a parte un pezzo di batteria e una linea di basso. Ma il resto è tutto mio. Soltanto che ora stavo andando in un’altra direzione.
E quindi come è andata con la tua ex-etichetta?
Sono arrivata a Los Angeles per mixare con Rob Schnapf – una bellissima persona – e ho cominciato a cantare questo pezzo che avevo provato al sound-check in un festival a Santa Barbara, perché l’avevo sentito in taxi mentre andavo lì e mi aveva proprio fatto piangere. Era Stay di Rihanna. Così un paio di giorni dopo la provo con Rob nello studio. E lui la registra e mi dice: “Beh, adesso che ci facciamo?”. Gli avevano chiesto di lavorare in un certo modo, senza nemmeno dirmelo. Ma io volevo passare ad altro. Non vado in studio solo a mixare, per me è ancora tutto fluido in quel momento. Così mi sono messa al microfono per provare a cappella Wanderer. È legata alla morte di una persona cara, non ero sicura che sarei riuscita a cantarla, infatti non mi uscivano le parole, facevo solo: “Mmmmm”. È lì che ho capito che loro si aspettavano tutt’altro.
A questo punto bussano per portarci delle birre, andiamo alla finestra a fumare e lei mi guarda le mani: «Hai l’accendino abbinato all’anello». Ho un anello con un cameo e un accendino arancione. «Anch’io avevo un anello con un cameo, tanti anni fa, l’avevo preso a Capri, era ricavato da una scatoletta di sardine e poi c’era questa pietra incastonata…», mi dice. Fa una pausa: «La pietra però è caduta». Sembra quasi dispiaciuta al ricordo, come se il distaccarsi di una pietra avesse una portata più vasta dell’aneddoto in sé. «L’avrò pagato un paio di dollari, è assurdo quanto tempo è passato da allora, ero una ragazzina…».
Hai detto che sei stata male, ora come stai?
Sì, esatto. Riavvolgiamo il nastro verso il fallimento totale. Mentre ero in tour per Sun, con tutta la pressione arrivata da quel disco, ho passato un anno a combattere in segreto contro questo male, il sistema immunitario è andato in tilt, avevo un problema all’esofago, alla lingua…
Temevi che non saresti più riuscita a cantare?
No, pensavo proprio che sarei morta. Ero gonfia di steroidi. Ho dovuto cancellare dei concerti, la mia ex-etichetta ha smesso di investire su di me. Mi sono ritrovata da sola. Poi ho cominciato a interessarmi del movimento di Occupy, di cose che non avevano a che fare con la musica. Avevo una relazione, la relazione è finita, e ho scoperto di essere incinta. E lì si è presentata una scelta: continuare a seguire il movimento o scegliere di diventare madre. Ho scelto la seconda cosa. Ho cominciato una cura omeopatica e sono stata meglio e quando mio figlio aveva due mesi ho buttato giù i primi pezzi di questo album. Poi arriva tutto quello che ti ho già raccontato, la mia ex-etichetta che mi chiede un album diverso, io che non voglio cambiare niente.
Per quello che vale, ho amato tantissimo questo disco. Anche tu sei riuscita a farmi piangere, per fortuna non in taxi, ma direttamente a casa.
Sì? Evvai! (Mi batte il cinque, nda) Su che pezzo?
Su Me Voy…
Mi piace molto quella canzone. Perché ti ha fatto piangere, ti sei riconosciuta?
Non so, forse. Probabilmente in tutto l’album, in questa dialettica impossibile tra il bisogno di una casa e la voglia di lasciarla, di andarsene…
Bene, ho fatto un ottimo lavoro allora (ride).

E l’immagine di copertina come è nata? E’ tuo figlio nella foto?
Sì. Faccio io l’art cover degli album, ma come per la musica, c’è sempre una componente estremamente fisica, lavoro con le mani, con il corpo, non sono un’artista concettuale. Dovevo suonare per il memoriale di un amico e volevo mettermi un vestito appropriato. Non sono abituata ai vestiti da femmina e insomma, volevo che mi stesse bene. Lo stavo provando allo specchio, c’era mio figlio nella stanza, era piccolo ma capiva la realtà dello specchio, per cui mi ha visto e voleva entrare anche lui in quell’immagine riflessa. Avevo la chitarra appoggiata lì vicino, lui si è aggrappato alla chitarra e a un certo punto ho realizzato che avevo questi tre elementi nel quadro: la forza che è la chitarra, l’amore che è mio figlio, e il vestito che sono io, la mia anima, perché quel vestito aveva un significato particolare per me.
Be’, però questa è una spiegazione da artista concettuale…
Okay, sì, ma ci arrivo dopo. Quando devo spiegare le cose. Se mi va di spiegarle, anche a me stessa. Ci sono cose che scopro sulle mie canzoni quando ne parlo, e lì si crea un’altra connessione. È per questo che continuo a suonare, per le persone che riescono a connettersi a quello che faccio. L’arte per me in definitiva non è altro che questo: creare una connessione di cui nemmeno tu eri cosciente.