Che siano già passati quarant’anni dall’uscita del primo album dei Depeche Mode è uno di quei dati di fatto che, prima di essere accettati, necessitano almeno di un rapido controllo su Google. La loro musica, la loro iconografia e il loro look hanno infatti contribuito, in dosi e in forme diverse, a far sì che siano sempre stati percepiti come una band moderna. Volendo riderci un po’ sopra, si potrebbe riesumare un meme che girava qualche anno fa, e che sottolineava che, a dispetto delle apparenze, Dave Gahan è otto anni più vecchio di Angelino Alfano.
Mettere in ordine di preferenza i loro quattordici album in studio significa ripercorrere una storia che, tra cambi di formazione e di suono (in entrambi i casi pochi, ma molto significativi), ha sempre fornito ai fan più di un motivo di interesse, ispirando inoltre altri musicisti diversissimi tra loro. Basti pensare alle centinaia di cover incise in questi anni: dai Bluvertigo a Johnny Cash, da Marilyn Manson ai Rammstein.
14. “Exciter” (2001)

Prodotto da Mark Bell, già al lavoro su Homogenic di Björk, rappresenta l’inizio della fase “conservativa” dei Depeche Mode, bravissimi a gestire quanto di buono fatto nei precedenti vent’anni di carriera. Qui mancano le canzoni memorabili, i groove che fanno muovere, le piccole grandi novità sempre presenti nei loro album. Il pubblico però continua a premiarli, soprattutto garantendo il tutto esaurito a cinque mesi ininterrotti di concerti, durante il quale la band conferma la scelta di presentarsi sul palco con un vero batterista, così come avvenuto durante il Singles Tour, greatest hits dal vivo andato in scena tre anni prima.
13. “Sounds of the Universe” (2009)

A venticinque anni di distanza da Some Great Reward, Martin Gore riporta in studio drum machine e sintetizzatori analogici: sembra un deciso ritorno al passato. Non è un difetto, anzi. Però si fa fatica a ricordarsi quali sono i brani contenuti nella scaletta, ecco spiegata la posizione decisamente bassa occupata in questa classifica. Nel relativo tour (che per la prima volta li vede esibirsi a San Siro e all’Olimpico di Roma) i Depeche includono solo la metà dei pezzi. Ai fan l’album piace: numero uno in ventuno Paesi, secondo posto in Gran Bretagna e terzo negli Usa.
12. “Delta Machine” (2013)

Ben Hillier è confermato alla produzione per il terzo album consecutivo, registrato tra New York e Los Angeles e mixato a Londra da Flood. Il principale difetto del disco, di nuovo, è la mancanza di pezzi che si fanno ricordare, quelli che diventano irrinunciabili dal vivo e che mai verrebbero esclusi dalla scaletta di un eventuale greatest hits. Un difetto non da poco per una band come i Depeche Mode, la cui storia è fatta anche e soprattutto di grandi singoli pop. Basta andare a un loro concerto per accorgersi che le nuove canzoni vengono accolte in maniera a dir poco tiepida rispetto ai classici di una carriera ultratrentennale.
11. “Spirit” (2017)

Cambia il produttore, stavolta è James Ford, ma non la sensazione di inaridimento della vena creativa di Martin Gore, che decide di prendersela con la politica (vive negli Stati Uniti, dove l’anno precedente Trump ha vinto le elezioni) e di sostenere istanze ambientali. “Le nostre anime sono corrotte, le nostre menti sottosopra, le nostre coscienze sono in bancarotta, siamo fottuti”, si ascolta nella conclusiva Fail, che secondo quanto dichiarato da Gore al magazine Classic Pop riassume il mood dell’album. «I Depeche Mode diventano seri e politici», scrive sull’Independent Andy Gill (solo omonimo del fondatore dei Gang Of Four), «ma è una cosa che non gli si addice». In realtà il problema sono le canzoni, da troppo tempo lontane dagli standard degli anni ’80 e ’90.
10. “Playing the Angel” (2005)

Primo album dei Depeche Mode contenente anche pezzi scritti da Dave Gahan, reduce dal suo debutto da solista Paper Monsters. Prodotto da Ben Hillier, già con i Blur di Think Tank, è forse il miglior album dei Depeche Mode post 2000, premiato anche da diversi numero uno in classifica, Italia compresa. Rispetto al precedente Exciter, la qualità delle canzoni è decisamente migliore, grazie soprattutto a un sound non più monocorde. Precious è l’ultimo grande singolo dei Depeche Mode. Affidato alla voce di Gahan, racconta il dolore di Martin Gore nello spiegare ai figli la scelta di divorziare dalla loro madre.
9. “Speak & Spell” (1981)

L’album d’esordio dei Depeche Mode è anche l’unico che può contare sulla presenza del fondatore Vince Clarke. Il gruppo lavora all’insegna del contenimento dei costi su un otto piste dei Blackwing Studios di Londra, con un sintetizzatore analogico che Daniel Miller presta al gruppo destinato a diventare il più grande successo commerciale della sua Mute. Per sincerarsi che il suono sia ok, i Depeche Mode mettono la cassetta con l’album finito in un’autoradio non proprio nuovissima. Se si sente lì, andrà benissimo anche altrove. Di sicuro va bene in classifica (numero 10 in Gran Bretagna) e anche la critica non ha particolari appunti da muovere («È così che dovrebbe suonare l’onesto synthpop», scrive Hot Press a proposito del singolo New Life). Rispetto ai lavori successivi è un album più leggero, con arrangiamenti meno curati e meno voglia di sperimentare, ma si fa decisamente perdonare grazie al suo gusto pop. Un esempio su tutti: il singolo Just Can’t Get Enough, destinato a diventare uno dei classici della band.
8. “A Broken Frame” (1982)

Martin Gore subentra a Vince Clarke nel ruolo di songwriter. «Si lavorava in modo diverso», spiega Daniel Miller nel libro ufficiale della Mute. «Vince aveva idee molto chiare sugli arrangiamenti, mentre Martin portava solo un abbozzo di canzone, che prendeva forma con la collaborazione di tutti». Dopo averli visti live al Rafters di Manchester, un ancora sconosciuto Morrissey scrive su Record Mirror: «Non saranno il gruppo più noioso di tutti i tempi, ma certamente ci vanno vicino». Ancora meno diplomatico Paul Weller, che su Melody Maker descrive così l’ascolto di Leave in Silence, il brano di apertura: «Ho sentito più melodia arrivare dal buco del culo di Kenny Wheeler». In realtà, all’interno della discografia dei Depeche Mode, A Broken Frame è un album di tutto rispetto, nel quale un pop affine a quello di Speak & Spell (The Meaning Of Love) sfuma in una malinconia che farà sempre parte della musica della band (See You). La copertina di Brian Griffin, ispirata a un dipinto del pittore russo Kazimir Malevich, dieci anni più tardi finirà addirittura sulla copertina di un supplemento di LIFE dedicato ai migliori fotografi degli anni Ottanta.
7. “Ultra” (1997)
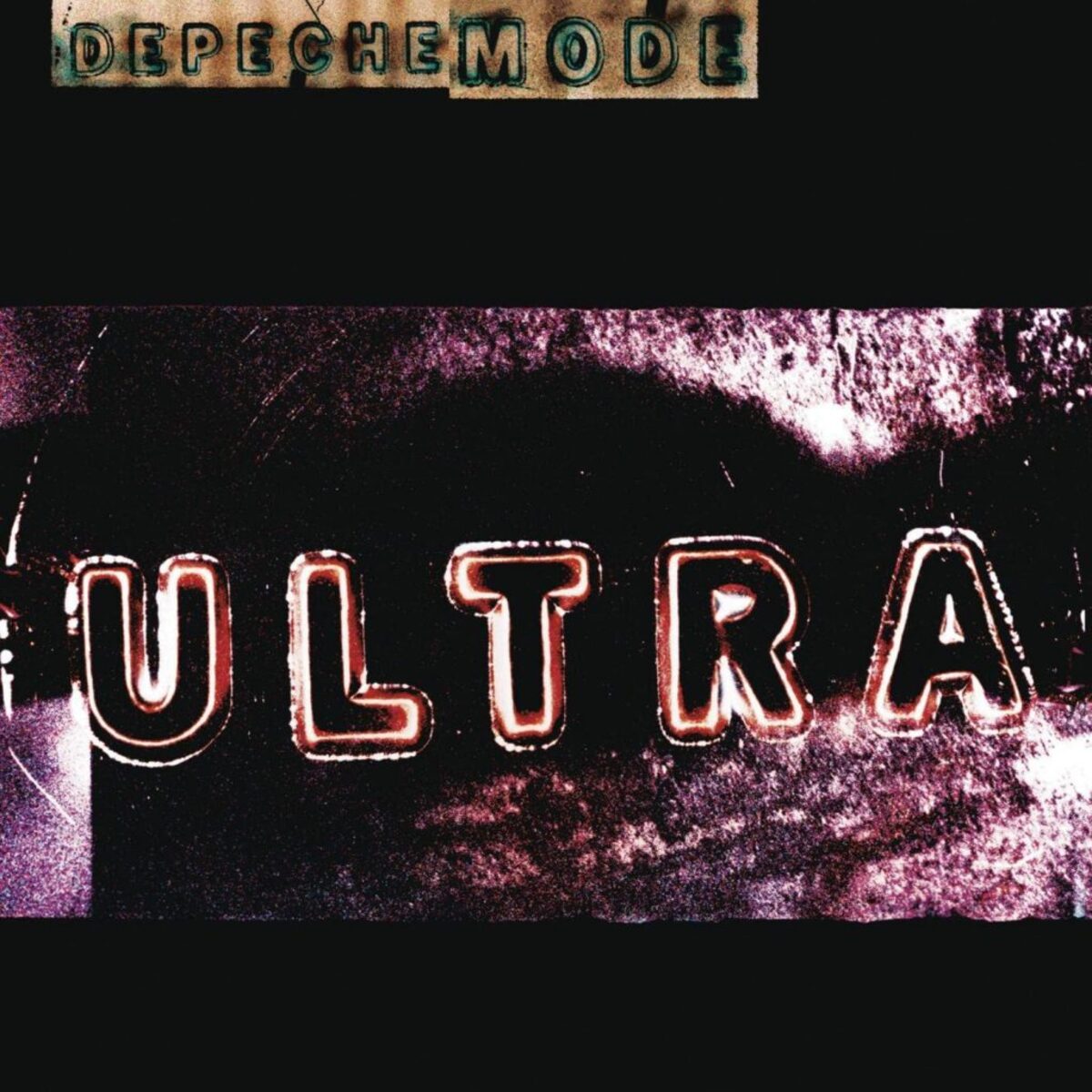
La scelta di Tim Simenon (Bomb The Bass) come produttore è il frutto del desiderio di tornare all’elettronica e far ballare il pubblico. Le premesse non sono delle migliori: Alan Wilder se n’è andato e soprattutto Dave Gahan ha rischiato le penne a causa di un’overdose. «Erano fragili e nervosi», racconta Miller su Monument (Arcana), «è un album di transizione, sia per quanto riguarda le loro vite sia per la struttura della band, che era composta da tre e non più da quattro persone». Sarà anche un album di transizione, ma è un ottimo album, l’ultimo dei Depeche Mode che può dirsi tale, grazie a pezzi splendidi (ascoltare la dolcissima Home e il groove di Useless per credere). In studio vengono chiamati diversi musicisti esterni. Su The Bottom Line, per esempio, si ascoltano la pedal steel guitar di BJ Cole e Jaki Liebezeit, il leggendario batterista dei Can. Memore degli sconquassi del tour precedente, per la prima volta la band decide di non far seguire concerti all’uscita del disco.
6. “Construction Time Again” (1983)

Registrato ai Garden Studios di Londra e mixato agli Hansa di Berlino, è il primo album che vede la presenza di Alan Wilder, diventato membro ufficiale della band dopo un inizio come turnista in sostituzione di Vince Clarke. È lui stesso ad acquistare di persona i campionatori digitali che permettono alla band di trasformare in musica i rumori registrati, in particolare quelli di oggetti metallici percossi. La tecnologia diventa quindi parte integrante del processo creativo, con un Martin Gore che, ispirato dal suono industriale degli Einstürzende Neubauten, tenta di darne una versione ultraleggera. Decisamente più cupo dei suoi predecessori, contiene comunque sprazzi di quel pop che rappresenta la migliore caratteristica della band: nella scaletta spicca Everything Counts, uno dei pezzi accolti con più entusiasmo dai fan anche durante l’ultimo tour. E a proposito di concerti, per la prima volta la band si esibisce in Italia, il 5 marzo al Teatro Tenda di Bologna e il giorno successivo al Teatro Orfeo di Milano.
5. “Music for the Masses” (1987)
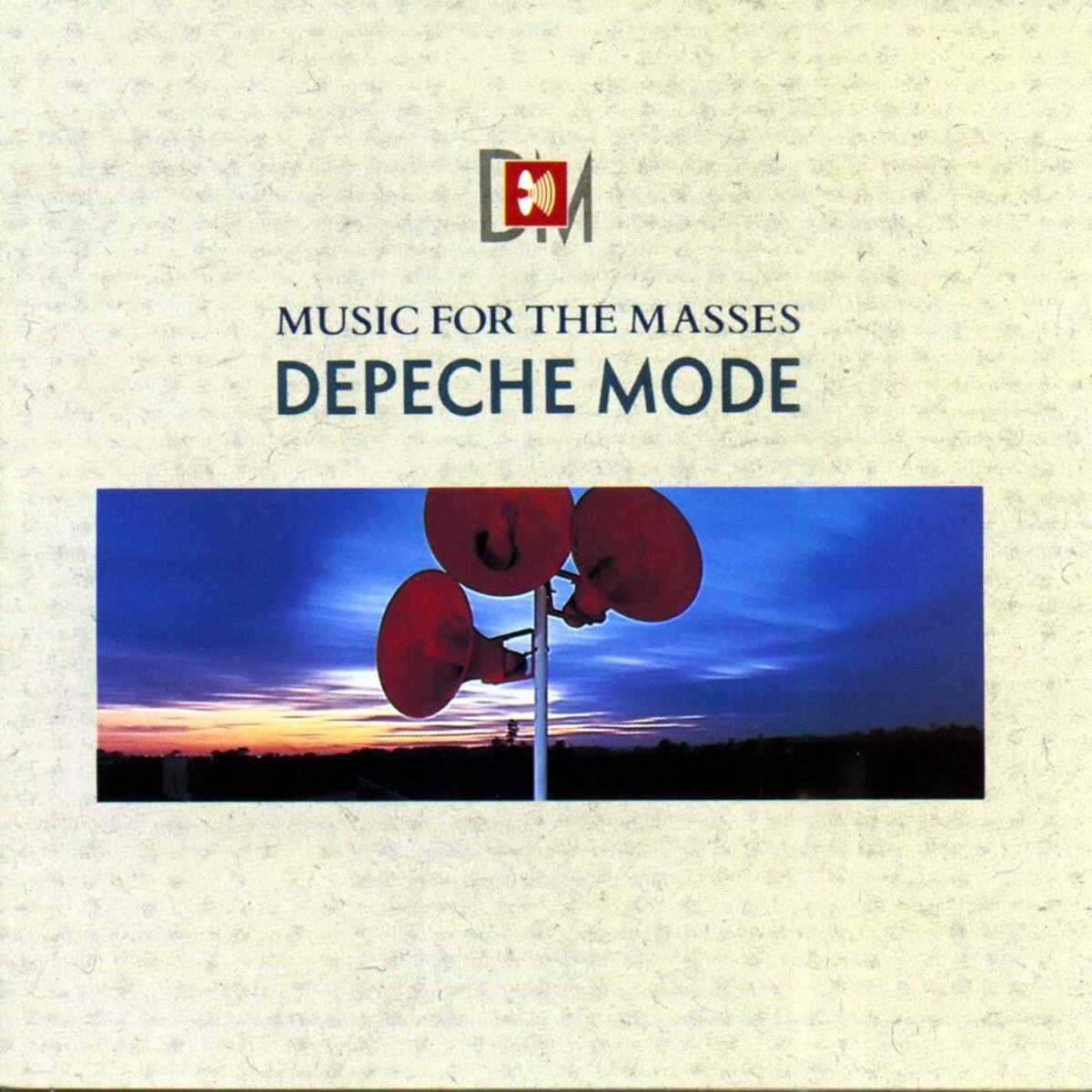
L’album con il quale i Depeche Mode iniziano la loro transizione verso un suono e un’immagine da rock band, sia pur decisamente atipica. Daniel Miller lascia i controlli a David Bascombe, già al lavoro su Songs from the Big Chair dei Tears For Fears. Le chitarre, benché rielaborate, non sono mai state così presenti e il risultato finale parla di un disco lontano da un ideale podio Depeche Mode, ma sicuramente fra i più importanti in quanto punto di svolta nella storia del gruppo. Come il precedente Black Celebration, la sensazione è quella della ricerca di un’omogeneità lontana dal pop del passato. Brillante eccezione la Never Let Me Down Again posta in apertura, futuro caposaldo dei live della band.
4. “Black Celebration” (1986)
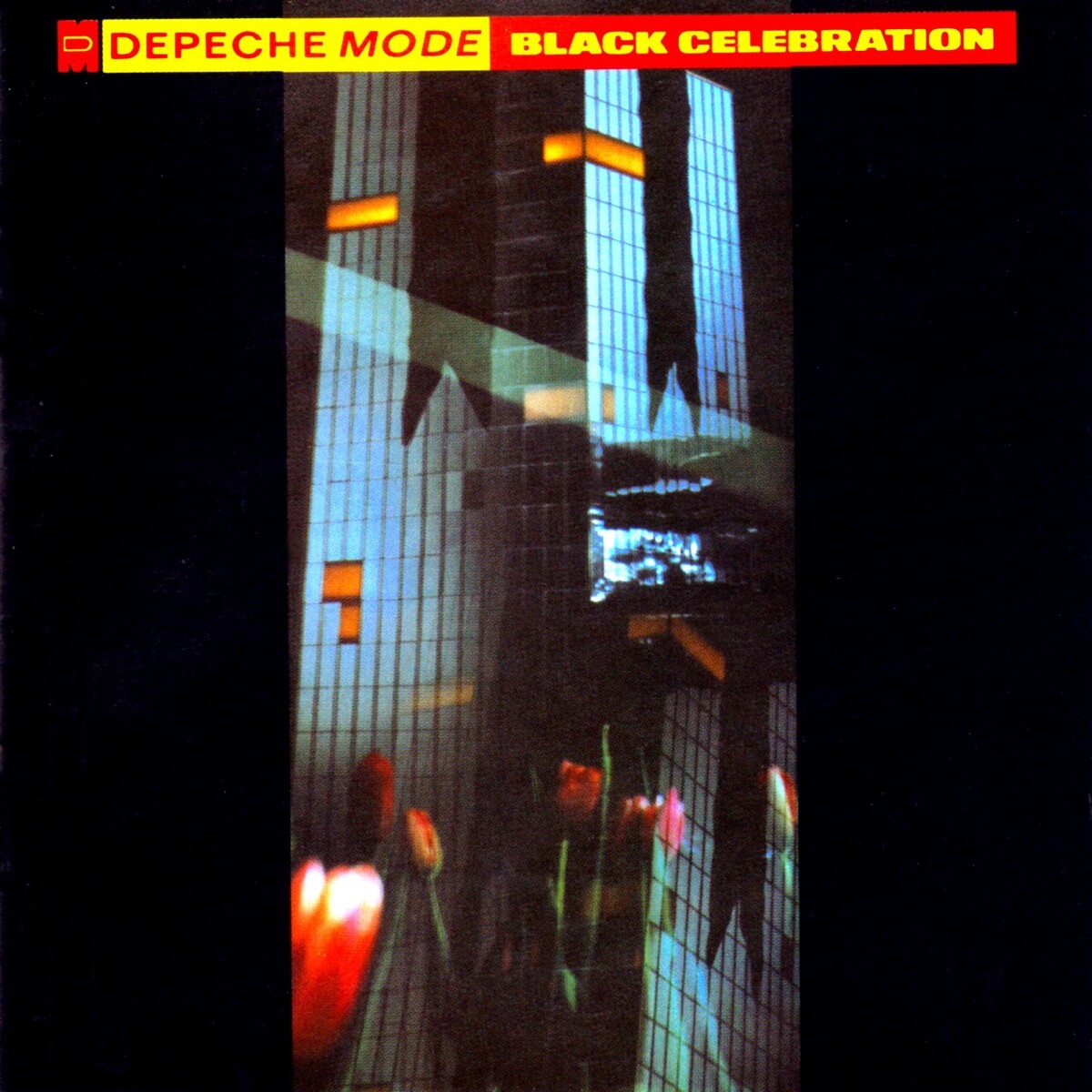
Nonostante un numero contenuto di brani spiccatamente da classifica, diventa l’album più venduto nella storia della band. Se il precedente Some Great Reward era molto vicino a una raccolta di singoli, Black Celebration è decisamente più compatto, un flusso di canzoni che è un peccato separare l’una dall’altra, un album che ancora oggi suona assai bene. I Depeche Mode affidano il video di A Question of Time ad Anton Corbijn, che da qui in poi giocherà un ruolo sempre crescente nella definizione della loro immagine, occupandosi di copertine, videoclip, palchi e visual dei concerti. Da Violator (1990) in poi qualcosa di molto simile all’essere di fatto il quinto membro del gruppo. Nonostante l’aria crepuscolare dell’album, la band è protagonista di un breve tour estivo italiano che li porta a esibirsi nei piccoli stadi di due località balneari: il 5 agosto a Pietra Ligure e il giorno successivo a Rimini.
3. “Some Great Reward” (1984)

I Depeche Mode tornano agli Hansa Studios e si affidano in qualità di coproduttore a Gareth Jones, che nello stesso periodo sta lavorando alla realizzazione di Halber Mensch, terzo album degli Einstürzende Neubauten. «Feci conoscere ai Neubauten i sequencer e i campionatori, e utilizzai parte del lavoro che avevo fatto con loro per esaltare alcuni dei suoni e delle melodie dei Depeche», spiega in Monument. Con questo album Alan Wilder diventa di fatto una sorta di produttore interno alla band, lavorando al fianco di Daniel Miller e dello stesso Jones. Dichiarazione di intenti un po’ naïf ma quanto mai adeguata ai tempi della Guerra Fredda, People Are People raggiunge il quarto posto delle classifiche britanniche, fino a quel momento il miglior piazzamento in assoluto della band. Ma un po’ tutte le canzoni rappresentano l’evoluzione in chiave pop del lavoro sui suoni intrapreso l’anno precedente con Construction Time Again.
2. “Songs of Faith and Devotion” (1993)

Dave Gahan abbandona la sua famiglia e si trasferisce a Los Angeles, gli avvistamenti nei locali lo danno appassionato di grunge e fan dei Jane’s Addiction. Tatuaggi, capelli lunghi e un pericoloso interesse per le sostanze stupefacenti. Reduce dal lavoro su Acthung Baby degli U2, Flood viene confermato nel ruolo di produttore, ma le session sono agitate. Per la prima volta la band utilizza turnisti per arricchire il suono, che siano gli archi di One Caress, le voci gospel di Get Right with Me o le uilleann pipes di Judas. Il risultato è l’album più rock dei Depeche Mode, per certi versi il migliore della loro carriera, grazie a canzoni che sono sì singoli da classifica (I Feel You e Walking in My Shoes) ma anche tessere di un mosaico che inquieta e trascina. Anche la critica rock italiana, che fin qui li ha sempre un po’ snobbati classificandoli come commerciali, si accorge di loro. Oltre alla sempre più frequente presenza sul palco della chitarra di Martin Gore, il turbolento tour che segue vede per la prima volta una vera batteria sul palco, suonata per alcuni dei brani da Alan Wilder, che al termine dei concerti lascerà la band.
1. “Violator” (1990)

Il disco con cui, cambiando per diventare qualcosa che non erano mai stati, i Depeche Mode riescono a piacere a tutti: fan del techno pop della prima ora e classic rocker, seguaci del dark e alternativi indie. Le vendite vanno alle stelle: per la prima volta superano il milione di copie sul mercato americano. Che qualcosa di grosso bollisse in pentola lo si era capito già dall’uscita del primo singolo Personal Jesus, con la sua struttura blues appoggiata sulla chitarra di Martin Gore. Come disse lo stesso produttore Flood: sono i Depeche Mode, ma non quelli che conoscete. Johnny Cash ne darà un’interpretazione memorabile, forse superando l’originale. Enjoy the Silence, il secondo singolo, stupisce di meno ma incanta anche grazie al video di Anton Corbijn, ispirato al Piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Anni dopo, quello stesso video sarà l’ispirazione per Viva La Vida dei Coldplay, che affideranno allo stesso Corbijn uno dei video della loro canzone. Ma è tutto l’album a rappresentare una summa, mai più superata, dell’opera di una band unica nel suo modo di coniugare aspirazioni da classifica e introspezione, coerenza e ricerca.
















