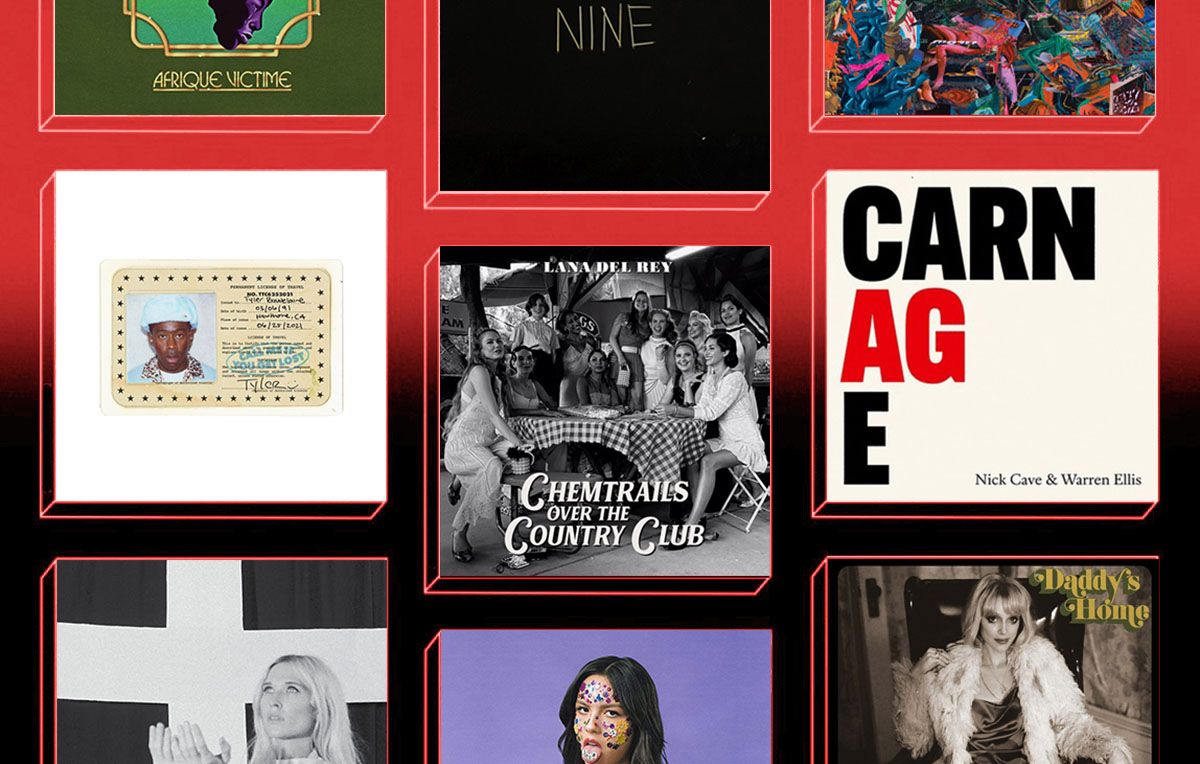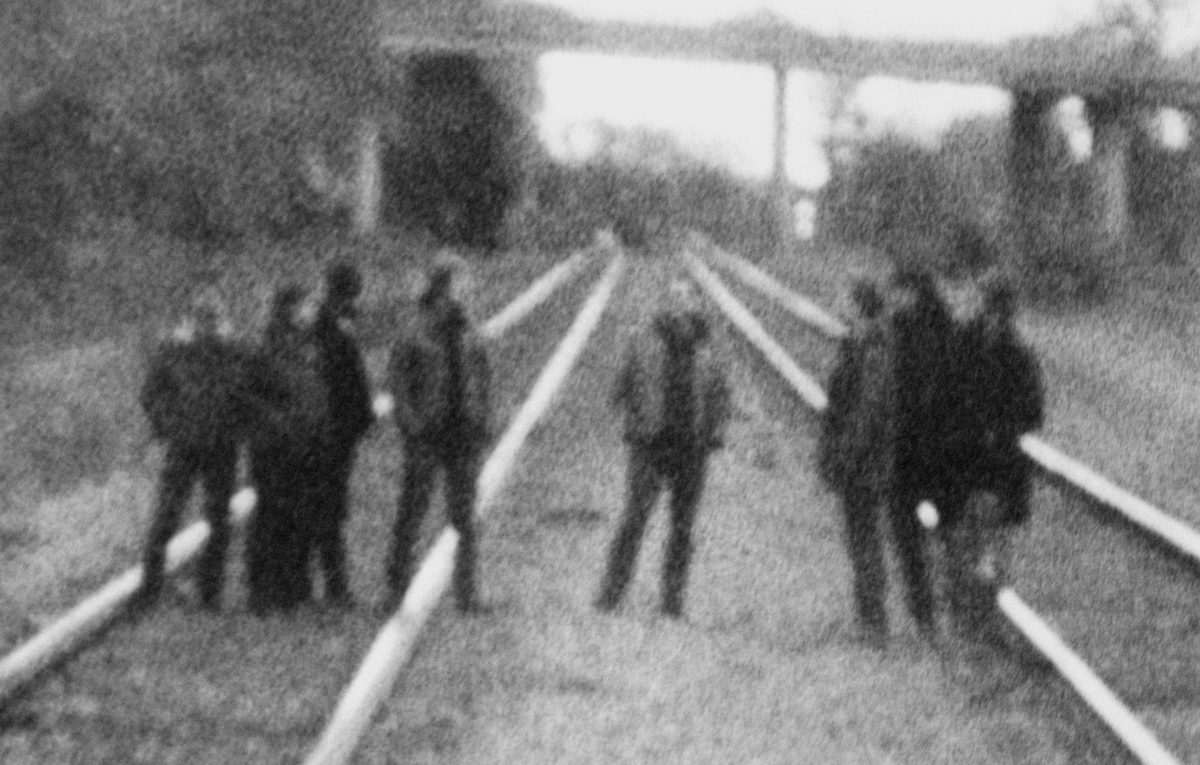Si avvicina l’inverno, e con l’inverno torna la voglia di post rock. Sì, perché mai genere musicale è stato, per me, più vicino al freddo, alla neve, alla pioggia, alle giornate corte e buie. Forse dipenderà dal giorno in cui ho comprato il mio primo album post. Piovigginava e tirava un gran vento gelido, il mare era in burrasca, il cielo era rossastro, minacciava neve. Ma io ero andato lo stesso nel negozio di dischi aperto fino a notte fonda, nel porto antico di Genova. Si chiamava semplicemente Music Store, un luogo pieno zeppo di CD (i vinili all’epoca non li voleva nessuno) sparsi in due piani. Era il 1999.
Avevo scoperto da poco che esistevano band che suonavano qualcosa di nuovo, di diverso, di difficilmente catalogabile. Musiche che trovavano riparo dietro la sigla post rock. Nel negozio avevano allestito un angolo tutto dedicato a band di quel genere. Non ho mai capito chi dei commessi fosse l’appassionato, so però che in quel periodo questo post rock aveva fatto discutere parecchio. C’era internet, ma non ancora quella dimestichezza di oggi nell’affidarsi totalmente alla rete, almeno per me. Preferivo spulciare come un ossesso le riviste specializzate. Avevo letto dei nomi: Tortoise, Godspeed You Black Emperor!, Rachel’s, Don Caballero. Non avevo ascoltato nulla di tutti questi, vedevo solo piccole stampe delle copertine e descrizioni che facevano intuire tutto e il suo contrario. Abbastanza da incuriosirmi.
Alla fine comprai un CD dei Tortoise, tornai a casa, ascoltai e rimasti parzialmente deluso. Non so cosa mi ero aspettato, ma c’era qualcosa che non riuscivo ad afferrare. Per me, abituato al prog, parevano come un “vorrei ma non posso”. Però… però… Rispetto al prog qui il modo di suonare era diverso, più asciutto, fresco, aperto a sfumature diverse: ambient, elettronica, wave, dub, minimalismo, trip hop, kraut. Un sacco di roba. Alcuni mi avevano detto che questo post rock era il prog di chi non sapeva suonare. A me la cosa stuzzicava, anche io non ho mai saputo suonare, ma comunque suono, mi piace chi sa mettere le idee sopra ogni menata. E di idee ce n’erano eccome in quella musica, così irta di ostacoli e per nulla carezzevole. Mi diceva qualcosa, volevo entrarci a tutti i costi. Come tutte le cose difficili che con impegno riesci a penetrare, perché pensi ne varrà la pena, alla fine me ne innamorai perdutamente.
Mi documentai ancora di più, scoprii che il termine post rock era stato coniato da Simon Reynolds per riferirsi a gruppi come Stereolab, Seefeel, Bark Psychosis… ma ci sarebbe stato da andare più indietro e scomodare anche i tardi Talk Talk, addirittura certe astrazioni care al Miles Davis elettrico. I gruppi che cercavo erano tutti provenienti dal Nord America, Stati Uniti e Canada, luoghi dove il genere aveva attecchito in maniera particolare. Nei primi anni ’90, mentre negli States imperversava il grunge, una massa di giovani introversi – di un’introversione diversa da quella grunge, più tesa al nerdismo, spesso provenienti dal punk e dall’hardcore – scopriva i King Crimson e il krautrock. Si chiudevano nei garage a suonare come dei pazzi, a sperimentare, a buttare giù un’idea nuova di musica con lunghi brani spesso strumentali, nessuna attenzione per l’apparire o il far spettacolo, chiusi, muti, a occhi bassi, scontrosi e geniali. Era la musica delle grandi nevicate che coprivano tutto il paesaggio desolato, nel silenzio assoluto. Il suono delle stazioni di rifornimento perse nella nebbia, delle ferrovie abbandonate, delle fabbriche dismesse, di tutti i non-luoghi che alla fine erano la zona di tarkovskiana memoria.
Ed eccoli, questi sono i dischi che mi hanno stregato, una bella informata in 10 posizioni di introversi nordamericani. Ci sarebbero anche gli inglesi da tirare fuori, in primis i Mogwai e poi molti altri, anche gli italiani hanno detto cose egregie. Ma intanto beccatevi questi, poi semmai ne riparliamo.
10. “When in Vanitas…” Brise-Glace (1994)

Con dentro due personaggi che faranno la storia del post: Jim O’Rourke (polistrumentista dal milione di progetti e metà dei Gastr Del Sol) e Thymme Jones (batterista che formerà i fighissimi Cheer-Accident). Brise-Glace, ovvero rompighiaccio in francese, è follia kraut di stampo Can, con improvvisazioni dal vivo in studio e O’Rourke che va a modificare le registrazioni come un George Martin al manicomio. I 24 e passa minuti di One Syntactical Unit sono manifesto della stasi più assoluta, della ripetizione fino a una noia che diventa sublime e infine del delirio.
9. “2” Don Caballero (1995)

Con i Don Caballero – da Pittsburgh, Pennsylvania – nasce il cosiddetto math rock. Sorta di virtuosismo punk in strutture perfettamente codificate e cicliche, una specie di minimalismo post rock con cambi di tempo a tutto spiano e un altare a Robert Fripp. In 2 tutto è perfezione strumentale per niente cervellotica, con quel pizzico di sangue che il Fripp a volte lascia a casa. Le chitarre di Ian Williams (poi nei super Battles, e prima negli sbilenchi Storm & Stress) e di Mike Banfield sono figure geometriche che si incastrano in perfetta combinazione, la batteria di Damon Che è oltre.
8. “The Anatomy of Sharks” June of 44 (1997)

È solo un EP: tre brani, poco più di 20 minuti di musica. Ma è essenziale, in tutto e per tutto. Il basso-grattugia di Sharks & Sailors, manifesto che in 11 minuti fa capire cosa è il post rock, che è post anche perché è un passo in più rispetto al classico suonare: è crudo e slabbrato, in mezzo ha il vuoto. Poi la furia si placa e poi ancora esplode, le chitarre fanno sanguinare le dita e spezzano le ossa. Boom è diverso, con le percussioni e la tromba per aria. Endless Steamer torna da capo e urla.
7. “Prazision LP” Labradford (1993)

Sono stati definiti i Pink Floyd americani, ma a volte con certe similitudini sarebbe meglio lasciar stare. Il trio Labradford ha poco a che fare con gli inglesi, nessuna tentazione space o psych, qui siamo sulla terra, in quelle lande innevate colme di abbandoni e sporcizia di cui si diceva. Si procede a passi lenti, i piedi affondano e la vista si fa sempre più confusa per la nebbia, non ci sono punti di appoggio, l’aria è fredda ed è circondata da fantasmi.
6. “The Sea and the Bells” Rachel’s (1996)

I Rachel’s rappresentano la via classicheggiante del post. Tutto si regge sulle magiche dita di Rachel Grimes e sugli arrangiamenti orchestrali, con radi accompagnamenti di chitarra, basso e batteria. Ispirato da Pablo Neruda, The Sea and the Bells è un concept album di ambientazione marina, con melodie pure e una generale atmosfera di calma nervosa, una specie di brace che non si consuma mai e che sa rendere un tessuto sonoro così nobile qualcosa di visceralmente rock.
5. “The Epiphany of Glenn Jones” Cul De Sac / John Fahey (1997)

In cui il chitarrista dei bostoniani Cul De Sac (il Glenn Jones del titolo) tira dentro uno dei suoi grandi eroi di gioventù, il sommo John Fahey, colui che ha allargato i confini della chitarra acustica (da possedere almeno Fare Forward Voyagers). L’unione tra lo schivo mito della chitarra e la giovane band crea un mix tra le sospensioni tipiche del genere (sospensioni di tutto: dalla melodia agli accordi, passando per il mood e per i testi, tutto nel post rock è più elusivo che concreto) e le invenzioni di Fahey che sperimenta in lungo e in largo nel corso di 10 lunghi brani che traghettano in visioni americane di terra arida e natura rigogliosa.
4. “Spiderland” Slint (1991)

Gli Slint sono una delle band che hanno dato inizio al movimento. Un semplice gruppo rock che improvvisamente deraglia e comincia a concepire canzoni che non sono più canzoni, sono più un’idea vaga di canzone. La sensazione è quella di qualcuno che sta provando a mettere su il brano della sua vita, ma non riesce a dargli forma concreta. In questo continuo tentativo c’è tutta la grandezza di una band che ha saputo concepire quello che da molti è considerato il capolavoro del post rock. Una musica fatta di continui smarrimenti, dove tutto è ridotto a brandelli e non coagula mai, anche l’amore, come nella sottile Washer.
3. “Upgrade & Afterlife” Gastr Del Sol (1996)

Il già citato Jim O’Rourke qui in compagnia di un altro mito: David Grubbs, proveniente da band proto post rock quali Squirrel Bait e Bastro. I Gastr Del Sol sono uno degli astri del movimento, con tanta sperimentazione alternata a momenti folk conditi dalle voci dei due. Nel capolavoro Upgrade & Afterlife ci sono dentro lunghi momenti di clangori metallici in rarefazione, cover del maestro John Fahey (Dry Bones in the Valley), con un mito del minimalismo come Tony Conrad che già aveva collaborato con i krautrocker Faust. Qui c’è la stessa visione folle dei tedeschi.
2. “Millions Now Living Will Never Die” Tortoise (1996)
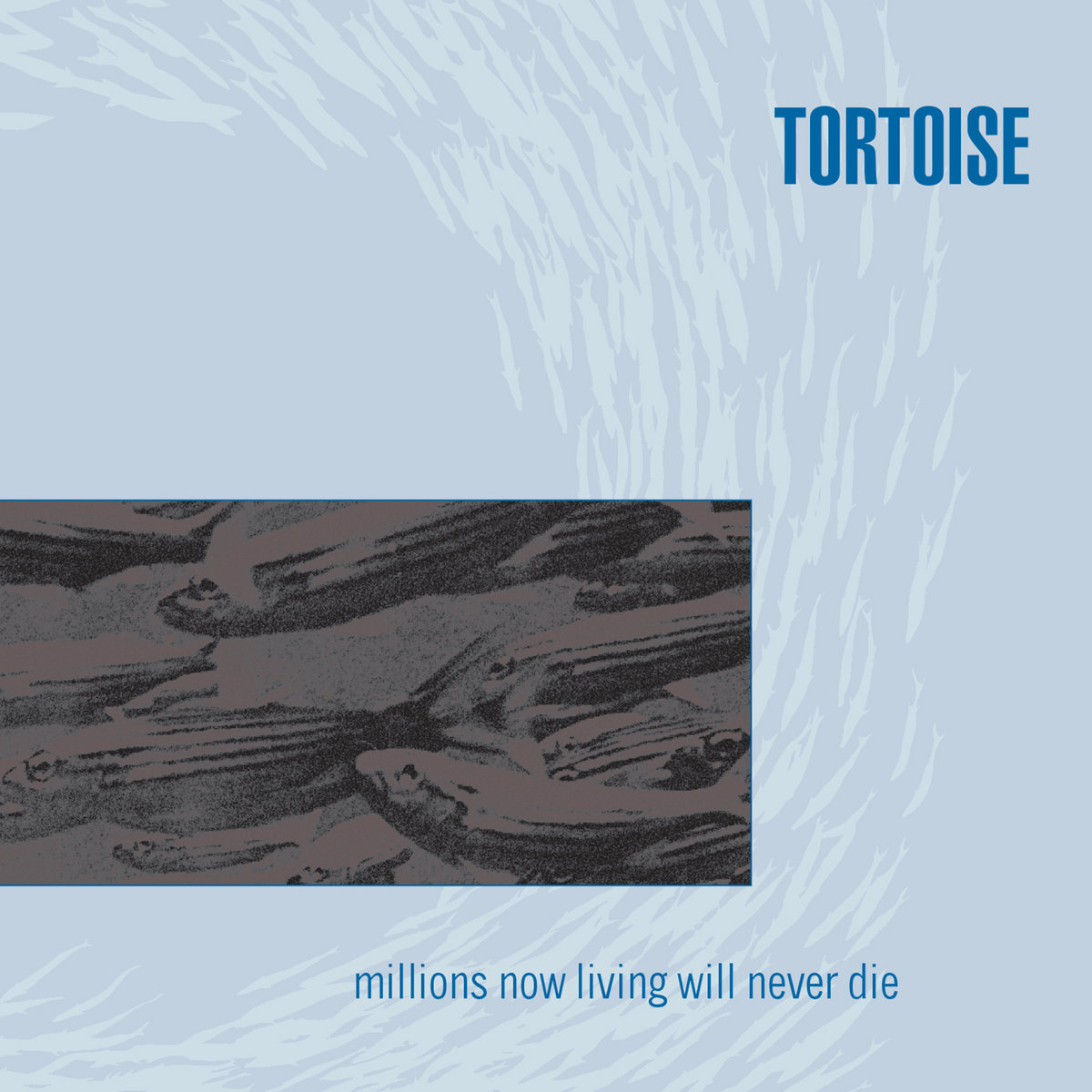
La band di Chicago sono i Gentle Giant del post rock. Ognuno suona una quantità incredibile di strumenti, insieme mischiano tutto quello che è possibile mischiare, con una predilezione per le atmosfere jazz, dub ed electro. Nel lato A di Millions Now Living Will Never Die c’è uno dei capolavori del post e del rock tutto: Djed, 20 minuti di labirinto strumentale che innesta umori minimal-kraut-dub dentro il quale perdere di vista la cognizione del tempo. Nel lato B le cose si tingono di jazz noir, come in Glass Museum, fatta di linee struggenti di chitarra e repentini cambi di tempo, tutto un fluttuare.
1. “F♯ A♯ ∞” Godspeed You Black Emperor! (1996)

Gli amati GYBE! (non ancora GY!BE) finiscono dritti al primo posto con il loro esordio cupo e sensazionale. Tre brani di 16, 17 e 21 minuti. Un’orchestra rock di 10 elementi. Bianco e nero sfocato di copertina, binari morti, chiacchiere di politica, città abbandonate, capannoni fatiscenti in mezzo al nulla, pioggia debole, ciminiere, violini che partono piano, pianissimo, si uniscono a uno a uno gli altri e lentissimamente tutto si fa intenso, più intenso, di un’intensità quasi insostenibile. Esplode, è una violenza sinfonica inaudita, ti sbatte contro il muro e ti prende a pugni. Poi si allontana, piano piano svanisce, torna nella nebbia, silenzio.