Nel 1984 il mondo non era ancora quello prefigurato da George Orwell 35 anni prima, ma neanche un posto così ospitale. Meno soggetto di quello attuale alla cultura della sorveglianza studiata dal sociologo scozzese David Lyon, forse, ma sicuramente turbolento, ribollente di malcontento sociale e di tensioni politiche internazionali. Come oggi, israeliani e palestinesi non trovavano modo di dialogare risolvendo le loro divergenze a suon di attentati, rappresaglie e massacri di innocenti. I rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica restavano in bilico in un clima di Guerra Fredda e di minaccia nucleare, il blocco sovietico boicottava le Olimpiadi di Los Angeles mentre Ronald Reagan e Konstantin Chernenko se le davano metaforicamente di santa ragione come nel video di Two Tribes di Frankie Goes to Hollywood (pezzo forte, insieme alla scandalosa Relax, dell’album di debutto della band di Holly Johnson, Welcome to the Pleasuredome).
Altrove la situazione non era più tranquilla: scampata a un attentato dinamitardo dell’IRA a Brighton, la lady di ferro Margaret Thatcher era impegnata in Inghilterra in un brutale braccio di ferro con i minatori in sciopero. A Nuova Dheli, a fine anno, il premier Indira Gandhi moriva per mano delle sue guardie del corpo sikh mentre la sua nazione era impegnata in un sanguinoso scontro con il Pakistan per il possesso delle terre di confine. E in Africa la carestia continuava a decimare la popolazione etiope, tanto da spingere Bob Geldof e Midge Ure a creare Band Aid, il supergruppo di pop star britanniche che a novembre confluì in uno studio londinese per registrare il singolo a scopo benefico Do They Know It’s Christmas?, uno dei casi discografici dell’anno. Mentre il suo futuro alleato Steve Jobs lanciava negli Stati Uniti il primo personal computer Macintosh, l’industria musicale godeva di buona salute, in un mercato in cui musicassette (55% del giro d’affari) e dischi in vinile (41%) dominavano ancora la scena rispetto al neonato compact disc (4%).
Molto del pop disimpegnato e di facile ascolto che regnava allora nelle classifiche, specchio di un ripiegamento progressivo su se stessi e di una voglia di evasione dalle brutture del mondo, non è invecchiato benissimo. D’altra parte sarebbe più che ingeneroso bollare il 1984 come un anno buio per la musica. È vero che in quei dodici mesi molti grandi nomi – i Queen di The Works (malgrado le hit Radio Ga Ga e I Want to Break Free) e l’Elton John di Breaking Hearts (nonostante Sad Songs), il Lou Reed di New Sensations e l’Elvis Costello di Goodbye Cruel World, il Rod Stewart di Camouflage (pur in presenza di Jeff Beck) e il David Bowie di Tonight (forse il punto più basso della sua carriera) – non hanno consegnato ai negozi album particolarmente memorabili, mentre i pur apprezzabili About Face e The Pros and Cons of Hitch Hiking stanno lì a ricordarci che David Gilmour e Roger Waters (seppure in compagnia di Eric Clapton) non potevano fare facilmente a meno uno dell’altro. Anche l’album postumo di John Lennon con Yoko Ono, Milk and Honey, non aggiunse molto alla storia dell’ex Beatle mentre Paul McCartney concentrava le sue energie su Give My Regards to Broad Street, un sentimentale e nostalgico progetto musical-cinematografico in cui No More Lonely Nights era uno dei pochi brani inediti.
Eppure, dentro, fuori o ai margini del mainstream, erano in tanti a confermare una eccellente ispirazione. Negli Stati Uniti i R.E.M. di Reckoning e i Violent Femmes di Hallowed Ground (a livello del primo, celebrato LP), i Gun Club di The Las Vegas Story, lo Stevie Ray Vaughan di Couldn’t Stand the Weather e i Cars di Heartbeat City, trainato dai singoli Drive e You Might Think tuttora nelle playlist delle radio formato classic rock. In Inghilterra il Robert Plant nostalgico e divertente dell’EP The Honeydrippers: Volume One (con Jimmy Page, Jeff Beck e Nile Rodgers) e i Marillion di Fugazi, i P.I.L. di This Is What You Want…T his Is What You Get e gli Specials A.K.A. di In the Studio (con Free Nelson Mandela, uno dei più memorabili singoli dell’anno), ma anche i Cocteau Twins di Treasure e gli XTC del sottovalutato The Big Express, i Cure di The Top e Siouxie and the Banshees con Hyæna, i Judas Priest di Defenders of the Faith e i Whitesnake di Slide It In.
Con Make It Big! e i suoi scoppiettanti singoli Wake Me Up Before You Go-Go e Careless Whisper George Michael e gli Wham! tenevano fede alle promesse del titolo dell’album mentre Body and Soul di Joe Jackson (l’LP di You Can’t Get What You Want) e Sparkle in the Rain dei Simple Minds avevano la sola colpa di arrivare subito dopo album ancora più riusciti e significativi. Nell’anno in cui morivano il padre del British Blues Alexis Korner e il principe del soul Marvin Gaye, erano tanti i nomi importanti che arrivavano all’album di debutto: i Red Hot Chili Peppers e i Bon Jovi con due dischi omonimi, Nick Cave per la prima volta con i Bad Seeds in From Her to Eternity, il pioniere dello shredding Steve Vai con Flex-Able e i Dead Can Dance, i Talk Talk di It’s My Life e i Bronski Beat di The Age of Consent, i Prefab Sprout di Swoon, i Pogues di Red Roses for Me e i Blue Nile di A Walk Across the Rooftops. Tutti esclusi, in certi casi a malincuore, dalla lista dei 25 titoli che abbiamo selezionato per rappresentare il sound del 1984.
1984
Van Halen
Gennaio 1984
A fine anno gli Eurythmics pubblicano la colonna sonora del film di ispirazione orwelliana Nineteen Eighty-Four, ma sono i Van Halen i più tempestivi a celebrare la fatidica ricorrenza (il loro album esce il 9 gennaio) con un disco di grande successo che non gli risparmia qualche critica feroce. La pietra dello scandalo che li catapulta verso le alte sfere delle classifiche è Jump, con un David Lee Roth al top dell’istrionismo e una marea di tastiere e di sintetizzatori che per la prima volta sembrano soffocare le chitarre in omaggio alla moda del momento. Su coordinate simili, tra synth bass e rototom, si muove I’ll Wait scritta con il cantante dei Doobie Brothers Michael McDonald, ma il riff hard rock di Panama (esplicitamente ispirato allo stile degli AC/DC), il boogie a tavoletta di Hot for Teacher, le rocciose Girl Gone Bad e Drop Dead Legs dimostrano che anche se la band ha deciso di strizzare l’occhio alle radio e a MTV Eddie Van Halen non ha le polveri bagnate e resta un grande axeman. 1984 rimarrà il best seller assoluto dei VH, prima che Lee Roth saluti tutti per dedicarsi a una fortunata carriera solista.
Learning to Crawl
Pretenders
Gennaio 1984
Risorgere dalle ceneri dopo che il bassista è stato cacciato perché tossicodipendente e il chitarrista è morto di overdose non è un gioco da ragazzi. Chrissie Hynde, tosta e volitiva, ci riesce con un fiammante disco chitarristico intenso e catartico, tra pub rock e beat anni ’60. Oggi si ricordano soprattutto Back on the Chain Gang, che racconta una storia di dolore, rimpianto e resurrezione prendendo ispirazione da Sam Cooke, e 2000 Miles, una carola natalizia con un fraseggio jingle jangle che declina in maniera diversa il tema dell’assenza. Ma non c’è davvero nulla che non valga la pena di ascoltare, in Learning to Crawl, tra l’esplosione di adrenalina di Middle of the Road e il giro di basso di My City Was Gone, Chrissie espatriata in Inghilterra che torna ad Akron, in Ohio, per scoprirla deturpata dai parcheggi e dai centri commerciali. Superati i trent’anni, la rocker americana fa i conti con relazioni sentimentali che si tramutano in guerre senza esclusione di colpi (I Hurt You, la cover soul di Thin Line Between Love and Hate dei Persuaders) ma anche con la tenerezza e con le gioie della maternità (Show Me).
The Smiths
The Smiths
Febbraio 1984
Nel periodo di mezzo tra Joy Division/New Order e Oasis, Manchester trova i suoi nuovi cantori negli Smiths, autori di un folgorante omonimo album di debutto che in copertina inaugura una galleria di omaggi cinematografici riproducendo una immagine di Joe Dallesandro ripresa dal film Flesh di Andy Warhol. Li distinguono dalla concorrenza lo squillante fraseggio byrdsiano di Johnny Marr (forse il migliore chitarrista rock inglese della sua generazione) e la personalità eccentrica e bohémien di Morrissey, un giovane Oscar Wilde dalla voce cantilenante che con accenti desolati e una punta di sarcasmo canta di traumi infantili, turbamenti adolescenziali, confuse identità sessuali, perdita d’innocenza, disagio sociale e omicidi (Suffer Little Children cita i famigerati Moors Murders che sconvolsero la città a metà anni ’60). Reel Around the Fountain, Still Ill e il singolo di debutto Hand in Glove (che Morrissey farà incidere anche a un suo mito d’infanzia, “la cantante scalza” Sandie Shaw) testimoniano la capacità di creare dei piccoli kitchen-sink drama da tre minuti; la più movimentata What Difference Does It Make? e Pretty Girls Make Graves citano nel titolo I vagabondi del Dharma di Jack Kerouac, un altro testo fondamentale nella formazione di Moz.
Café bleu
The Style Council
Marzo 1984
Dopo avere sciolto i Jam tra la costernazione dei numerosissimi fan britannici, Paul Weller forma un nuovo sodalizio con il tastierista mod Mick Talbot, sostituisce al parka un elegante spolverino bianco e cerca ispirazione nei bistrot di Parigi sorseggiando cappuccini e sfogliando Le Monde. Dal suo nuovo e articolato manifesto artistico prende forma un sofisticato cocktail musicale che sconcerta (in patria) qualche critico e una parte del pubblico mixando strumentali jazzati alla Mose Allison e in stile Blue Note, suadenti ritmi di bossa nova, fascinose ballate notturne come The Paris Match (con la voce impareggiabile di Tracey Thorn degli Everything but the Girl) e My Ever Changing Moods (che dà il titolo alla edizione americana del disco: meglio però la versione uptempo ed elettrica uscita qualche tempo prima come singolo), rap, funk e blue eyed soul (You’re the Best Thing: Weller non aveva mai scritto nulla di così esplicitamente sentimentale). Forse troppa ambizione, e troppa carne al fuoco, ma al di là di qualche episodio trascurabile è da apprezzare il coraggio dell’operazione e la gradevolezza tutt’altro che superficiale dell’insieme. Il pubblico europeo, Italia compresa, reagirà molto meglio di quello inglese: intanto Weller si è già reinventato una nuova carriera (e non sarà neppure l’ultima volta).
Run-D.M.C.
Run-D.M.C.
Marzo 1984
Il rap e l’hip hop sono stati sdoganati presso il grande pubblico qualche anno prima da pionieri come Afrika Bambaataa e Grandmaster Flash, ma con il loro album di debutto i giovanissimi Run-D.M.C. (neanche ventenni) ne spostano la frontiera verso l’hardcore con un piglio più aggressivo e l’autenticità di chi frequenta la strada, un sound minimale e abrasivo, beat insistenti e rime taglienti che veicolano messaggi di protesta e di critica sociale. Uscita come singolo l’anno prima dell’album, It’s Like That mette il dito sulla piaga della disoccupazione arrivata anche negli Stati Uniti a livelli record, sulle guerre che avvelenano il mondo e su un sistema che mette il denaro al centro di tutto, mentre con nient’altro che uno scratch e una batteria elettronica il suo lato B Sucker M.C.’s anticipa la moda del dissing prendendo di mira un rapper ritenuto incapace di fare il suo lavoro. Hard Times è presa in prestito a Kurtis Blow mentre in Rock Box una chitarra elettrica stridente suonata in stile metal prelude in un certo senso alla versione di Walk This Way che gli stessi Run-D.M.C. incideranno quattro anni dopo con gli Aerosmth, interpreti originali del brano, assecondando una intuizione geniale del produttore Rick Rubin.
Ocean Rain
Echo & The Bunnymen
Maggio 1984
La trasformazione di Ian McCulloch, cantante e leader di Echo & the Bunnymen, in una reincarnazione new wave di Scott Walker è completata nel quarto disco della band di Liverpool, qui sovente affiancato da un’orchestra di 35 elementi registrata in uno studio di Parigi dove i quattro inglesi si imbevono di romanticismo e douce France sognando di avere a fianco Jacques Brel. Tenebrosa, tempestosa e avvolgente, The Killing Moon è la canzone che incarna il loro nuovo corso («È un salmo, quasi un inno», spiegherà McCulloch, convinto immodestamente che si tratti della «più grande canzone mai scritta», il suo «essere o non essere che contiene una risposta al senso della vita»). Sitar, clavicembali, xylofoni e glockenspiel arricchiscono di colori psichedelici e di pop sinfonico alla Moody Blues l’asciutto e tagliente suono chitarristico dei primi dischi e altre composizioni melodiche e intriganti come Silver e Seven Seas mentre Thorn of Crowns resuscita altre vecchie ossessioni ricorrenti di McCulloch e del chitarrista Will Sergeant: Jim Morrison e i Doors.
Private Dancer
Tina Turner
Maggio 1984
Più che un ritorno è una resurrezione. Liberatasi nel decennio precedente dalla morsa terribile del marito, aguzzino e padre padrone Ike Turner, Tina fatica a ricostruirsi una vita e una carriera fino a quando la Capitol le offre un grande budget e una grande opportunità. Non meno di otto rinomati produttori si prodigano per rivestire la sua voce ancora graffiante e una bella scelta di canzoni di sonorità scintillanti, patinate e trendy a cavallo tra pop, soul e rock. Con il suo groove accattivante dal profumo giamaicano e le sue sonorità AOR What’s Love Got to Do with It (tre Grammy e due milioni di copie vendute nel mondo) è il perfetto biglietto da visita di un album in cui una Turner leonina, rigenerata e grintosa non dimentica le sue radici r&b (con due cover dal prezioso catalogo Hi di Memphis, Let’s Stay Together di Al Green e I Can’t Stand the Rain di Ann Peebles), prestandosi anche alla penna dei migliori autori del momento (la morbida e sensuale Private Dancer porta la firma di Mark Knopfler ed è eseguita da una cast di stelle: Jeff Beck alla chitarra, Wilton Felder al basso e al sax, Joe Sample al piano e al synth). Siccome è il momento giusto, non manca neppure una ripresa in stile electro-pop della orwelliana 1984 di David Bowie, pubblicata dall’artista inglese dieci anni prima su Diamond Dogs.
Eden
Everything but the Girl
Maggio 1984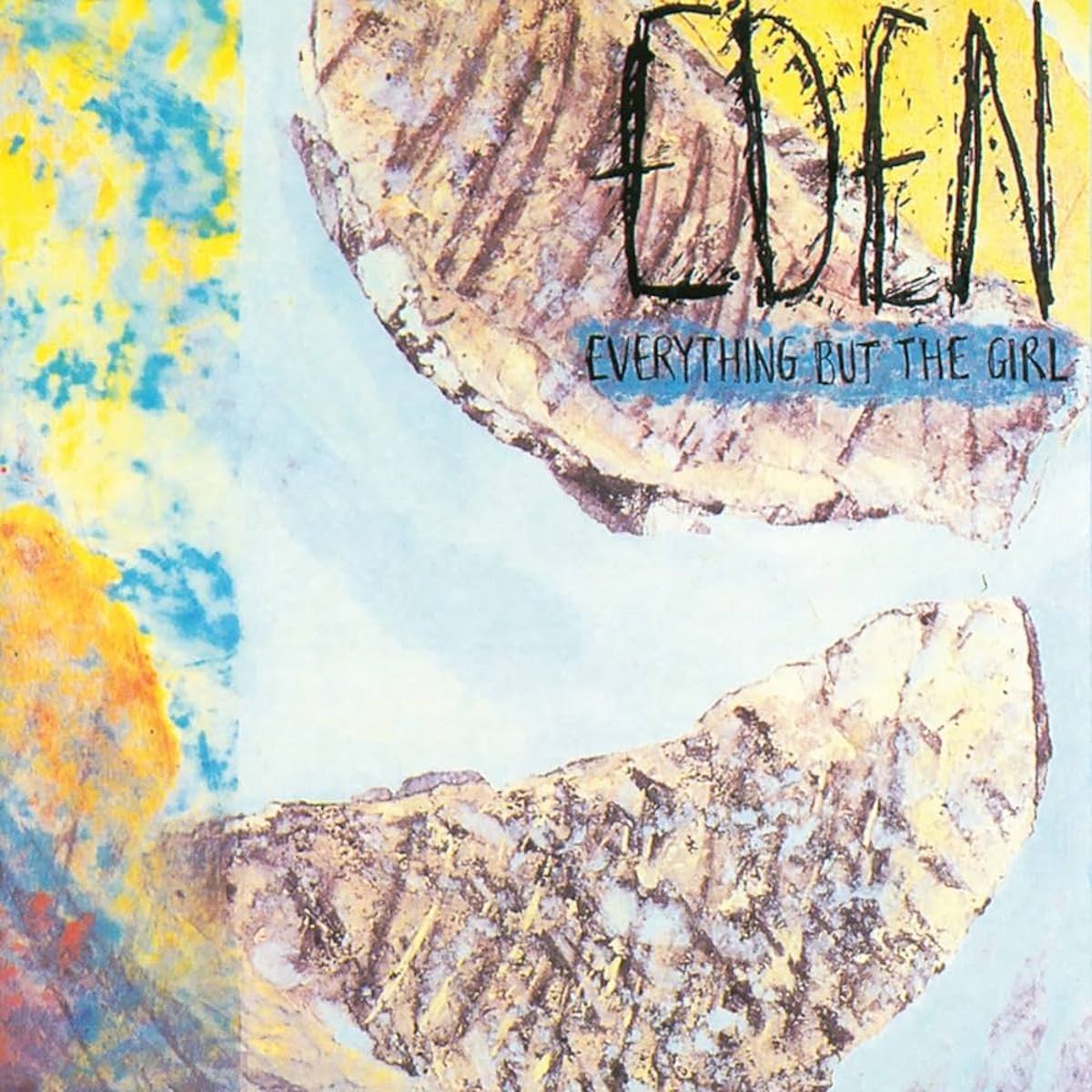
Dalla città portuale di Hull, Nord dell’Inghilterra, Ben Watt e Tracey Thorn – due antistar dall’aspetto dimesso che hanno già raccolto separatamente consensi nel circuito underground – scendono a Londra per confezionare sotto la sigla Everything but the Girl (rubata a un negozio di mobili) una deliziosa opera prima con 12 canzoni color pastello che conservano il senso di intimità domestica in cui sono nate. Lei ha una voce suadente e malinconica, lui un tono sommesso e uno stile chitarristico modellato su quelli di Nick Drake, di John Martyn e di João Gilberto. Sottovoce, incantano con la bossa nova del primo singolo Each and Everyone (lo spleen inglese, del resto, è un sentimento non troppo distante dalla saudade brasiliana) e con carezzevoli ballate in punta di dita spesso colorate di quel jazz che hanno imparato ad amare sui dischi della Prestige e della Blue Note: musica agrodolce, Bittersweet, come intitola un’altra delle canzoni migliori in scaletta. Più o meno nello stesso periodo e nello stesso studio, il produttore Robin Millar registra Diamond Life di Sade: Eden vende venti volte meno, ma resterà nel cuore di molti.
Born in the U.S.A.
Bruce Springsteen
Giugno 1984
Nel 1984 lo stadium rock americano diventa un paradigma: grazie a Reckless del canadese Bryan Adams (12 milioni di copie nel mondo) ma soprattutto grazie all’ancora più popolare Born in the U.S.A. di Bruce Springsteen, il disco che fa da clamoroso contrappeso al folk scabro, acustico e lo-fi del precedente Nebraska. Qui va tutto al contrario: produzione bombastica e radio friendly, mentre Max Weinberg picchia implacabile sulle pelli della batteria con la precisione metronomica di una drum machine e Roy Bittan (provocando un certo sconforto in chi ama Bruce e la E Street Band dagli inizi) mette in disparte il pianoforte per prodigarsi al sintetizzatore in cerca di sonorità più à la page. Il colpo di grazia lo dà un singolo ammiccante come Dancing in the Dark, ma alla base dell’idea di un Bruce “venduto” senza pudore al mercato si annida una serie di fraintendimenti: che colpiscono in primo luogo la title track, interpretata da molti, e dal presidente Reagan in primis, come un roboante inno patriottico mentre è un urlo di disperazione dei veterani del Vietnam dimenticati e abbandonati in patria. Sotto la fibra muscolosa degli arrangiamenti e quel suono spinto si nasconde un repertorio di qualità (soprattutto le ballate, amare e disilluse, romantiche o speranzose, come Downbound Train, No Surrender, Bobby Jean e My Hometown), ma il solco lasciato sul terreno resta indelebile: da quel momento, nella fan base si creerà un discrimine tra coloro che hanno iniziato a amare Bruce ben prima di Born in the U.S.A. e quelli che lo hanno trasformato in un fenomeno di massa.
Parade
Spandau Ballet
Giugno 1984
Nell’anno di Wild Boys dei Duran Duran, gli Spandau Ballet tengono alta la bandiera dell’estetica New Romantic pubblicando il loro quarto album, quello di Only When You Leave e di I’ll Fly for You. Due hit single – il primo più mosso e ritmato, il secondo più lento e vellutato, con l’immancabile presenza di un sax romantico e sensuale – che dimostrano un paio di cose: primo, che al di là del ciuffone e della faccia carina da video star Tony Hadley è un ottimo cantante con una voce ben educata; secondo, che Gary Kemp è un compositore di valore e un chitarrista competente, capace di sfornare gustose caramelline pop-soul che combinano groove e melodia senza ricorrere a troppi trucchi di studio (stavolta, anzi, l’obiettivo dichiarato consiste nel creare musica adatta a essere riprodotta dal vivo nei grandi spazi a cui la band è destinata in conseguenza del suo crescente successo). Muzak, sentenziano all’epoca alcuni critici inglesi: ma anche se il resto non è all’altezza dei due pezzi forti (a cominciare dagli altri due singoli: Highly Strung, più in linea con i vecchi Spandau, e Round and Round, musica leggerissima in abito da sera), con Parade i quattro londinesi di Islington dimostrano che il loro white boy soul può reggere dignitosamente la distanza dei 40 minuti.
Purple Rain
Prince
Giugno 1984
Venticinque milioni di fan di Prince non si possono sbagliare: Purple Rain è l’album più famoso e più venduto del genio di Minneapolis, per quanto concepito come colonna sonora dell’omonimo film semiautobiografico di cui lui stesso è protagonista. Let’s Go Crazy apre la luccicante fantasmagoria con una chitarra che in coda si lancia in una frenetica svisata blues, e mentre la sofisticata When Doves Cry e la lunghissima, epica ballata che intitola il disco (8 minuti e 41 secondi) valgono una carriera, c’è molto altro in serbo: pezzi come I Would Die 4 U e Take Me with U spingono sui groove e incrementano ulteriormente il quoziente ritmico dell’LP mentre la torrida Darling Nikki ne innalza la temperatura erotica (dopo avere sentito la figlia undicenne cantarne il testo che allude alla masturbazione femminile, la moglie del futuro vicepresidente degli Stati Uniti, Tipper Gore, invocherà all’industria discografica l’applicazione sui dischi dai contenuti “espliciti” di un adesivo “Parental Advisory” a tutela dei minori). Purple Rain contiene una sequenza di mini sinfonie maniacalmente costruite sovrapponendo voci e loop, tracce strumentali, tastiere e synth, chitarre e batterie elettroniche, nell’ottica di una musica totale che non si sa come definire: bianca o nera? Pop o soul? Funk o rock? Dance o neo psichedelica? Assimilate le lezioni di James Brown e di Sly Stone, dei Funkadelic e di Stevie Wonder, dei Led Zeppelin e di Joni Mitchell, Prince ha creato un genere che appartiene solo a lui.
Brilliant Trees
David Sylvian
Giugno 1984
Il musicista più dandy d’Inghilterra insieme a David Bowie e a Bryan Ferry aveva già fatto capire di cosa fosse capace con l’art rock elettronico ed elegante dei Japan ma soprattutto con il singolo Forbidden Colours, scritto e interpretato assieme a Ryuichi Sakamoto per il film Furyo. Ciò nonostante, in Brilliant Trees scompagina le aspettative, realizzando un’opera che in certi momenti (e soprattutto nella title track finale) assomiglia a una seduta di meditazione in musica, a una ascetica riflessione che prende spunto dal suo interesse per gli insegnamenti di Gurdjieff, oltre che per le opere letterarie e cinematografiche di Radiguet, di Sartre e di Cocteau e per i dipinti di Picasso (il testo di The Ink in the Well cita Guernica). Red Guitar è il pezzo più adatto alle orecchie dei consumatori di pop music, mentre il resto si muove con stile e profonda ispirazione in territori folk-jazz-etno-ambient-funk grazie a un formidabile team di musicisti che include Holger Czukay dei Can e il trombettista Jon Hassell (due discepoli di Stockhausen), Mark Isham, il contrabbassista Danny Thompson (Pentangle, John Martyn) e lo stesso Sakamoto oltre a Richard Barbieri e Steve Jansen dei Japan.
Diamond Life
Sade
Luglio 1984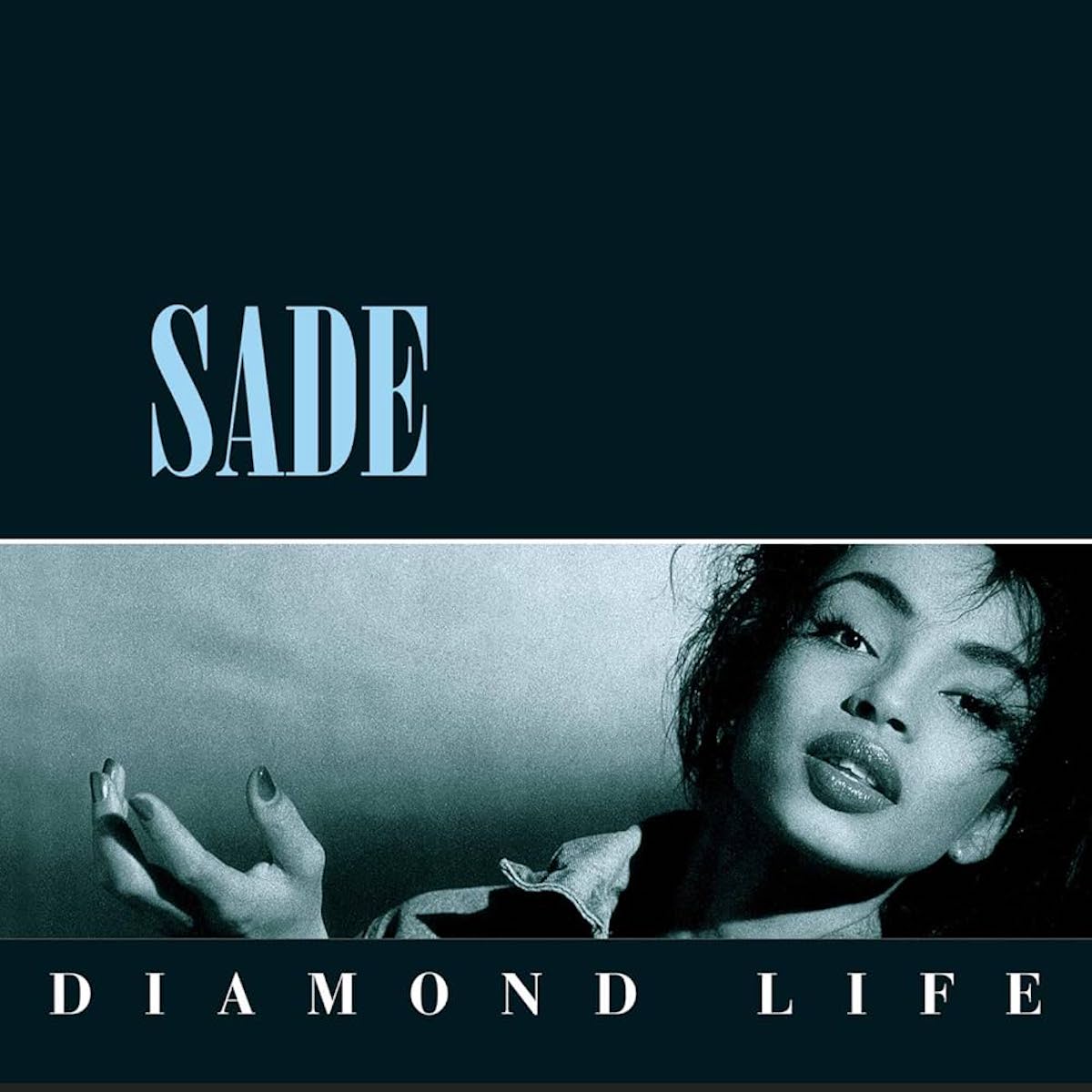
Tra gli eccessi musicali e d’immagine dei divi techno pop del momento svetta per stile, misura ed eleganza la modella, aspirante fashion designer e cantante di origini nigeriane Sade Adu con il gruppo che porta il suo nome. Il debutto Diamond Life è all’insegna di una musica apparentabile all’easy listening ma anche di sostanza e di gran classe: smooth soul e sophisti-pop sono le etichette utilizzate dalla stampa specializzata inglese per indicare una proposta garbata, raffinata e fascinosa a cui la produzione di Robin Millar, che sta dietro alle produzioni britanniche più cool del momento, garantisce impeccabile qualità. Il sassofonista, chitarrista e compositore Stuart Matthewman è un eccellente e affidabile partner musicale, le canzoni funzionano tanto in radio che sul giradischi di casa: tra il velluto di Smooth Operator e di Your Love Is King e una cover dell’inno pacifista di Timmy Thomas Why Can’t We Live Together, il disco scorre tra suoni soffici e carezzevoli da night club, spruzzate di jazz e percussioni latine, chitarre funky e ritmi lenti da ballo guancia a guancia. Il neo soul dei decenni successivi parte anche da qui.
Ride the Lightning
Metallica
Luglio 1984
Fight Fire with Fire inizia acustica con l’incedere di un madrigale, per poi esplodere in una tonante tempesta elettrica con vertiginosi cambi di tempo e riff fulminanti di chitarra suonati da Kirk Hammett (che ha appena sostituito Dave Mustaine, accreditato in due brani ma poi cacciato dal gruppo per comportamento violento e consumo eccessivo di alcol e droghe). È solo al secondo album, la band fondata da James Hetfield e da Lars Ulrich, ma ha già una visione personale, matura e sfaccettata di quello che qualche giornalista ha cominciato a chiamare thrash metal (molto credito viene attribuito alle nozioni di teoria musicale di cui è in possesso il bassista Cliff Burton). È un atteggiamento che si riflette anche nei testi: Ride the Lightning racconta gli ultimi istanti di vita di un condannato alla sedia elettrica, For Whom the Bell Tolls descrive gli orrori della guerra ispirandosi all’omonimo romanzo di Hemingway, la evocativa power ballad Fade to Black parla di suicidio sfoggiando le spiccate qualità melodiche del quartetto, Creeping Death rievoca le piaghe dell’antico Egitto, The Call of Ktulu – roccioso strumentale di quasi nove minuti – manifesta una ricorrente fascinazione per i romanzi fantascientifici di H.P. Lovecraft. Cambi di tempo, uso accorto delle dinamiche, variazioni cromatiche, umore apocalittico: con questo disco, che non a caso Rolling Stone ha collocato nel 2017 all’undicesimo posto nelle classifica dei 100 migliori album metal di sempre, un genere considerato da molti ormai codificato e monocorde compie un prodigioso balzo in avanti.
Zen Arcade
Hüsker Dü
Luglio 1984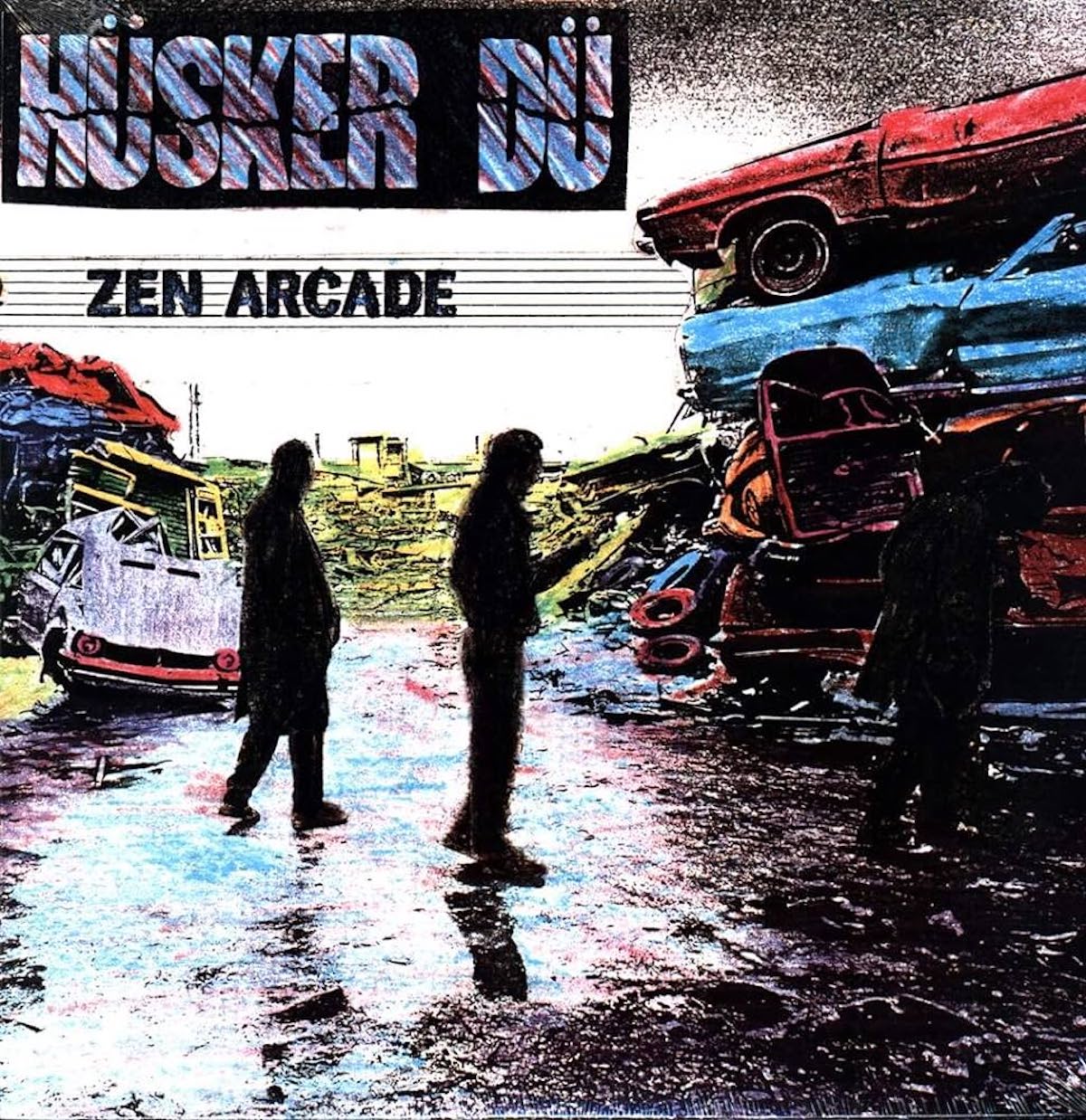
Quattro facciate, 23 canzoni incentrate sul tema della difficoltà di crescere e sui drammi (e le tragedie) dell’adolescenza, seguendo le vicende di un ragazzo che si decide ad abbandonare una famiglia violenta e oppressiva ma che anche altrove sbatte il muso contro una realtà tutt’altro che accogliente. Al secondo album, il trio di Minneapolis assurge al rango di band di punta dell’hardcore punk americano; dimostrando ambizioni insospettabili e creatività inarrestabile, affronta con spavalderia il formato del doppio album e l’idea del concept tanto cari ai vituperati gruppi prog degli anni ’70. Nulla di più distante da Zen Arcade, che vive sulla dicotomia tra i due autori Bob Mould (voce e chitarra, il più prolifico) e Grant Hart (voce e batteria), mentre al bassista Greg Norton tocca l’ingrato compito di mediare tra i due estremi di un sistema in equilibrio perennemente instabile. Something I Learned Today, urgente e anfetaminica, è il prologo di un aspro romanzo di formazione che include incontri con il sistema e la disciplina militare (Chartered Trips), con le religioni orientali (Hare Krsna), con le droghe e con la morte (Pink Turns to Blue). Non ci sono soltanto velocità, adrenalina e urla gutturali ma anche sprazzi di melodia e interludi pianistici, riff in stile Byrds, pezzi in cui Mould tramuta il suo ringhio disperato in un lamento rauco e malinconico (Newest Industry) mentre Never Talking to You Again concede spazio alle chitarre acustiche e il finale sorprende con i travolgenti 14 minuti strumentali e noise/psichedelici di Reoccurring Dreams.
Double Nickels on the Dime
Minutemen
Luglio 1984
I Minutemen prendono spunto dai compagni di etichetta Hüsker Dü (che li precedono di due giorni nei negozi) ma anche, imprevedibilmente, dai Pink Floyd di Ummagumma per sfornare a loro volta un doppio album destinato a mandare all’aria le regole non scritte del nuovo punk-rock americano. I tre componenti della band scelgono separatamente la scaletta delle prime tre facciate, destinando alla quarta gli “scarti” e affastellando nel processo una quantità impressionante e persino disorientante di suggestioni, di schizzi musicali e di canzoni (45, spesso di durata inferiore ai due minuti). Il chitarrista D. Boon sembra prediligere pezzi di denuncia e di protesta (Viet Nam, Corona o This Ain’t No Picnic, che affronta il tema del razzismo), il bassista Mike Watt preferisce un approccio impressionista e il flusso di coscienza nel solco dell’amato James Joyce (June 16th cita l’Ulisse). Dentro c’è di tutto (e il famoso critico americano Robert Christgau parlerà di “poesia con jazz”): funk-rock minimale, scattante e nervoso che anticipa i Red Hot Chili Peppers, assoli non ortodossi di chitarra, ritmiche convulse e spezzate, i singulti e i sobbalzi di Watt trasforma il suo basso in uno strumento solista, ma anche strumentali arpeggiati alla chitarra acustica (Cohesion), scherzi musicali, un pezzo cofirmato da Henry Rollins e cover che rivelano interessi a tutto campo (Don’t Look Now dei Creedence Clearwater Revival registrata dal vivo, Ain’t Talkin ‘bout Love dei Van Halen, Dr. Wu degli Steely Dan). “Il punk-rock ci ha cambiato la vita”, canta Mike in History Lesson – Part II: nel frattempo i Minutemen hanno cambiato per sempre il punk-rock.
Powerslave
Iron Maiden
Settembre 1984
Da un quinquennio saldamente alla guida della New Wave of British Metal, con Powerslave gli Iron Maiden si confermano una inossidabile macchina da guerra, solida come un carrarmato dell’esercito di Sua Maestà britannica. La formazione è rodatissima, con un tridente d’attacco che a un Bruce Dickinson dall’ugola di acciaio affianca i duellanti Dave Murray e Adrian Smith alle chitarre mentre Steve Harris al basso e Nicko McBrain alla batteria sono una sezione ritmica che non fa prigionieri. L’ispirazione bellica di Aces High (che narra la storia di un pilota della RAF durante la Battaglia d’Inghilterra) e di 2 Minutes to Midnight (una denuncia degli interessi commerciali che stanno dietro a ogni conflitto armato, mentre il doomsday clock scandisce l’avvicinarsi dell’Apocalisse nucleare) attizza il fuoco di due futuri classici del repertorio, mentre Flash of the Blade (ripresa 24 anni dopo dagli Avenged Sevenfold) strega anche Dario Argento che la vuole nella colonna sonora di Phenomena. Anche Back in the Village viaggia a velocità supersonica, ma la vera sorpresa arriva in fondo, con le variazioni di tempo e d’atmosfera di una ambiziosa Rime of the Ancient Mariner ispirata all’omonima poesia di Samuel Taylor Coleridge: prima di allora non si erano mai sentiti gli Iron Maiden così epici, mistici e romantici.
Some Great Reward
Depeche Mode
Settembre 1984
È l’album di People Are People, un’invocazione al superamento delle discriminazioni che impone i Depeche Mode anche negli Stati Uniti e diventa un inno per la comunità LGBT, e di Master and Servant, dove la descrizione di un rapporto di dominio e di sottomissione nella sfera sessuale funziona anche da metafora di quanto accade nella politica, nella società e nel mondo del lavoro. I ritmi robotici e le glaciali sonorità sintetiche, spesso ottenute con ampio ricorso ai sample, non soffocano il carisma interpretativo di Dave Gahan e l’intelligenza musicale di Martin Gore, che in Lie to Me scrive di adulterio, con Somebody confeziona in forma di anomala ballad pianistica una canzone d’amore cinica e disincantata e in Blasphemous Rumours racconta una storia tetra e beffarda affrontando i temi del suicidio, del rapporto tra uomo e Dio e della tragica fatalità della vita attirandosi non poche critiche da parte delle comunità religiose. Sono temi dark e insoliti come questi, oltre al suono avvolgente delle tastiere e a melodie esotiche come quella di It Doesn’t Matter a garantire al disco un appeal durevole nel tempo.
The Unforgettable Fire
U2
Ottobre 1984
È uno strano connubio, a prima vista, quello tra quattro irlandesi tutto fuoco e passione, un intellettuale apparentemente algido come Brian Eno e un emergente stregone delle sonorità ambient come Daniel Lanois. Succcede però che dopo il successo di War gli U2 desiderano alzare lo sguardo oltre il rock and roll in senso stretto, hanno apprezzato la svolta dei Simple Minds con New Gold Dream e sono pronti al grande passo: un disco ancora imperniato sulla voce a pieni polmoni di Bono e sulla triade chitarra-basso-batteria caricati però di nuove sfumature grazie agli echi, agli effetti e ai colori prodotti in studio di registrazione anche con il supporto di una sezione d’archi. Le prime note di A Sort of Homecoming, con gli strumenti e il canto immersi in una suggestiva foschia, segnalano il cambiamento: pur imprimendo un marchio inconfondibile al suono, i produttori non schiacciano ma anzi amplificano lo slancio idealista e la portata epica di canzoni come Pride (In the Name of Love) (dedicata, come MLK, alla figura di Martin Luther King), The Unforgettable Fire (ispirata al disastro nucleare di Hiroshima) e Bad, dove i classici riff circolari e i delay della chitarra di The Edge incorniciano il dolente omaggio di Bono alle tante vittime dell’eroina nella Dublino piegata dal tracollo economico-sociale degli anni ’80. È con una versione di 12 minuti di quella canzone che, l’anno dopo a Wembley per il Live Aid, gli U2 scriveranno un’altra pagina fondamentale della loro storia e di quella del rock.
Let It Be
The Replacements
Ottobre 1984
Minneapolis negli anni ’80 è un po’ come San Francisco nei ’60 o Seattle nei ’90: un incubatore di idee, anche se in questo caso non si può parlare di una vera e propria scena. Contemporaneamente a Prince e agli Hüsker Dü (che come loro incidono per la indie SST e hanno le radici nell’hardcore punk) anche i Replacements sfornano uno dei loro dischi più importanti; lo scompigliato leader Paul Westerberg ha ancora un’anima scapestrata ma non si accontenta più di urlare e di fare rumore: lo dimostra con il singolo che anticipa e apre l’LP, una ballata programmaticamente intitolata “oserò”, I Will Dare, con una melodia jangle pop e la chitarra di un riconosciuto specialista del genere come Peter Buck dei R.E.M. (mentre lui imbraccia un mandolino). We’re Comin’ Out e Tommy Gets His Tonsils Out hanno ancora l’impeto rabbioso dei dischi precedenti, ma la strascicata ballata pianistica Androgynous e soprattutto l’inno Unsatisfied (uno dei pezzi più belli e toccanti in repertorio, in cui Westerberg esprime la frustrazione ma anche la voglia di reagire di una generazione, suonando una 12 corde e una slide mentre Bob Stinson improvvisa alla chitarra elettrica) colgono con pungente realismo i dubbi e i turbamenti della delicata fase di passaggio dall’adolescenza all’età adulta. I Replacements cantano senza pudori di erezioni e di sogni erotici (citando Madonna in Gary’s Got a Boner), dell’“età più difficile” e di identità confuse (nella ballata Sixteen Blue) prendendo le distanze dal rock and roll fasullo che si vede in televisione (Seen Your Video). Difficile non farsi conquistare dal loro sound febbrile e dal loro candore disarmante.
How Will the Wolf Survive?
Los Lobos
Ottobre 1984
Una decina di anni dopo Ry Cooder, anche i Los Lobos servono al pubblico rock una musica apparentemente lontana dal suo palato, il norteño rielaborato secondo la sensibilità moderna di un collettivo di musicisti di sangue messicano ma nati e cresciuti in California (nel quartiere di East Los Angeles) che affiancano fisarmoniche e strumenti a corda tradizionali alle chitarre elettriche, al basso, alla batteria e al sassofono di Steve Berlin (unico non chicano della band, in arrivo da Philadelphia). Nel loro primo album con una distribuzione internazionale aggiungono corritos e serenate in lingua spagnola a un repertorio frizzante che ingloba rock blues elettrico di scuola chicagoana (Don’t Worry Baby), rhythm & blues ballabili (la cover I Got Loaded) e rock and roll vintage sulla falsariga del loro eroe e predecessore Ritchie Valens. Sono generi ben impiantati nel dna di musicisti che interagiscono da più di dieci anni e si sono fatti le ossa suonando a feste e matrimoni: la loro musica ruggisce già come il motore ben rodato di un lowrider in bella mostra per le strade del quartiere e pronto ad avventurarsi fuori città. Due chitarre, due voci soliste, una sezione ritmica compatta e a tenuta stagna: David Hidalgo, Cesar Rosas e Louie Pérez, gli autori del gruppo, dimostrano già una notevole sapienza compositiva in A Matter of Time e in Will the Wolf Survive? (incisa anche dal re dell’outlaw country Waylon Jennings), ballate esemplari tra John Mellencamp e John Fogerty nello stile che in seguito verrà definito Americana.
Rattlesnakes
Lloyd Cole & The Commotions
Ottobre 1984
Un fulmine nel cielo d’autunno. Da dove salta fuori quel ragazzone inglese dallo sguardo imbronciato, dal vocione profondo e con il ciuffo alla Elvis? È un giovane di buone letture e appassionato di cinema, che ha studiato letteratura all’università di Glasgow facendo sogni di gloria con un gruppo di amici ribattezzatisi Commotions come una soul band degli anni ’60. Li annuncia al mondo come meglio non si potrebbe Perfect Skin, primo singolo e brano di apertura del loro album di debutto ispirato nel testo al ricco immaginario dylaniano di Subterranean Homesick Blues (Cole canta di una ragazza che assomiglia a Greta Garbo, mentre la protagonista di Rattlesnakes, la title track che ruba il titolo a un libro di Joan Didion, legge Simone de Beauvoir e “sembra Eve Marie Saint in Fronte del porto”). Immagini seducenti come le canzoni di questo LP sorprendente e avvincente, con un sound pulito e brillante di chitarre e organo che talvolta evoca i Doors e i Velvet Underground anche se l’approccio è decisamente più morbido e suadente ricordando semmai certi pionieri del nuovo pop scozzese come gli Orange Juice (modello dichiarato del gruppo). Come un giovane poeta romantico o un filmmaker della nouvelle vague, Cole scrive di turbamenti esistenziali e complicazioni amorose arricchendo di citazioni colte e intriganti canzoni semplici, immediate e cristalline di solido impianto folk-rock: saranno in tanti a innamorarsi di Speedboat, di 2cv, di Forest Fire (con un notevole assolo del chitarrista Neil Clark) e di Are You Ready to Be Heartbroken?, un paio di anni dopo registrata anche dalla rediviva pop star dei Sixties Sandie Shaw.
Fried
Julian Cope
Novembre 1984
L’acido lisergico e le automobiline giocattolo sono due grandi passioni di Julian Cope, il grande eccentrico della scena pop inglese anni ’80 che sulla copertina di Fried (sballato, inebriato, intossicato: il titolo non dà adito a dubbi) si fa fotografare nudo con un guscio di tartaruga sulla schiena mentre gioca con il modello di un camioncino in mezzo a un cumulo di scorie nella campagna inglese. È il suo secondo album solista in un anno, dopo i successi con i Teardrop Explodes, rivali liverpooliani di Echo & the Bunnymen abbandonati per i contrasti insanabili con il tastierista David Balfe. Del pop barocco e adrenalinico del precedente e ottimo World Shut Your Mouth resta qualche traccia giusto nel garage folk di Reynard the Fox (il riff è rubato a un vecchio brano dei Them) e in un singolo accattivante come Sunspots che avrebbe meritato migliore fortuna. Ma tra una briosa canzone d’amore (Holy Love) e una invocazione rivolta a Odino (King of Chaos: mitologia, paganesimo e folklore sono altri interessi del poliedrico personaggio) il cuore del disco è rappresentato da ballate acustiche stordite, intorpidite e psichedeliche in cui Cope invoca lo spirito di Brian Wilson finendo per assomigliare di più a Syd Barrett e citando per nome e cognome l’ex manager con cui ha avuto un rapporto conflittuale (Bill Drummond Said): quest’ultimo, in seguito cofondatore dei KLF, gli replicherà due anni dopo con Julian Cope Is Dead.
Like a Virgin
Madonna
Novembre 1984
Non è più una ragazzina (ha 26 anni), Madonna Louise Ciccone, quando esce il suo secondo album provocando scosse telluriche nel music business e nella società americana. Il vecchio amico/amante Steve Bray e una vecchia volpe della disco funk come Nile Rodgers (Chic) la aiutano a mettere a fuoco il suo progetto di conquista del mondo, anche se con quest’ultimo litiga sulla scelta del titolo (la parola “vergine” avrebbe probabilmente turbato il pubblico delle radio e della tv) e sulla sequenza dei singoli (inutile dirlo, sarà lei ad averla vinta). Promosse da due videoclip passati a loro volta alla storia, Like a Virgin e Material Girl veicolano a ritmo dance pop (e con non pochi fraintendimenti da parte dei media), l’idea allora rivoluzionaria di una giovane donna volitiva e indipendente che ama provocare e ha il pieno controllo di sé: del suo corpo, della sua sessualità, della sua immagine, del suo abbigliamento, delle strategie di marketing e di comunicazione: il pacchetto completo, insomma, in cui la musica, tra synth scintillanti e beat scoppiettanti, è solo uno degli elementi. Le polemiche che la accompagneranno per tutta la carriera sono già iniziate (l’altro pezzo forte e irresistibile per i frequentatori del dancefloor, Dress You Up, finisce nel mirino del Parents Music Resource Center per le forti allusioni sessuali del testo), non tutto è ancora a punto (il terzo singolo Angel suona un po’ come una copia sbiadita dei primi due, altri pezzi scorrono senza lasciare grandi tracce), ma la cover di Love Don’t Live Here Anymore, brano soul dei Rose Royce, dimostra che a dispetto degli strali iniziali della critica e dei suoi mezzi vocali non eccelsi, Madonna può diventare credibile anche come interprete di ballate melodiche. Like a Virgin non è soltanto un disco spartiacque per il music business ma anche il detonatore di una rivoluzione culturale e di costume.
Brewing Up with Billy Bragg
Billy Bragg
Novembre 1984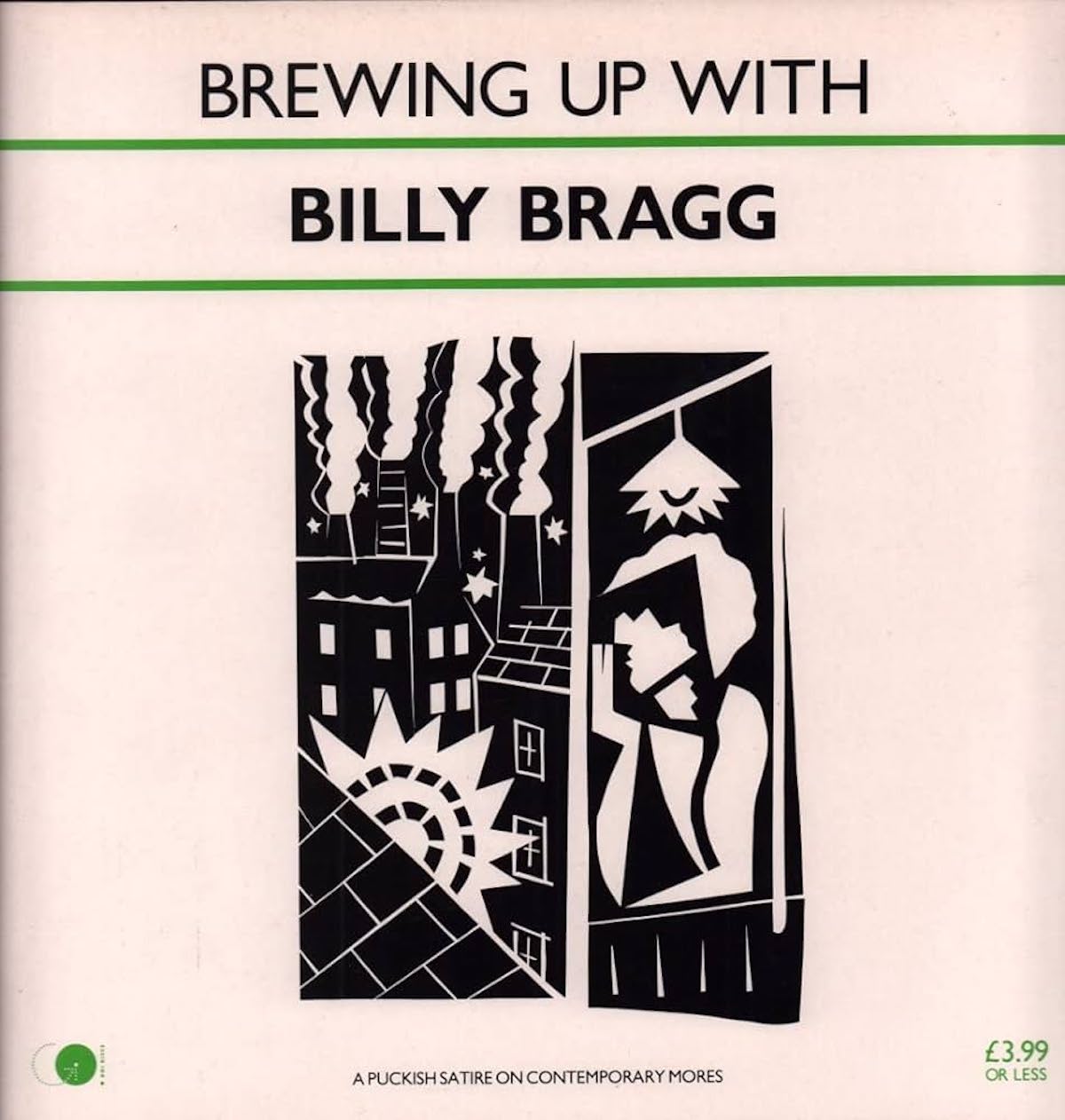
Il sottotitolo – “una maliziosa satira sui costumi contemporanei” – spiega bene il contenuto di questa “pausa tè” in compagnia di Billy Bragg, che alla prima prova sulla lunga durata dopo il mini LP dell’anno precedente si conferma personaggio atipico e carismatico: un arguto commentatore dell’attualità politica e dello stato della nazione (Island of No Return, la satira sui tabloid inglesi di It Says Here), cantore proletario sempre pronto a solidarizzare con la classe lavoratrice strangolata dalle misure economiche del governo Thatcher ma empatico anche nei confronti delle vicende sentimentali di goffi e teneri protagonisti che gli assomigliano (Love Gets Dangerous, The Saturday Boy e A Lover Sings, dove una seconda voce, una tromba o un organo si aggiungono per la prima volta ai suoi scarni arrangiamenti folk punk per voce e chitarra elettrica: un voluto mix tra Woody Guthrie e i Clash). A dispetto della inequivocabile “inglesità” del personaggio e del pronunciatissimo accento dell’Essex, il suo è un linguaggio comprensibile a tutti (chiunque può identificarsi con il senso di inadeguatezza e di rimpianto di canzoni come The Myth of Trust o St. Swithin’s Day), espresso con umanità e calore: tanto che per molti diventa quasi naturale attribuire a Bragg un ruolo di amico fidato o di ideale fratello maggiore, oltre che di acuta coscienza critica delle storture del suo Paese e di tutto l’Occidente.
















