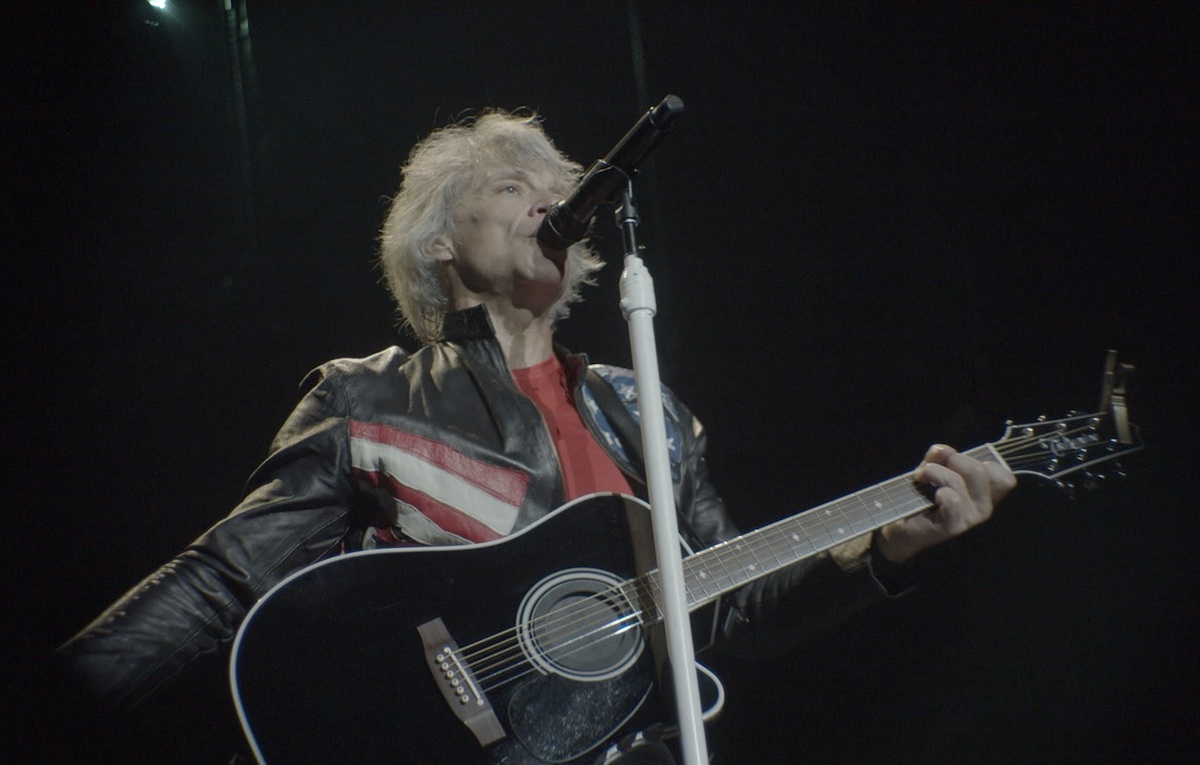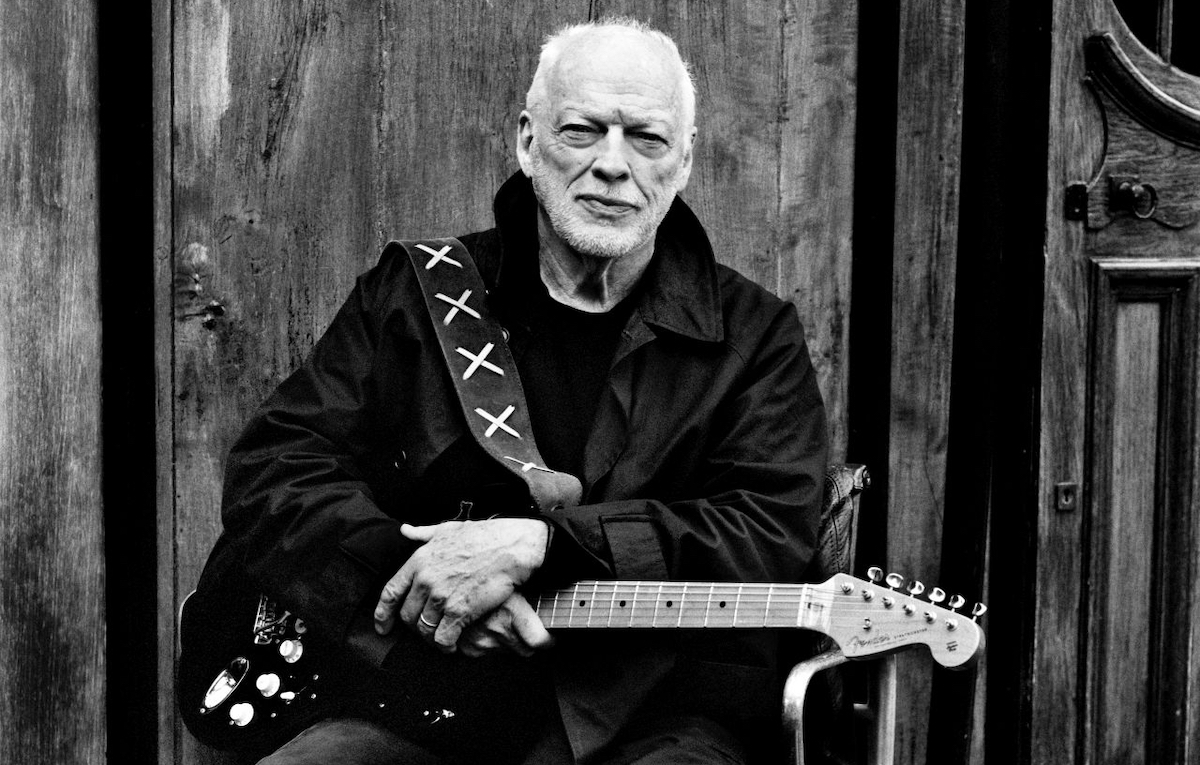Avete mai avuto la sensazione di essere presi in giro? È quel che disse più o meno Johnny Rotten all’ultimo concerto dei Sex Pistols. È quel che si prova assistendo al successo di certi album premiati dal pubblico e a volte anche dalla critica senza meriti anche se ogni disco – anche il peggiore – ha del buono e tracce che meritano. Ecco dieci esempi eclatanti. L’elenco sarebbe lungo, ma da qualcuno bisogna pur iniziare.
On Every Street
Dire Straits
1991
Già dalle prime note, si capisce che On Every Street porterà una band di successo e – piaccia o no – originale verso il tracollo artistico. L’album sembra registrato da un gruppo già defunto. Di vivo c’è solo l’intenzione di timbrare il cartellino per chiudere il contratto discografico e fare cassa con mezza idea allungata per 12 brani, di cui la gente non ricorda neanche i titoli. Persino i singoli sono spariti dall’inconscio collettivo: Calling Elvis, un country blues elettrico à la John Lee Hooker piuttosto scontato, e Heavy Fuel che, nonostante il testo ironicamente “estremo” e scorretto, elogia tutti gli habits negativi. E in effetti Knopfler aveva messo i Dire Straits in cantina già nel 1988 perché non ne poteva più della pressione del successo: possiamo immaginare per quale motivo ha cambiato idea (tocca comunque mantenere i propri privilegi a suon di carte di credito), ma il gioco non varrà la candela. Dopo il tour e la palata di soldi che si vedrà rovesciare sul tavolo, il suo matrimonio e la sua band svaniranno nel nulla. Già dai credits comunque era chiaro che qualcosa non quadrava: gli Straits ridotti a quartetto e intorno a loro una caterva di session man. E non bastano la chitarra di Phil Palmer (la sei corde di The Idiot di Iggy Pop) e la batteria di Jeff Porcaro dei Toto a salvare l’album. On Every Street otterrà il disco di platino e schizzerà in cima alle classifiche di mezzo mondo nonostante non valga un’unghia del precedente Brothers in Arms. È la forza di un marchio che si consuma a busta chiusa, come aveva già notato Knopfler: «Molte recensioni dicevano che eravamo la più grande band del mondo, non si mette l’accento sulla musica, ma sulla popolarità. Avevo bisogno di riposo». E se c’è qualcosa di positivo in On Every Street è la spinta che porterà Knopfler a pensare solo alla sua musica e non alla ribalta, con un coraggio raro in un simile ambiente.
Be Here Now
Oasis
1997
Dietro la creazione di inutili best seller, o quasi, c’è a volte la sindrome da sequel. Ci si ritrova ad essere la big thing del momento e a dover immediatamente confermarsi. Il risultato è Be Here Now dopo (What’s the Story) Morning Glory?. Gli Oasis hanno fatto il pieno di stereotipi da stardom e in qualche modo restituiscono tutto questo, in modo brutale, al pubblico. Non possiamo dire se sia un album onesto o no, sicuramente è una fotografia dello stato mentale del musicisti che in perenne psiche alterata dalla cocaina, in botta megalomane da essa indotta, decidono di registrare un disco epico, trionfale, insomma una roba eccessivamente pompata a mo’ di kolossal cinematografico, che però poi si sgonfia appena togli gli inutili overdub di chitarre, le sovraincisioni, gli effetti di compressione, ecc. Se infatti canti con la chitarrina acustica il singolo D’You Know What I Mean? ti ritrovi con una cosetta che scriverebbe un pivello alle prime armi. Tutto l’album è così, una promessa mancata e in pratica la morte degli Oasis. Addirittura molti (come il critico Jon Savage) specularono che in quel disco fosse concentrata la fine del Brit pop e dell’indie britannico tutto, e in questo senso è un documento di decadenza morale e artistica eccezionale. Ma se vogliamo parlare di musica, beh, basti pensare che Noel Gallagher in quel periodo soffriva di blocco dello scrittore e per mettere su i pezzi si imponeva una disciplina ferrea ma anche volendo ridicola, con orari da ufficio improbabili che non avevano nulla a che fare con l’ispirazione. Nello stesso tempo a causa dei dissapori tra Liam e Noel, col primo che si rifiuta di cantare ai concerti e l’altro che minaccia di cacciarlo a pedate, il management pensa di portare gli Oasis a registrare prima che si disintegrino con il risultato di metter su session tesissime, con gli Oasis che pensano solo a pippare. Il produttore Owen Morris non è convinto della qualità del nuovo materiale, esprime i suoi dubbi e Noel quasi lo silura per questa opinione più che legittima. La stampa inglese, all uscita del disco, darà sostanzialmente ragione al produttore con le sue critiche ampiamente negative. Nonostante ciò, l’album risulta un pazzesco successo commerciale. Se vogliamo trovargli dei pregi, è quasi un disco che strizza l’occhio al noise in quanto a impatto, violenza sonora, loudness war impunita e quasi pornografica, ma è un peccato che manchino le canzoni, che è quello che era da sempre la missione degli Oasis. In retrospettiva, come giustamente dice Noel, «solo perché vendi un sacco di dischi non vuol dire che sei bravo: guarda Phil Collins».
We Can’t Dance
Genesis
1991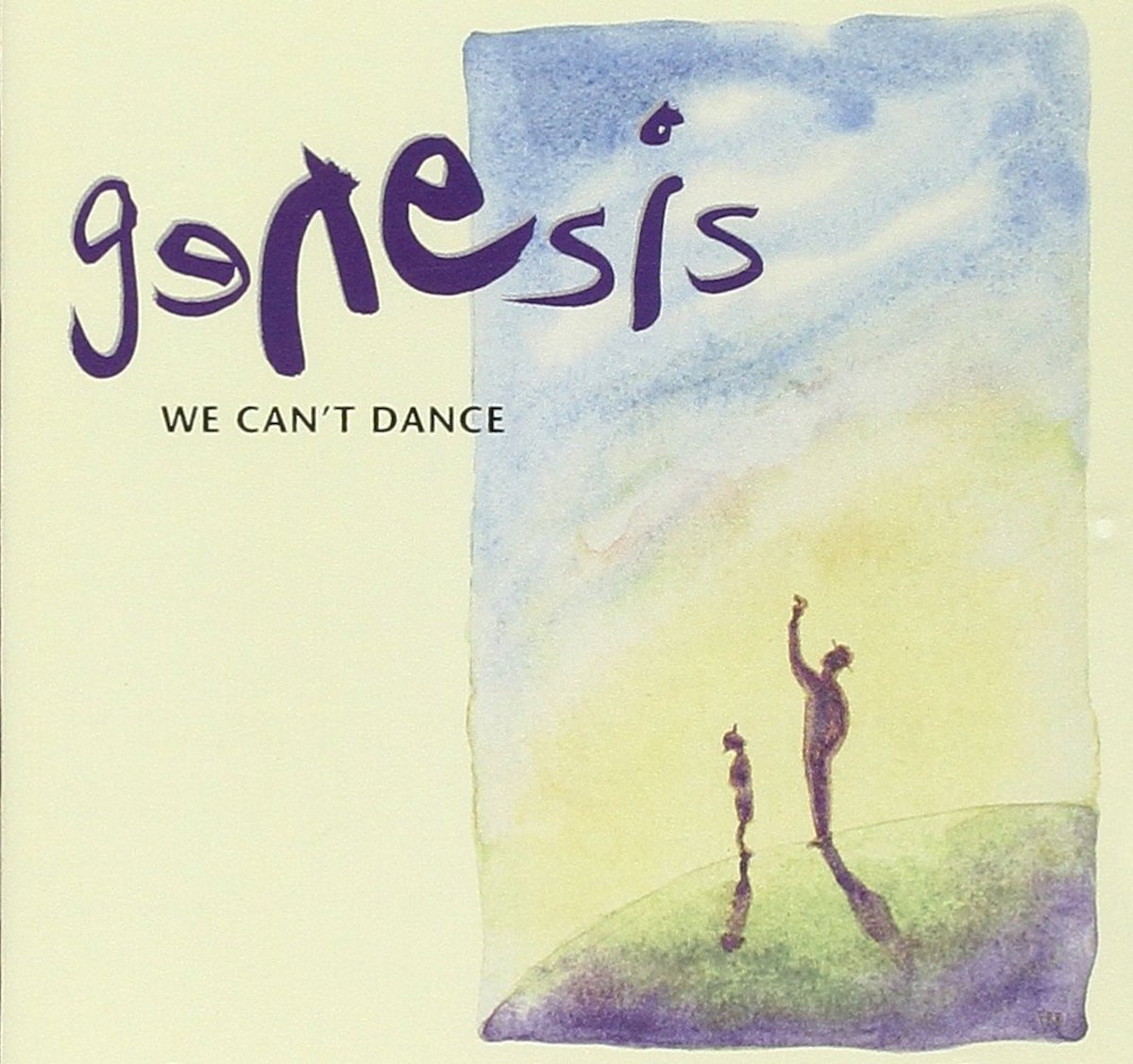
Non è chiaro come Phil Collins & soci siano riusciti a tirare fuori un disco così imbarazzante e non solo a farla franca, ma anche ottenere un successo mondiale, con oltre dieci milioni di copie vendute, nomination a pioggia e un American Music Award come miglior band. Evidentemente il segreto è proprio quello, piegarsi a un pubblico che si è dimenticato non tanto del prog – oramai seppellito dalla storia – ma del coraggio in musica, infilando dei testi in teoria critici sulla società e sarcastici sui costumi, ma fin troppo generici e telefonati che sanno molto di “sindrome U2”. La critica incredibilmente tenderà a un certo appecorinamento con poche eccezioni dettate dal fatto che i Genesis oramai sono visti come un side project di Collins, ovvero una band pop a tutti gli effetti. E da questo punto di vista We Can’t Dance è fin troppo straight nella sua forma. Persino una canzone sull’abuso di un quindicenne, ovvero No Son of Mine, sembra bubblegum music da pubblicità. Probabilmente uno dei grossi handicap è che il disco è stato scritto interamente in studio traendo spunti dalle session di gruppo, cosa che sulla carta potrebbe essere anche interessante e stimolante, ma in questo caso impedisce a Collins di avere materiale collaudato, che teneva per i dischi solisti. Mike Rutherford, tanto per sottolineare quanto questo album sia un passo indietro evidente, smette di usare la chitarra synth per un suono più tradizionale, e se vogliamo “ingenuamente” rock. Solo che da una parte bussa alle porte il grunge, dall’altra l’elettronica e i Genesis invece di fare quello che riesce loro meglio, cioè confondere le idee tra prog, art rock e hi tech, si rifugiano in un adult contemporary rock inoffensivo. Quando finalmente Collins lascerà, gli altri proveranno con Calling All Stations a creare una sorta di grunge prog con alla voce il cantante degli Stiltskin, Ray Wilson. La critica li stroncherà, il pubblico li ignorerà bellamente, ma almeno lì c’è il tentativo di cambiare le carte in tavola. Come da titolo, in We Can’t Dance regnano pantofole e divano: a ballare non ce la fanno proprio.
All That You Can’t Leave Behind
U2
2000
Se Phil Collins ha avuto il virus degli U2, ovvero buttarsi sulla critica sociale, gli U2 hanno avuto il morbo dei Genesis, cioè diventare adult contemporary senza neanche accorgersene. La mutazione avviene con questo disco, che segue l’album in cui gli U2 coraggiosi finiscono di esistere. Parliamo di Pop, che nei suoi eccessi, nei suoi difetti e nelle sue stravaganze mette il mito del gruppo alla berlina e rimane il testamento dei veri U2, quelli che se ne fottono del pubblico. La flessione commerciale li porta a più miti consigli. All That You Can’t Leave Behind accoppia alla produzione Brian Eno e Daniel Lanois per ricreare gli U2 che furono, quelli rock ma intellettuali, quelli che non sbracano, quelli che hanno sempre cose intelligenti da dire e una roba grottesca come Discothèque non l’avrebbero mai resa pubblica. E allora ecco Beautiful Day e The Edge che torna a suonare la chitarra con il set up del 1983 nonostante i compagni non siano d’accordo. Vendono oltre 12 milioni di copie e ottengono sette Grammy dando alla gente quello che si aspetta dagli U2: un disco – a prescindere dalla qualità delle canzoni in sé – scritto a tavolino per non alienarsi la fanbase già ampiamente irritata dal famigerato trittico Achtung Baby/Zooropa/Pop, e capace di aprire la fase “conservatrice” degli U2 che dura ancora oggi. Ci chiediamo che cosa sarebbe successo se il portatile smarrito da Bono contenente i testi ancora inediti fosse stato riportato al legittimo proprietario: probabilmente le cose sarebbero andate diversamente e gli U2 avrebbero definitivamente “lasciato dietro tutto quello che non potevano”, cioè il loro status, il loro brand, la loro reputazione.
Dangerous
Michael Jackson
1991
Immagina di essere Michael Jackson. Hai appena finito di promuovere Bad, è andato molto bene poiché ha retto il confronto con Thriller, anche se ovviamente è anni luce sotto. In una botta di paranoia decidi di silurare Quincy Jones per dimostrare che il tuo successo non è dovuto solo a lui. E così Jackson coinvolge nuovi collaboratori per stare al passo con le mode del momento. È soprattutto attratto dal new jack swing e chiama alla consolle il pioniere del genere, Teddy Riley. Non c’è quindi l’intenzione di innovare, ma inseguire la moda del crossover. Jackson mescola un po’ tutto, dal rap all’industrial all’r&b e soprattutto ci infila ancora una volta il rock. Il risultato è un disco che può affascinare per il tentativo di abbandonare la sindrome di Peter Pan e diventare finalmente adulto, ma le sue storie – analisi sociali, ansie egualitarie, appelli ecologisti e via dicendo – sono il parto di un ricco isolato nella sua Neverland che probabilmente vede il mondo da un televisore ultimo modello, a debita distanza. Probabilmente è proprio per il suo approccio semplicistico che è diventato un culto soprattutto nello sviluppo dell’r&b più generalista: è quel che richiede il pop moderno. In pratica è diventato paradossalmente un riferimento per i difetti trasformati in pregi. Dangerous sarà un successo commerciale spaventoso, ma non ha la genialità, né l’ispirazione di Thriller, è solo un esercizio di stile impeccabile, uno sforzo sovrumano per rimanere sulla breccia. Incredibile anche che sia considerato meglio di Invincible, quello sì – nella sua tormentata gestazione – disco innovativo e senza compromessi, ma si sa la gente chiede dalla musica emozioni un tanto al chilo e Dangerous di pericoloso ha solo il nome. Jackson voleva un disco che superasse il successo di Thriller. Non ce l’ha fatta, ma oltre 30 milioni di persone hanno comunque abboccato all’amo.
New Jersey
Bon Jovi
1988
Quando arrivi alla maggiore età ti rendi conto degli errori che fai nella vita. Il mio fu quello di aver comprato, appena adolescente, New Jersey di Bon Jovi, con la speranza che fosse meglio di Slippery When Wet che rappresenta ancora oggi un picco di un certo tipo di hard rock pennellato di glam. Alla fine ho rivenduto il vinile: New Jersey è un disco tamarrissimo, il cui unico interesse è forse la presenza di un brano proto lo-fi, Ride Cowboy Ride. Passi il singolo Bad Medicine, ma è di base un coro da stadio e soprattutto nasce da una frustrazione paranoica di Bon Jovi e Richie Sambora, ovvero quella di non essere più in grado di scrivere una hit come You Give Love a Bad Name. E infatti non ne erano più in grado, tanto che il primo pezzo che esce dalle session è Love Is War, poi relegato a B side, composto dalla medesima progressione di accordi di You Give Love a Bad Name. I Bon Jovi danno il meglio, ma New Jersey sembra la fotocopia appena più “zorona” di Slippery. Ad esempio, la storia di Born to Be My Babe è speculare a quella di Living on a Prayer, due giovani della working class che lottano per arrivare a fine mese, solo che è scritta da uno che oramai ha tanti di quei soldi che può mandarglieli lui e sistemarli seduta stante. Provano a fare anche qualcosa di sperimentale come nella intro di Lay Your Hands on Me, quasi in odor di Screamadelica, ma alla fine tutto – anche i solo, sempre puntuali per carità – ritorna all’arena rock più scontato. Negli Stati Uniti l’album sarà certificato sette volte platino e piazzerà cinque pezzi nella top 10. Sarà forse perché a scegliere la tracklist – dice la leggenda – furono chiamate delle babysitter con ragazzini al seguito anziché qualcuno che ci capisse qualcosa di musica?
The Miracle
Queen
1989
I Queen hanno educato tanti ragazzetti come me a una totale libertà musicale, all’importanza di spiazzare ed essere spiazzati. Ragion per cui quando uscì The Miracle molti corsero nei negozi di dischi, paghetta alla mano, curiosi di ascoltare cosa si sarebbero inventati dopo A Kind of Magic. Ce lo siamo fatti piacere. Uscì a ridosso del giugno 1989, molti fecero di I Want It All, Breakthru e The Invisible Man la loro colonna sonora estiva, ma cosa è rimasto delle canzoni del disco? Forse l’amaro in bocca. The Invisible Man sembra la versione 2.0 di Ghostbusters, Scandal uno scippo non proprio ispirato a Moroder, tra l’altro detestata da Roger Taylor, The Miracle non ha un centro e ha un testo di una tale ingenuità da far impallidire Michael Jackson. E poi ci sono brani come Party e Khashoggi’s Ship di un edonismo comprensibile solo a chi – come loro – poteva permetterselo. The Miracle è un passo falso nella carriera dei Queen, una sorta di regressione fanciullesca salvata solo dalla produzione e dal fatto che i nostri era scafati abbastanza da raddrizzare ogni situazione. Nel 1987 a Mercury viene diagnosticato l’AIDS, le cose non saranno più come prima. L’ottimismo particolarmente accentuato nel disco, a volte fastidioso, serve per non cadere nel baratro: per questo The Miracle ha un lato oscuro che è lasciato volutamente fuori dall’album e che invece avrebbe dato lustro al lavoro, completandolo. Innuendo in effetti avrà questo aspetto che lo renderà – coi suoi pregi e i suoi difetti – il testamento della band. Ad ogni modo il miracolo avvenne: numeri uno in vari Paesi, svariati dischi di platino e d’oro, un nuovo successo di una band in crisi.
The Division Bell
Pink Floyd
1994
Ci sono volte in cui uno si chiede: ma perché? È il caso dell’ultimo album dei Pink Floyd, omaggio postumo a Rick Wright, ovvero The Endless River: perché pubblicare una simile “crosta”? Forse però l’ultimo album ufficiale in studio era alla fine peggio perché non si trattava di materiale d’archivio editato, riveduto e corretto, ma roba inedita. Stiamo parlando di The Division Bell. C’è chi lo considera un ritorno ai Floyd classici e ne loda l’aspetto sincero e chi a un tentativo di allacciarsi alla new age in voga. E chi invece lo trova imbolsito e poco ispirato, per non parlare di Roger Waters che lo bolla senza mezzi termini come «spazzatura senza senso dall’inizio alla fine». I Floyd ci mettono cinque anni a farlo, ci si aspetta un botto creativo non indifferente che invece non c’è. Già dal concept (l’incomunicabilità, ancora?) è una specie di tentativo di riassumere la storia dei Pink Floyd con occhio nostalgico, tanto che tutti i brani bene o male hanno quel sapore di già sentito per il quale non ti ricordi neanche una nota nonostante ripetuti ascolti, ma ti rimane un sentimento fantasmatico di perdita assoluta, la perdita di una delle più grandi band del mondo. Che cerca di appigliarsi a una possibilità di evoluzione data dalla new age in ascesa senza però osare più di tanto, anzi della new age prende la parte più autocompiaciuta tanto che spesso ti chiedi se non stai ascoltando una compilation generalista della rivista omonima che all’epoca andava per la maggiore. I tentativi di attualizzarsi sono imbarazzanti come nel singolo Take It Back, dove sembra che David Gilmour voglia imitare gli U2, con quel delay alla chitarra. Se in A Momentary Lapse of Reason almeno c’era il fattore interessantissimo dei Floyd teletrasportati nell’era digitale, qui la band non rischia, non si espone, vuole stare al sicuro. Dalle session fu anche prodotta una traccia, un potenziale album di un’ora che venne battezzato The Big Spliff, tutta roba ambient: probabilmente la cosa giusta sarebbe stata pubblicare quello, ma i Floyd non avranno il fegato di farlo uscire neanche come commiato, tagliandolo a pezzettini dentro The Endless River (la cosa migliore di quel disco, indubbiamente). Ci si chiede come mai Gilmour non si sia prodigato a fare all’ epoca quello che farà con gli Orb nel 2010 con Metallic Spheres che proiettava il sound della sua chitarra in un paesaggio futuribile. Forse il rischio di un flop a una certa età può pesare, soprattutto sulle finanze. Le colossali vendite realizzate e l’affluenza di una massa di giovani al tour gli daranno ragione. Il brano che veramente avrebbe potuto dare una direzione sensata al lavoro è High Hopes, che dice tutto delle nostre misere vite e trasuda di emozioni lise, con quell’intro di campane a morto: un brano che avrebbe potuto cantare persino Kurt Cobain e che suona davvero eterno, la dimostrazione che se i Floyd vogliono alzare la testa sono imbattibili.
Mechanical Animals
Marilyn Manson
1998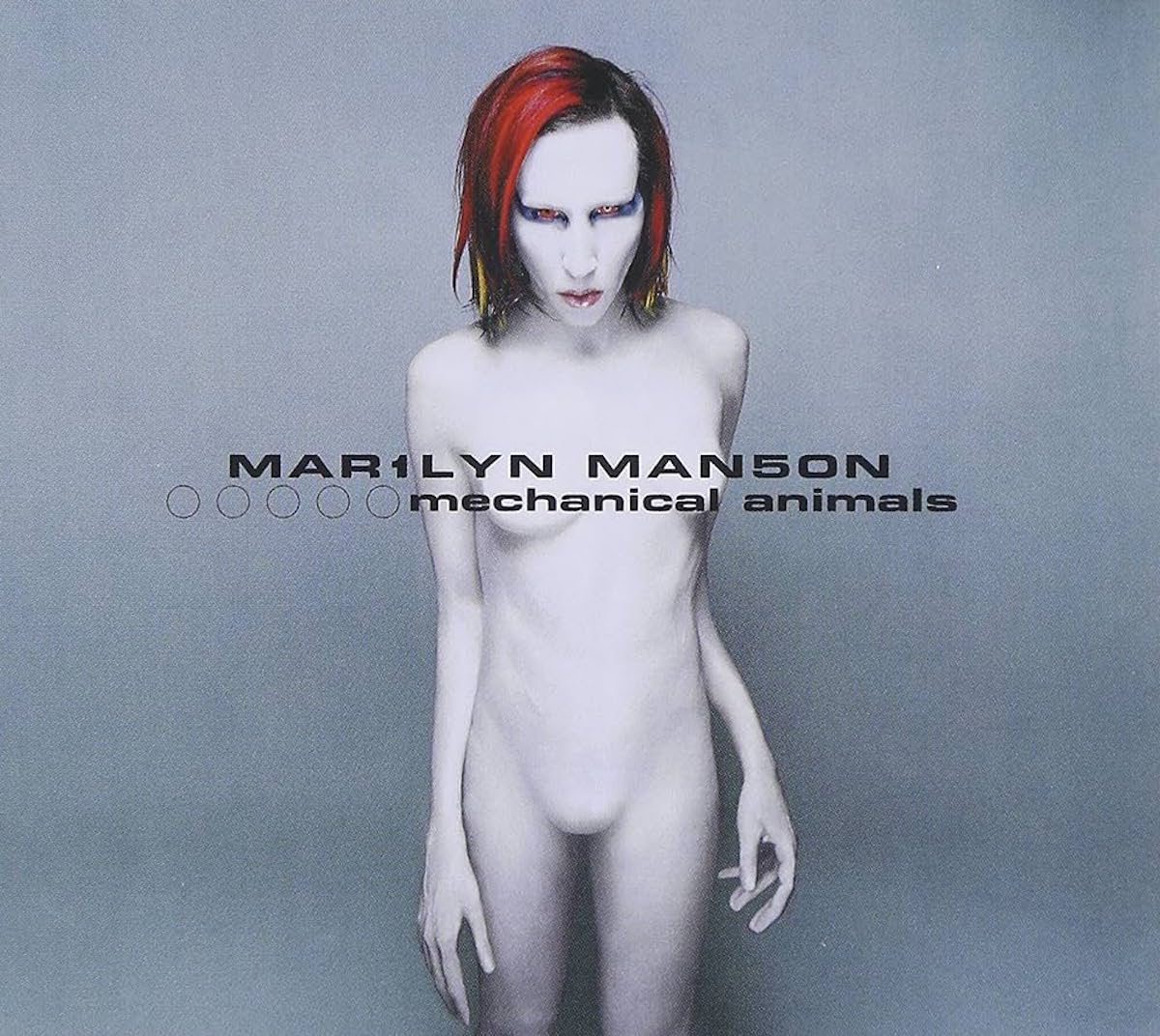
Dice Liam Gallagher che Marilyn Manson era un grande fan di Be Here Now, a causa del suo suono testosteronico. Non ci stupiamo che anche lui abbia pubblicato un disco il cui successo rimane spiegabile solo col fatto di uscire dopo il famoso Antichrist Superstar, ad oggi il lavoro che rappresenta meglio la band americana. Certo, pure Antichrist non era una novità, ispirato in maniera neanche troppo nascosta a The Wall dei Pink Floyd, dove tutto è portato forzatamente all’estremo e il cui valore artistico alla fin fine è da imputare alla produzione di Trent Reznor dei Nine Inch Nails. Una volta raggiunto un certo potere decisionale e cavalcando l’onda del successo, Manson decide di fare a meno di Reznor e mette su l’ennesima opera rock, stavolta un baraccone che prende di peso Ziggy Stardust e L’uomo che cadde sulla terra facendone un pappone industrial chic. Tradotto: quello che in un certo senso Gary Numan aveva già fatto negli ’80, ma amplificato dall’estetica “estrema” di fine ’90. È il disco più accessibile del catalogo di Marilyn Manson, anche i testi si limitano ad argomenti già digeriti come l’abuso di droghe (che palle), l’alienazione e tutto il resto (cose che Bowie aveva già stra-analizzato con la produzione berlinese), con titoli sufficienti per far aggrottare le ciglia, basti pensare a Rock Is Dead, concetto espresso già da Lenny Kravitz. Lo zoccolo duro dei fan non apprezzerà la svolta radio friendly, che però assicurerà alla band il suo primo numero uno negli Stati Uniti e tre dischi di platino con tanto di critica più o meno allineata a sostenerlo: leggenda vuole che il disco non abbia avuto ancora più successo perché sabotato dall’etichetta discografica che non apprezzava la copertina con un Manson androgino con tanto di protesi mammarie e per via del casino nato dalla tragedia della Columbine. Forse è meglio così: la band ha evitato di ritrovarsi un mano il suo Dangerous per concentrarsi su Holy Wood, l’ultima parte del trittico narrativo “in reverse” della saga di Marilyn Manson di fine anni ’90. Quello sì che è un disco che convince, ma resta un episodio isolato perché subito dopo il nostro “anticristo” cercherà di stare al passo con Korn e Slipknot, ovvero il massimo della musica di consumo degli anni 2000. Forse Manson voleva la normalità del numero uno e non fare il matto che osa.
Human Touch
Bruce Springsteen
1992
Il matto che osa è invece Bruce Springsteen, che in pieno delirio grunge invece di fare un disco rock si mette a pubblicare una roba patinata, guidata da sintetizzatori generici e soprattutto senza la E Street Band, appena sciolta. A livello di testi vuole fare qualcosa di positivo, canzoni felici in cui c’è un ottimismo di fondo. Non vuole più fare il personaggio del Boss. Solo per questo, Human Touch ha la nostra simpatia, ma è impossibile non notare che l’idea sulla carta frizzante non è stata messa bene in pratica. Se fosse uscito quattro anni dopo, maggiormente ponderato, forse sarebbe stato un capolavoro. Non era roba nata per il rock da stadio, ma neanche per un pubblico di affezionati. Aggiungiamoci la suprema cazzata di fare uscire Lucky Town nello stesso momento e possiamo capire come Springsteen fosse in una fase suicida. Però alla fine il disco vende più di un milione di copie solo negli Stati Uniti ed entra nei top 5 di mezzo mondo, Italia compresa.