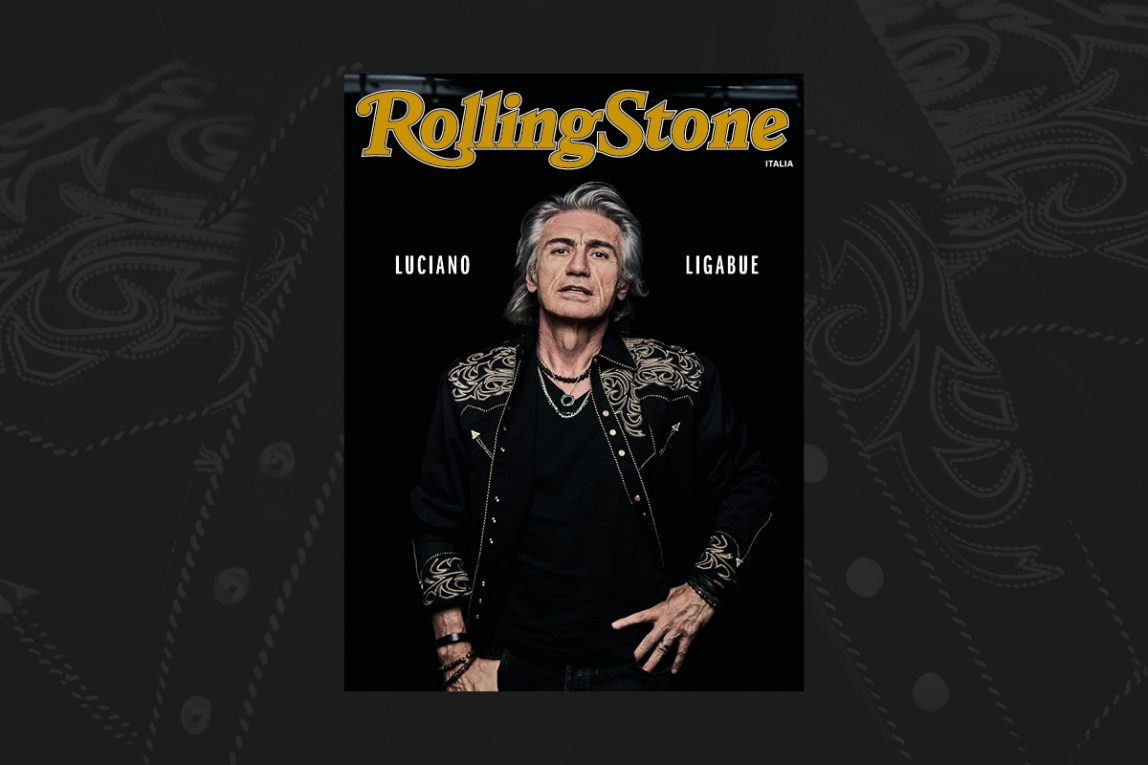Mike Garson è stato il musicista che più di ogni altro ha accompagnato David Bowie lungo il proprio percorso artistico. Qualcosa di stupefacente, se consideriamo la carriera di un artista capace di toccare praticamente ogni genere musicale e, per ovvi motivi, bisognoso di musicisti adatti al sound che quelle mutazioni richiedevano. Per capirci, il pianoforte di Garson era presente tanto ai tempi del primo concerto americano dell’allora Ziggy Stardust (parliamo dei primi anni ’70), così come nella sua ultima performance in assoluto.
Anche per questo, quando qualche mese fa Garson annunciò di aver ideato A Bowie Celebration: Just For One Day, sulla carta il più grande tributo alla figura di David Jones mai immaginato, le aspettative raggiunsero livelli elevatissimi. A differenza di altri tributi avvenuti negli anni precedenti, a colpire fu subito l’elenco di partecipanti alla serata: dalla band che l’aveva accompagnato durante gli ultimi tour, passando per gente come Carlos Alomar, Adrien Belew, Peter Frampton, Trent Reznor e Ian Hunter, la lista comprendeva la creme della creme di chi aveva vissuto in prima persona le gesta del Duca Bianco. Gente che aveva contribuito a rendere immortali alcune delle sue opere, che aveva usufruito della sua generosità o che, cresciuto con la sua musica, era poi riuscito a intrecciare il proprio percorso artistico con il suo.
Un omaggio monstre della durata di tre ore e mezza capace se non di colmare l’incolmabile, quantomeno di rendere giustizia a uno dei più grandi geni del ‘900. Va da sé che il rischio di delusione fosse direttamente proporzionale alla grandezza delle aspettative. Dopo uno slittamento di un giorno causa Covid (lol), la serata ha finalmente avuto inizio con un colpo da novanta: i Duran Duran, freschi della loro reinterpretazione di Five Years. Un’esecuzione convincente e sentita da parte di una delle tante band che avevano mosso i primi passi seguendo pedissequamente gli insegnamenti del Bowie di Scary Monsters. Una scelta azzeccatissima, capace di portare immediatamente la serata sui binari sperati. Il timore maggiore riguardava l’effetto da concerto in streaming.
Il fatto che non tutti gli ospiti potessero essere presenti nella location losangelina scelta da Garson poteva trasformare la diretta in uno dei tanti eventi trasmessi negli ultimi mesi: collegamenti svogliati dagli studi casalinghi dei vari musicisti, uniti a collage video che potessero colmare in qualche modo le distanze obbligate. Invece, la scelta di avere una backing band presente in studio, che cambiava a seconda del periodo storico affrontato, ha saputo fare da collante ai collegamenti oltreoceano, resi per altro più credibili da giochi di regia tanto semplici quanto efficaci. In più di un’occasione, grazie a un utilizzo inedito di monitor a grandezza naturale, era davvero difficile capire chi fosse davvero sul palco con Mike Garson e chi invece a migliaia di chilometri da lì.
In questo senso, la performance migliore è stata forse quella del leader dei Def Leppard Joe Elliott, la cui interpretazione di Win, riarrangiata per soli piano e voce, ha definitivamente fatto decollare un concerto che, complice un’incerta Space Oddity cantata da un emozionato Billy Corgan, sembrava poter prendere una piega decisamente soporifera. A evitare che ciò accadesse hanno contribuito poi Peter Frampton con una tiratissima Suffragette City, un Trent Reznor sempre più somigliante al nostro Omar Pedrini con Fantastic Voyage e, soprattutto, una versione devastante di Fashion e Gary Barlow (sì, proprio lui) con una Fame praticamente perfetta.
Forte anche la presenza dei Jane’s Addiction, con un Perry Farrell in grande spolvero nel rievocare The Man Who Sold The World accompagnato da Tony Visconti e Dave Navarro e Chris Chaney a dare manforte ai tamarrissimi Taylor Hawkins e Corey Taylor su Rock ‘n’ Roll Suicide e Hang On To Yourself. Queste ultime, suonate in uno studio separato che faceva molto Unplugged degli Alice In Chains, avrebbero meritato il premio per il miglior momento della serata, se non fossero giunte appena prima degli arrivi di Boy George e Ian Hunter.
Il primo, protagonista di uno spettacolo in grado di unire un po’ tutte le arti di Bowie, dal travestimento al mimo, ha incantato e commosso come nessuno prima di lui con uno splendido medley di brani tratti da Aladdin Sane. Mentre il leader dei Mott The Hoople, prima dell’inevitabile All The Young Dudes, è stato l’unico a poter proporre un brano proprio, ma comunque a tema Bowie: a qualche anno dalla morte, la sua Dandy resta ancora l’omaggio più riuscito scritto da un’artista della sua generazione.
La presenza di Ian Hunter non poteva che far tornare alla mente lo storico momento in cui lui, Bowie e Mick Ronson si erano ritrovati dopo anni sul palco dello stadio di Wembley per celebrare il mito di Freddie Mercury. Fino a quel momento, Garson era riuscito nell’impresa più difficile: quella di non trasformare la serata in un triste elenco di figurine mancanti. Una sensazione durata comunque pochi istanti, giusto il tempo di farsi trasportare lontano dalle note di Heroes e dalla sensazione che sì, anche se solo per un giorno, con la giusta cura anche un evento in streaming può trasformarsi in qualcosa di catartico.