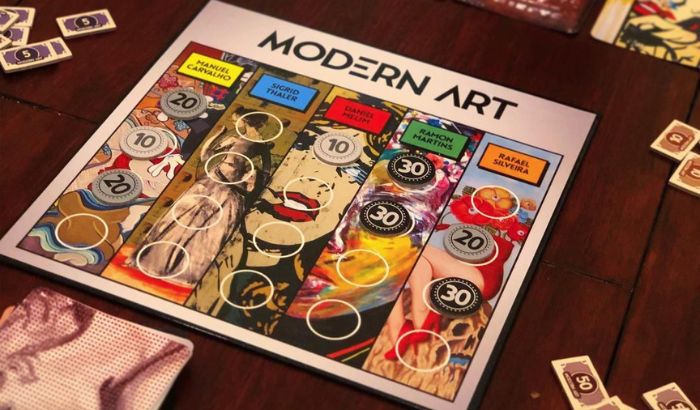Divano venduto come un due posti con possibilità di trasformazione in letto, e rivelatosi poi di misero utilizzo persino alla sola persona che voglia stendere appena le gambe per mettersi sulla pancia il gatto. Cucina fabbricata nell’anno domini 1973, con antine cigolanti e piano cottura a gas la cui pericolosità allarma i vigili del fuoco costantemente. Un agghiacciante tavolino di plastica ripiegato e appeso alla colonna, da aprire nel punto più accessibile al momento del veloce (e sempre più infrequente) pasto. Il mobile più sottile mai fabbricato appoggiato a ridosso della parete nord, dove troneggia un anonimo televisore che perde segnale al primo colpo di tosse del vicino orrendo. L’unica finestrella (e per di più risultante da abuso architettonico), lasciata aperta per ossigenare noi, incauti locatari, quando ci apprestiamo al pagamento del canone mensile fissato a tre/quarti del nostro (misero) stipendio da impiegati a tempo assolutamente determinato (sei mesi, sostituzione maternità). Madre e padre in visita per la prima volta ai figli single, trentenni, d’incerto futuro e fresco trasferimento, nella giornata più uggiosa che Milano possa ricordare.
«Pensavo fosse più grande», dice nostra madre, confermandosi quell’essere che ci mette al mondo e ci cresce con amore, salvo poi darci il colpo di grazia mentre si siede con finta indifferenza sul nostro divano, acquistato con uno svantaggiosissimo finanziamento. «Questi forse si riescono a sistemare», rincara nostro padre, con la voce che giunge sopra il raccapricciante cigolare di un pensile della cucina, la cui antina viene aperta e chiusa senza pietà al fine di uno studio attento. E lo sapevamo già, che la distanza che separa la cucina dal divano è tre passi di numero, ma lei, la madre, che ora si alza per andare vicino a lui, il padre, e dire senza dubbio la propria in merito, è la conferma che aspettavamo da tempo: a seconda della falcata, nella conta dei passi c’è giusto quella variabilità di “mezzo”. Ma adesso l’urgenza è un’altra: che nessuno dei due umani in visita chieda di poter andare in bagno prima di uscire tutti insieme a pranzo, ché lo sciacquone del water ancora non funziona, l’idraulico pare essere imbottigliato nel traffico meneghino in un tempo che oscilla tra “mai” a “sempre”, e – quel che è peggio – la vista delle piastrelle arancioni potrebbe suscitare un qualche malore che manda al camposanto.
«Sono ancora in pigiama», diciamo, al fine di distrarli del tutto dall’inevitabile capatina in bagno. Ed è vero: sono le undici e trenta del mattino ma abbiamo ancora su un pile, infilato in quel pantalone che ci va largo; l’unico capace di raggiungere l’altezza ascellare per ripararci dal freddo nelle gelide notti che filtrano dagli infissi. In testa: un basco osceno capitato in sorte solo qualche giorno prima in occasione dell’imbarazzante Secret Santa dell’ufficio, e indossato durante la perlustrazione del pensile da parte dei genitori, con il chiaro intento di aggiungere distrazione alla distrazione. Lo sguardo perso degli ospiti indesiderati rivela il successo del piano ordito da tempo; il momento è quello giusto per sparire dentro l’armadio alla nostra destra, che funge altresì da camera da letto. Quando riemergiamo, siamo con tanto di giaccone pesante, a espressione della più severa urgenza nell’uscire di casa.
È tutto molto fantozziano: lo slittino usato per scendere i quattrocento scalini del condominio senza ascensore; la cacca di cane pestata sul marciapiede appena fuori dal portone e che proprio non avevamo visto, perché sul cellulare era arrivata la notifica della mail del nostro capo nelle uniche tre ore libere degli ultimi 92 giorni da sottopagati, da inoltrare con urgenza all’ufficio raccomandazioni e promozioni del 18esimo piano; il cielo che ora si è aperto ovunque, tranne che per questa nuvola sopra le nostre teste, da cui scende una pioggerella sottile, fastidiosa come la morte e inevitabile come il giorno dopo la piega dal parrucchiere; l’ombrello rotto durante la discesa con lo slittino; lo sciopero dei trasporti pubblici, a cui si combina sapientemente la chiusura delle strade principali del centro per la maratona dei fruttariani a difesa della dignità dei peperoni verdi; il monopattino elettrico a noleggio, uno per tutti e tre, disponibile a un chilometro di distanza. «Ma perché non ti compri una macchina?», chiede nostro padre, che guida senza logica alcuna; «Sarebbe meglio andare sempre in taxi», gli risponde quella chiamata madre, che sta dietro a lui e davanti a noi, col cappello di pelliccia che ci finisce in bocca. A ogni sanpietrino che fa vibrare le nostre guance, e a ogni topicco che prendiamo, un sospiro che dice “Me, tapino!” ci esce dalla bocca insieme a un ciuffo di pelo di volpe argentata.
Tre infarti e quattro costole rotte dopo, il ritardo accumulato per il pranzo prenotato dai genitori nel ristorante di Cracco, si aggira attorno alle quattro ore e ventisette minuti. L’unica soluzione ormai possibile è lì pronta: il pietoso e carissimo pranzo nel bar turistico di turno, dove un cameriere armato di menù ci mostra fotografie di lasagne al sapore di tradimento e cotolette fritte negli scontrini non emessi. «Venghino! Venghino!», dice lui; «Bravo ragazzo, come parla bene! Il congiuntivo ormai non si sente più», commenta nostro padre sedendosi al tavolino dove le gambe non ci stanno neppure per quel po’. Poi sentiamo un tonfo: è il cameriere che ha sistemato il passeggino di una giovane coppia lanciandolo oltre il bancone, direttamente in cucina, dove probabilmente verrà fatto a pezzi e servito come dessert. Guardiamo quei due clienti: non sono italiani, ma non superano i trent’anni. «Chissà quando ce ne fai uno anche tu, di nipotino!», è l’inevitabile commento di coloro che ci hanno messo al mondo alla vista dell’infante che dorme in braccio. Di tutta risposta, quel Tinder che ultimamente usiamo come degli ossessi, suona una notifica.
«Sono terminati i nitrati per il prosciutto», ci dice ora il cameriere. Risultato: il toast molle che abbiamo ordinato non ci verrà servito; al suo posto, una frittatona di cipolle. Davanti al piatto, una certa associazione agghiacciante inizia a solleticarci il pensiero, e con il primo boccone la frittatona diventa la nostra madeleine di Proust: ma certo, come abbiamo fatto a non pensarci prima! Tutta questa giornata ricorda la vita e le imprese non-memorabili del Ragioniere Ugo Fantozzi. E sarà perché negli ultimi giorni ci siamo rivisti tutti i film in streaming, o perché l’osceno basco che abbiamo ancora in testa è adesso appiattito, proprio come lo “spagnolin” genovese del Fantozzi più depresso che mai, in un fiume di amarezza ci troviamo a esclamarlo: «Quanto vorremmo essere Fantozzi oggi!».
Quel ragionier Ugo dell’omonimo romanzo del 1971 di Paolo Villaggio, e che ebbe un tale successo da portarci l’esempio dell’italiano medio anche sul grande schermo (Fantozzi, 1975). Con una chiara intenzione: di far ridere la generazione di allora, che sguazzava nel benessere al punto da considerare mediocre la vita costellata di certezze di una persona qualunque, per quanto inetta. Mentre noi, i millennial cresciuti nel confronto con i giovani di allora, i nostri genitori; noi, che ci impicchiamo dietro a tutto; noi, a ogni boccone del frittatone di cipolle lo ripetiamo: «Quanto vorremmo essere Fantozzi oggi!».
Con una casa di proprietà in centro, seppur in equo canone e che si affacci su una strada trafficata; ma non con la sola scelta di un monolocale in affitto, pagato un salasso per andare comunque in pezzi. Con la certezza dell’assunzione a tempo indeterminato per un impiego, e pur considerato mediocre, o senza ambizioni; ma pur sempre garanzia che la nostra indipendenza economica non sia appesa a un filo. Con la possibilità di avviare una famiglia con chi amiamo, di provvedere alle necessità del caso; per quanto poi si possa correre il rischio di incappare in un amore che si trascina, o in una figlia il cui aspetto fisico è motivo di scherno. Con un modo di vivere, infine, che per quanto possa sembrarci minacciato dall’arrivo (e non ogni 14 mesi circa) di una nuvoletta carica di pioggia, sia quel che deve essere: finalmente dignitoso. Anche se dignitosamente fantozziano.