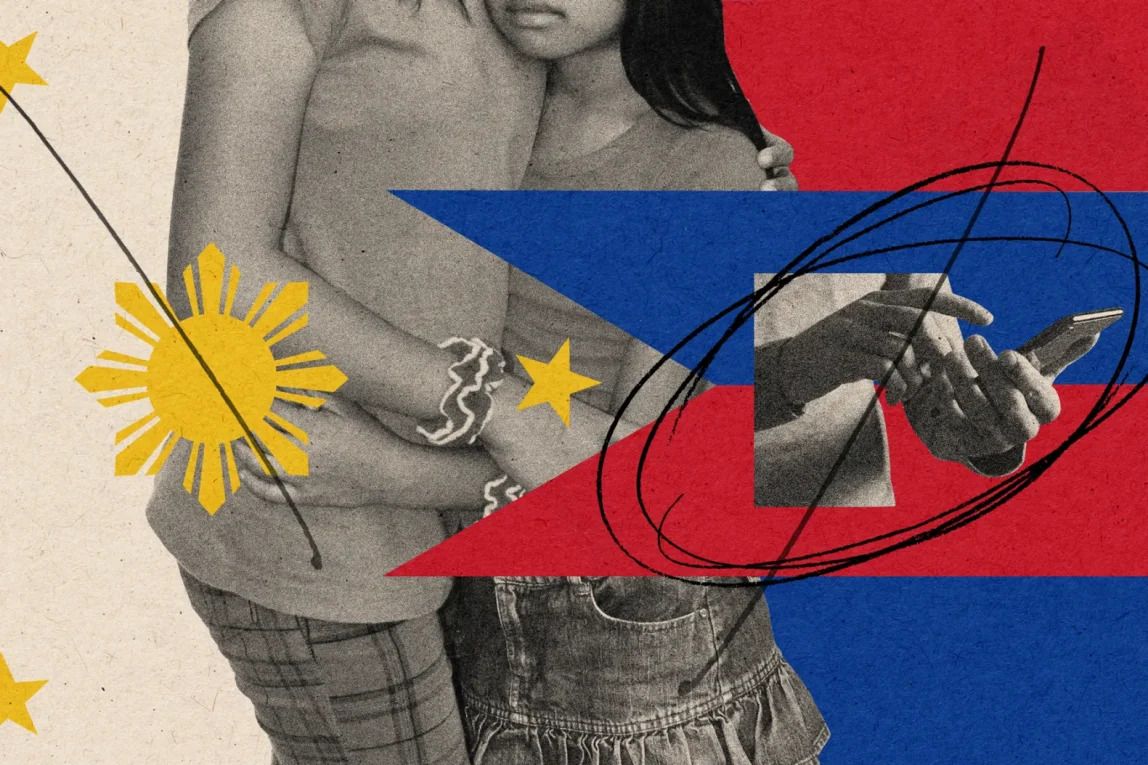Sembrava piccola per avere tredici anni, e si raggomitolava dentro un cardigan indossato come una mantella. Nella stanza faceva caldo e appiccicoso, anche per essere gennaio, un mese particolarmente umido nelle Filippine. Mi afferrò la mano mentre raccontava la sua storia, mentre Cecilia Oebanda-Pacis — fondatrice e direttrice di questo rifugio nascosto — traduceva dal tagalog. Eravamo seduti in cerchio, una trentina di ragazze in un campus nascosto in alto tra le montagne. Accanto a me c’erano bambine di appena cinque anni, in attesa di raccontare la propria storia. Ma Arianna — la chiameremo così — aveva bisogno di parlare per prima. Il suo passato sembrava volerle esplodere fuori dal petto.
«Prima di arrivare qui… quando avevo undici anni», cominciò, «ho avuto un bambino da mio nonno…». All’inizio sorrideva — un’espressione forzata, di coraggio — e la mantenne finché non scoppiò a singhiozzare. Io ascoltavo in differita, in attesa della traduzione; la mascella mi si è spalancata quando ha pronunciato quell’ultima frase. Le più piccole abbassarono la testa, ma io non riuscivo a distogliere lo sguardo: Arianna si stava spezzando davanti a me. Le presi la mano e la tirai in un abbraccio; pianse ancora più forte tra le mie braccia. Come tutte le altre ragazze qui presenti, era stata allontanata dalla sua famiglia per il ruolo che aveva avuto nei suoi abusi. Arianna, però, portava anche il peso di essere stata separata dal suo bambino. Volevo piangere con lei, ma mi sembrava un diritto non mio. Così la tenni stretta, gli occhi lucidi, finché non smise di piangere.
Questo è successo quattro mesi fa, sulle colline che si ergono a nord e a est di Manila. Ero appena tornata, con il jet lag, da un semestre di liceo negli Stati Uniti, e tutto intorno a me mi sembrava familiare ma confuso, come l’inizio di un incubo. Il caldo claustrofobico, l’umidità nelle narici, le zanzare che non smettevano mai di ronzare. Ero stata invitata a visitare questo rifugio, chiamato Center of Hope, da mio padre, un uomo d’affari.
Negli ultimi sei anni, la nostra famiglia ha donato ingenti somme alla sua organizzazione no-profit madre, un’azienda chiamata Voice of the Free. La missione di VF è salvare quante più ragazze possibile dalle grinfie dei trafficanti di esseri umani nelle Filippine. Per decenni, il mio Paese è stato un bazar a cielo aperto per lo sfruttamento sessuale dei minori. Nel 2021, l’anno più recente per cui si hanno dati, più di 800.000 filippini sono stati rapiti dalle bande che dominano questo traffico nel Pacifico meridionale. Tra le ragazze di quel gruppo, molte furono vendute a bordelli in Asia; altre furono spedite a papponi in Europa o date in sposa a pedofili all’estero.
Ma la maggior parte delle ragazze in questo rifugio era sopravvissuta a un altro tipo di orrore: erano state sfruttate sessualmente da un famigliare per sostenere la famiglia. Gran parte di questi abusi avvenivano in casa, online. C’erano ragazze in questo gruppo che apparivano in video, nude, dall’età di un anno. Ci incontrammo in una grande stanza al piano terra di un edificio che fungeva sia da scuola che da dormitorio del Center of Hope. Si unirono a noi nel gruppo i 12 adulti che lavoravano come personale a tempo pieno. Molte erano insegnanti e terapiste; altre erano tate e domestiche. Le ragazze erano profondamente legate a tutte loro, afferravano le loro mani e si sedevano sulle loro ginocchia. Ma le ragazze più grandi sembravano aggrapparsi a Oebanda-Pacis, che ha fondato Voice of the Free nel 1991 (ha aperto questo rifugio in cima a una collina nel 2014; considerando i suoi uffici in altre città, è una delle cinque strutture che gestisce attualmente).
Natalia Paradies con I residenti del Center of Hope. Foto: cortesia
Figlia di dissidenti politici incarcerati dal regime di Marcos, ha trascorso metà dei suoi vent’anni in prigione, dando alla luce due figli in prigionia (anche suo marito Ricardo era detenuto in quella prigione). Poco dopo il suo rilascio nel 1990, è stata avvicinata da una madre la cui figlia era scomparsa a Manila. La ragazza «è stata prelevata dalla sua provincia per lavorare come domestica» all’età di 12 anni, racconta Oebanda-Pacis. «L’abbiamo trovata in prigione» – era stata falsamente accusata di furto dal suo datore di lavoro – «e abbiamo convinto la polizia a rilasciarla».
In quell’atto di misericordia non retribuito, Oebanda-Pacis trovò la sua vocazione. Reclutò volontari — molte erano madri — per passare al setaccio i parchi di Manila alla ricerca di ragazze scomparse. Ne trovarono più di quante sapessero gestire: la città era piena di bambine attirate o rapite dalle baraccopoli. «Tutto questo è successo prima che esistessero leggi sul traffico di esseri umani nelle Filippine», racconta Oebanda-Pacis. «Le ragazze venivano (ingannate con, nda) la promessa di un lavoro e di una vita migliore a Manila (dai trafficanti, nda), poi venivano costrette nei bordelli e nei nightclub».
Aprì il suo primo rifugio nel 1995, poi condivise le sue competenze con le forze dell’ordine. Nel corso dei decenni ha stretto collaborazioni con la polizia locale e con la Federal Port Police. Lavorando insieme, hanno salvato decine di migliaia di ragazze nei porti e nelle città delle Filippine. A un certo punto, era arrivata a gestire 80 dipendenti e passava più tempo sulla burocrazia che sulla sua missione. Così, undici anni fa, trovò un accordo con le autorità: assorbirono la maggior parte del suo personale, così lei poté concentrare l’attenzione su questo rifugio. Delle 25 donne che impiega oggi, circa la metà sono ex residenti del Center of Hope.
Quella mattina, le ragazze mi portarono a vedere le loro stanze. I miei occhi si fermarono sui disegni sopra i loro letti. Colori vivaci, rosa e gialli accecanti, nei dipinti del giardino e nei ritratti di loro stesse mentre giocavano a rincorrersi: un senso collettivo di rifugio. Ma c’erano anche, in alcune immagini, cieli neri e foreste spettrali. «La pittura è uno dei modi in cui le nostre ragazze ci dicono che stanno soffrendo, prima ancora di riuscire a dirlo a parole», spiega Oebanda-Pacis. «Può volerci moltissimo tempo per guarire, soprattutto per quelle con i traumi peggiori».
Cecilia Oebanda-Pacis (davanti, terza dalla destra). Foto cortesia
Al piano di sotto qualcuno fece partire una canzone pop: le ragazze avevano preparato un balletto in mio onore. Io sono una pessima ballerina e una cantante ancora peggiore, come mio padre ama ricordarmi. Ma erano così piene di gioia mentre urlavano le parole che, dopo un attimo, mi unii a loro. C’era qualcosa di meraviglioso nelle loro voci — e di sfidante. Mi stavano cantando la loro canzone di sopravvivenza.
Provengo da una famiglia molto numerosa di Manila, la capitale delle Filippine. Talmente numerosa che, per la nostra riunione di famiglia dell’estate scorsa, abbiamo affittato un resort sull’isola di Cebu — e si sono presentate 400 persone per il weekend. I miei genitori hanno cresciuto me e i miei due fratelli in un quartiere protetto nel centro di Manila; per anni, uscivo dai cancelli solo per andare a trovare parenti in una villa poco distante. Grazie a quell’isolamento, avevo pochissima percezione di come fosse la vita per la maggior parte dei bambini del mio Paese (a mezz’ora da casa mia, alla periferia di Manila, milioni di bambini vivono nelle baraccopoli con meno di un dollaro al giorno). Poi, quando avevo 10 anni, i miei genitori mi iscrissero a un coro di Natale che stavano finanziando. Dopo il concerto, mio padre mi fece sedere e mi mostrò delle foto di scuole in mattoni costruite nelle province. «Hai fatto qualcosa di molto più grande di quanto pensi», mi disse. «Il concerto in cui hai cantato ci aiuta a costruire scuole per i bambini poveri che non le hanno».
Ero confusa — ma capii presto l’impegno della mia famiglia nel servizio pubblico. Per esempio, il nostro grande clan possedeva aziende di energia solare e donava ogni anno migliaia di pannelli alle comunità povere con scarse forniture. La nostra famiglia possedeva anche una banca a Manila: finanziava associazioni che distribuivano cibo alle famiglie povere e sosteneva la costruzione delle scuole. Tutto questo era una novità per me. Mio padre andava a lavorare ogni giorno in un birrificio con jeans e una camicia da lavoro (aolo più tardi avrei scoperto che era lui ad aver fondato quel birrificio). Mia madre restava a casa con noi; la nostra casa era grande, ma non lussuosa. Mi ci sono voluti anni per capire davvero quanto fossi fortunata — e quanto fossero determinati i miei parenti a costruire opportunità per i bambini nati con molta meno fortuna.
Poco dopo aver capito che eravamo ricchi, ebbi il mio primo incontro con la povertà. Frequentavo la International School of Manila, il cui motto è Integrità, Servizio e Merito. Dalla prima media in poi, la mia classe partecipava a progetti settimanali che ci portavano nelle risaie roventi, diverse ore a nord. Lì lavoravamo nel fango e nel caldo insieme a braccianti disperatamente poveri — alcuni erano bambini della nostra età. Andavamo in fattorie polverose a selezionare prodotti, togliendo vermi dalle verdure lungo le linee di cernita. Più vedevo, più sentivo il bisogno di capire come i bambini poveri venivano sfruttati.
Poi, al liceo, sentii i miei genitori parlare di Voice of the Free. Avevo una vaga idea del traffico di esseri umani — ma nelle Filippine è un segreto doloroso, quasi mai menzionato nelle notizie o sui social. Ancora una volta, incalzai i miei genitori; mi avvertirono che era un argomento molto cupo. Ma insistetti, cercando informazioni online e continuando a far domande su Voice of the Free. Mi spiegarono che aiutavano VF a finanziare la formazione della Port Police per riconoscere trafficanti e vittime in transito. Poi, l’anno scorso, mi misero in contatto via email con Cecilia Oebanda-Pacis. Lei mi invitò a visitare il Center of Hope e — se me la sentivo — incontrare alcune ragazze.
Questa estate sono tornata al Center of Hope, con l’obiettivo di fare più della semplice volontaria. Ho chiesto a Oebanda-Pacis se potessi realizzare un cortometraggio sul rifugio e sulle donne che ci lavorano. Al minimo, il video sarebbe finito sul loro sito, per mostrare al pubblico cosa fa realmente VF. Nel migliore dei casi, avremmo potuto condividerlo ampiamente sui social, raccontando l’orrore del traffico di esseri umani nel mio Paese e la devastazione che infligge ai bambini poveri. Lei ha detto sì, con una condizione: stare lontana dalle bambine più piccole, che erano ancora in pericolo per mano dei loro abusatori.
Dopo molti tentativi ed errori – ero tanto goffa come videomaker quanto come ballerina – sono finalmente riuscita a mettere a fuoco i miei soggetti e ho chiesto loro di raccontare le loro storie. Ave, una donna vivace sui venticinque anni, era la più giovane di 12 figli di una famiglia di contadini che viveva di riso e verdure. Un giorno, uno sconosciuto ben vestito si avvicinò ai suoi genitori. Vostra figlia, disse, è una bambina dotata; vorrei mandarla a scuola a Manila per mantenere la sua promessa. L’uomo mantenne la parola, pagò la retta di Ave e le riempì l’armadio di bei vestiti. Ma un mese dopo che Ave si era trasferita dall’uomo, lui la fece sedere nella sua stanza dei computer e la mise in contatto con degli sconosciuti online. Ben presto, quegli sconosciuti chiesero alla bambina di nove anni di spogliarsi; alcuni di loro volarono a Manila per incontrarla.
Ave. Foto cortesia di Center of Hope
Per cinque anni, Ave e gli altri bambini intrappolati lì – tre dei quali avevano sei anni o meno – furono brutalmente sfruttati dal loro trafficante finché un vicino non chiamò la polizia. «La polizia ci ha salvati e poi ci ha portati qui», racconta Ave. «La mia guarigione è stata molto difficile – sono rimasta per 10 anni – ma (lo staff, nda) è diventato la mia famiglia e i miei angeli». Un anno fa, Ave si è laureata a Manila in ospitalità. Ora è la coordinatrice degli eventi per VF, condivide i suoi guadagni con i genitori e i fratelli e aspetta il suo primo figlio con il marito.
Quando le ho chiesto perché si fosse seduta con me, i suoi occhi si sono illuminati di determinazione. Ave ha lottato per anni per far sì che il suo trafficante rispondesse delle sue azioni, raccontando ripetutamente la sua storia in tribunale. «Quell’uomo ora è in prigione a vita, e io sono libera e al sicuro. Ma (continuo a, nda) parlare per fermare gli abusi. Non voglio che altri bambini siano vittime». Oebanda-Pacis condivide la sua determinazione. Nel corso di 30 anni, ha costruito un esercito di alleati per affrontare il vergognoso segreto del suo paese. «Ora abbiamo partnership con chiese, aziende, governo e scuole», afferma. Ha anche aiutato la polizia a creare centri di accoglienza per le ragazze che salvano dai trafficanti. Il suo nuovo obiettivo è raccogliere fondi per un trattamento comunitario, in modo che queste bambine possano guarire più vicino a casa. Fino ad allora, continuerà a formare le ragazze di cui si prende cura per essere la prossima generazione della resistenza. «Le nostre armi segrete sono l’accettazione e l’amore», dice Oebanda-Pacis. «Sappiamo fin troppo bene cosa hanno passato queste ragazze».