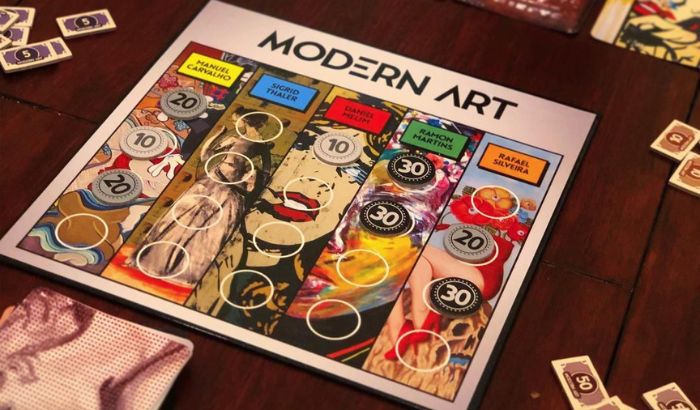Se ti accorgevi della musica, voleva dire che era più brutta del solito. Le discoteche erano posti infernali dove si imparava a vivere. A vivere male, certo, cioè nell’unico modo possibile. Di più: là dentro si imparava il segreto dell’esistenza. Negli anni ’80 soltanto nell’area di Rimini erano 150, ora sono meno della metà. Per il sociologo Aldo Bonomi l’intera Emilia Romagna era “un distretto del piacere”. Naturalmente non è esatto: era un distretto di annichilimento dell’io, un grande tempio buddista.
All’ingresso il buttafuori, un energumeno in maglia nera attillata sprovvisto del più elementare senso estetico, valutava la tua estetica. Lo faceva in base a criteri prestabiliti: scarpe scure sì scarpe bianche no, camicia sì maglietta no, o viceversa. Criteri imbecilli, ottusi, inesorabili. Il battesimo del fuoco della burocrazia, della sua strapotenza. Kafka & anabolizzanti. Si partiva dalle basi: tu non conti un cazzo. Magari ti eri fatto decine di chilometri, e un no del buttafuori significava tempo trasformato in nulla. In fila, ci si rannicchiava dietro l’amico ben vestito, che desse lui la prima impressione. Il Kinki di Bologna, allora famoso per le serate house e per la condensa di sudore che colava dai soffitti, era presidiato dal temutissimo Charlie. La gente si stringeva e si calpestava a ridosso dell’entrata, allungando i colli e spalancando gli occhi, sperando di piacergli, a Charlie, sperando che i soldi investiti in settimana in una fascetta o in una collana si rivelassero un buon investimento, lui squadrava i candidati uno a uno, poi indicava il prescelto con la mazza da baseball, gesto arbitrario e imprevedibile come un miracolo. “Grande Charlie” mormoravi mentre gli passavi umilmente accanto. Allora tu lo avresti baciato, Charlie, lui e il suo faccione squadrato: sfogare la fattanza sotto i portici di via Zamboni non era mica un bel lavoro. Saresti restato te stesso, un modesto individuo, nella penombra, con gli altri corpi distanti metri e metri e anni luce da te.
Invece, dentro alle discoteche: corpi. Centinaia, migliaia di corpi. Chi non ha mai frequentato certi locali non conosce la vera funzione biologica del sudore: è un lubrificante, che consente di sgusciare con più facilità tra i propri simili, di non restare incastrato nella massa, di godersela invece, la massa: è vaselina collettiva. E tu sgusciavi alla grande, mano sopra al bicchiere, palmo bagnato. C’è stato il periodo del whiskey, del rum, della vodka – l’ultima era superalcolica della discoteca – poi del gin e ora della tequila. Di punto in bianco, così, da un mese all’altro, senza sapere per come né perché, tutti cambiavano cocktail. L’importante era raggiungere uno stato in cui non eri più tu, non eri più nessuno, eri solo un corpo. Anzi, il pezzo di un grande corpo brulicante, eri un metatarso. Era l’anti-selfie.
Nei concerti è diverso, si canta, c’è un testo, un’ipotesi di significato, c’è l’immedesimazione nell’interprete. C’è un senso, questa chimera infantile. I concerti sono uno stato di illuminazione precedente, misticismo dilettantesco. È vero che nelle discoteche c’era il vocalist, ma in pochi lo stavano davvero a sentire. Solo quando riascoltavi la cassettina della serata, in auto o a casa tua, ti rendevi conto che il trans tal dei tali aveva detto al microfono, femminilizzando la voce: “Come vuoi che ti presenti, con un uh là là o con un Attention? Attention s’il vous plait, attention s’il vous plait, je présente…la catastrophe! Uh là là là là là là!” Quello che doveva presentare era il dj. Ralph, Massimino, i Pasta Boys. Il dj era stimato, apprezzato, a volte adorato, ma non era una star: erano gli albori di internet, non c’era Youtube, la sua faccia la vedevi solo nella penombra del locale, alle quattro del mattino, in condizioni psicofisiche compromesse, e restava un ricordo ectoplasmatico, non era un’effige scolpita nei pixel e replicata in centinaia di pagine web.
Non c’erano rock star, non c’erano ideali, nella discoteca era tutto squisitamente gratuito, meditazione pura, fine a se stessa, a un passo dal vuoto. Diventare una cassa di risonanza dei bassi, che non dicono niente, lasciare andare speranze e paure, passato e futuro, così, per nulla, per il Nulla. Ti guizzavano erezioni altrui sulla carne, i sederi sussultavano, i gomiti pungevano, un ripasso di anatomia in codice braille. Il brodo primordiale che ribolliva a Misano Adriatico. Ci si aiutava con le pastiglie. Anfetaminiche o robose. Le prime ti agitavano, le seconde ti squagliavano, cioè diventavi smidollato e sdolcinato, una caramella sciolta, la pista era un pastone dolciastro. “Ti voglio bene” lo potevi dire a uno sconosciuto che ti concedeva mezza sigaretta, e che magari rapinava le vecchie nella bassa modenese. Un monaco buddista ci mette decenni a raggiungere lo stesso stato di benevolenza universale. Capitava che dovessero accompagnarti alla toilette perché tu ti bagnassi i polsi, la faccia, la gola: ma quello era solo l’ego che puntava i piedi, che non voleva cedere, che si spaventava di fronte all’abisso del Nirvana.