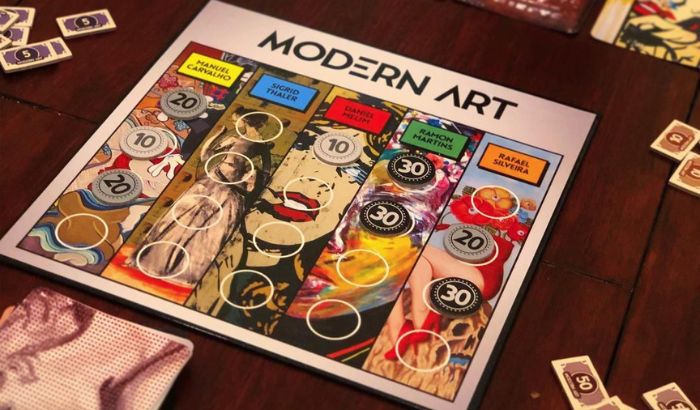Alberto Piccinini: Devo essere sincero, ho un ricordo confuso del momento in cui Sergio Ballo, il costumista di Bellocchio premiato per Rapito, ha fatto la pazza ai David l’altra sera. Un po’ perché li avevano messi sulla scala come Wanda Osiris – diceva lui – un po’ perché c’era una statuetta sola per due premiati, da pezzenti, un po’ perché il sionismo e l’antisemitismo eccetera. Che è stato il momento migliore di tutta la cerimonia, molto noiosa ma non più di un’altra prima serata qualsiasi di Carlo Conti, e mi spiace perchè lì ho perso il filo. Mi sono alzato dal divano condividendo l’intima tragedia dell’autrice e del conduttore Biggio in diretta col passare dei minuti dello sclero impossibile da fermare. Pensa come sto. Qualcuno avrà avuto l’idea: i premi minori? Mettiamoli in un altro studio. Benissimo. Ideona. Qualcun altro avrà dovuto dirglielo ai candidati, uno a uno. Di solito a questo punto 3/4 degli autori tv scappano fingendo di essere impegnatissimi. Oppure parlano a mezza bocca, rimandano, poi vediamo, famo, dimo. Hai presente, no? Infine qualcosa succede, ed è come cadere dal 50esimo piano della barzelletta: fin qui tutto bene, fin qui tutto bene, bene. Scusa se insisto: la metafora mi pare chiarissima. Sono passati sul palco Germano e Riondino, Cortellesi e Garrone. Non uno che abbia detto niente della situazione. Ma dico: Riondino che ha postato Ignazio La Russa a testa in giù non più di una settimana fa, Cortellesi che in questi mesi ha preso palate di merda sui social dalla destra di ogni genere e, sospetto, silenziosamente dai giurati che non le hanno dato il miglior film; Matteo Garrone – il più matto di tutti da sempre – che timbra il cartellino di Rai Cinema quasi come un impiegato. Niente. Mi aspettavo non dico il Jonathan Glazer proPal che agli Oscar poi ha fatto parlare per un mese, ma almeno qualcuno che vendicasse il silenzio del Primo Maggio, che ho trovato ancora più agghiacciante. Scusa la retorica, la cosa che più temo non è la censura ma l’autocensura. Il volemose bene, il cinema del telefoni bianchi, gli Anni Trenta del consenso e dei privilegi. Amen.
Giovanni Robertini: Sergio Ballo è già meme, supercazzola suprema, non escludo un passaggio da Del Debbio. Per il resto il disegno mi sembra abbastanza chiaro, scalettato diabolicamente come un format olandese anni Novanta: Sanremo come il Primo Maggio come i David come la sagra dalla salamella della provincia piacentina. Prima regola: sminare il campo con le gag cringissime del buon Biggio, circondarlo col filo spinato della conduzione “simpatica” di Conti e Marcuzzi, e chiamare Luca Tommassini come arma di distrazione di massa (quando ho visto Mahmood entrare in tackle nell’omaggio a Fellini cantando Tuta Gold ho rimpianto la coreografia di Cosmo al Concertone sulle manganellate della polizia ai cortei proPal). Seconda regola: l’autocensura come dress code, il minimalismo del non dire nulla, quasi una perversa forma di coolness (“sono così indignato che sarebbe di cattivo gusto mostrartelo”). Pure il battaglione tarantino di sinistra capitanato da Riondino ha fatto meno di un Dargen D’Amico qualunque, disinnescato come Kid Yugi dopo la scoperta di Milano, dei soldi e dei dischi d’oro. Certo, ci rimane la chat di Whatsapp di Massimo Giannini… Scherzo. Anzi, sai che ti dico? Non l’avrei mai pensato, ma oggi ho nostalgia di tutta la retorica anni Novanta, tutta tutta, compreso Zulu dei 99 Posse che a un concerto legge una lunghissima lista, in ordine alfabetico, di prigionieri politici italiani.
AP: Mamma mia, sì. E non sei il solo. È il primo anno che faccio caso a quelli che postano vecchi video del concertone: ho visto gli Iron Maiden presentati da Mollica e Paolo Zaccagnini nel 1990, cose così. Ma ho visto pure due puntate di Baby Reindeer. Ho sentito 20 minuti dell’album di Cindy Lee. Sono a posto, mi pare. Sul New Yorker becco il profile di Judith Butler: 20 cartelle, con viaggio fino alla casa di Berkeley e chiaccherata nella vecchia Bmw del filosof* (usa il pronome they/them) che ha il sedile dietro ingombro di volumi di Merleau-Ponty. Wow. Judith Butler questa settimana sarà in alcune università italiane, io ci vado, sono un fan da sempre tipo Mina anche se c’è da menare le mani coi fasci antigender. Altre differenze e somiglianze in merito al dibattito sul gender: da noi il feud Mara Maionchi vs Tiziano Ferro, nato come una stanca scheggia promozionale di Belve, arriva ugualmente al cuore del problema. Mettiamola così: le boy band, che noi ricordiamo bene cos’erano, funzionavano come macchine di inaudita violenza disciplinare, tra le peggiori in tutta la storia della musica pop. Britney Spears – avvistata ancora due giorni mezza nuda e sconvolta al Chateau Marmont di Los Angeles – paga per tutti, come e anche peggio di quanto hanno pagato Kurt Cobain e Jim Morrison (un habitué dei bungalow allo Chateau). Nessuno mi convincerà che Mara Maionchi va perdonata perché allora non usava il coming out, i dietologi andavano di moda e le ragazzine in piena tempesta ormonale erano un investimento sicuro. Le major, parliamoci chiaro, facevano le major. Noi eravamo indie, o almeno ci provavamo. E tutti quelli che avrebbero potuto fare e non hanno fatto magari non saranno fino in fondo colpevoli, ma complici sì. Ho parlato, vostro onore.
GR: Ah, giusto, dimenticavo Mara Maionchi e la terza regola del format: depotenziare temi di grande dibattito culturale e politico dandoli in mano a spregiudicati e inconsapevoli interpreti con i loro commenti instagrammabili, che è un po’ la prassi del talk show. Faccio qualche esempio: Raz Degan a parlare di politica israeliana (visto in tv), Mara Maionchi sul coming out, Capo Plaza sulla salute mentale, BigMama sul bodyshaming, Leão sul razzismo, e così via tra panel, dischi d’oro e punti di share. Come dicevamo prima, è tutta una questione di scaletta. Anche l’hype gigante attorno al bel disco di Cindy Lee credo che sia in parte dovuto al fatto che il disco non si trovi su Spotify, e che per sentirlo non si possano skippare le tracce ma affidarsi in toto per più di un’ora a un link YouTube. Un nuovo format, ce ne sono in giro parecchi: ieri ho comprato su Bandcamp una compilation di suonini We Will Stay Here – Music for Palestine, 20 euro per gli MP3 e una maglietta (c’era anche la cassettina ma non volevo esagerare) per finanziare gli aiuti sanitari. L’ho subito messo a palla sulla mia Dacia (molto buoni i pezzi di Still, Cosmo e Not Waving) e mi sono sentito subito meglio.