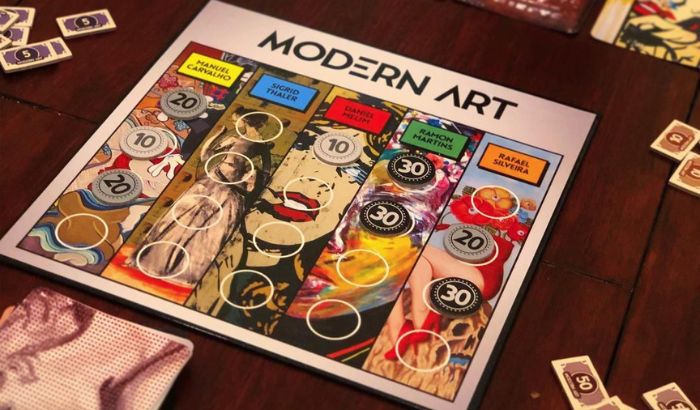Abito in Val di Chiana, la Louisiana italiana, un’ex palude dove siamo tutti figli di consanguinei e per accorgersene basta cercare di farsi dare il giusto resto da un elettrauto. Per dire, qua è uscito solo oggi il terzo numero di Dylan Dog, dal titolo Le Notti di Luna Piena (serie che comunque non mi sta dispiacendo). E mi fa specie pensare che, nonostante questo ritardo mentale e culturale, sono abituato ad usare il telefonino fin dal 1996, anno di Tremors 2, prima che diventasse un oggetto alla portata di tutti. Ai tempi mi fu acquistato dai miei genitori per una ragione ben precisa, sintetizzabile in cinque semplici parole: “Alessandro, non si sa mai”. Nel senso: se mai all’uscita da scuola fossi stato picchiato da alcuni skinheads, poi ucciso, tagliato in sei pezzi, col fallo strappato inserito in bocca a mo’ di avvertimento di quelli di Herbalife, avrei potuto comodamente chiamare i miei per dire loro di passarmi a prendere e portarmi al pronto soccorso più vicino.
Il mio primo telefonino fu il lussuoso Nokia 8110 reso famoso dal film Matrix l’anno successivo, quello ironicamente detto “a banana” perché simile a tutto fuorché a una banana. Inclusa la custodia originale, costò la bellezza di un milione e quattrocentomila lire dell’epoca alla Casa dello Sconto, oggi Euronics. Riflettevo che, con la stessa cifra, uno avrebbe potuto comprarsi millequattrocento classici a mille lire della Newton alla bancarella davanti alla stazione, farsi una cultura mostruosa e rilassarsi un attimo in veranda, come un perfetto colonnello Mustard. Un camionista sieropositivo dagli agghiaccianti precedenti penali avrebbe potuto abbandonare i suoi folli propositi e diventare un premio Nobel di quelli che scoprono la cura per la distrofia muscolare e affini e quanti di paraffini. Ecco, a me con la stessa cifra mi comprarono un telefonino.
Era un oggetto che subivo passivamente, tanto misterioso quanto privo di qualsivoglia attrattiva. Ricordo solo che negli anni ‘80 si mormorava che Don Giuseppe, il prete del mio paese, ce l’avesse come optional nella sua Mercedes. Si diceva che gli servisse per essere rintracciabile in caso di estreme unzioni, per partire in missioni in Africa decise all’ultimo minuto, per parlare col Santo Padre e forse anche coi defunti. Erano anni particolari quelli, lontani dalla volgarità di questa benedetta trap e dalla malizia dei meme di questa arrogante generazione del LOL da cui per la prima volta prendo ufficialmente le distanze in questo pezzo per Rolling Stone (storici, drizzate le antenne). Erano anni in cui se uno aveva un personal computer davanti, era letteralmente terrorizzato all’idea di sfiorare qualsiasi lettera della tastiera perché temeva che la macchina s’impallasse senza ritorno e poi bisognasse buttarla via. E se a scuola un bambino lo bocciavano perché aveva premuto la “P”, pensavi che ci stava. Per lo stesso motivo, il telefonino era percepito come un oggetto dai poteri quasi sovrannaturali, di certo da usare solo nelle le grandi occasioni e in poche, distillatissime volte nella vita. Insomma, un accessorio da capo della Sanson o giù di lì. E così l’avevo creduto anch’io, fino a quando, nel 1994, anno di Scuola di Polizia 7: Missione Miami, un mio compagno raccontò in classe un fatto successo in una scuola di Empoli e di cui avevano parlato i giornali. Una ragazza, appena finito l’esame di terza media, aveva tirato fuori dallo zainetto il suo telefonino personale e aveva chiamato il babbo per farsi venire a prendere. Oggi è normale amministrazione, ma ai tempi fra i miei compagni e i professori fu l’incredulità, il panico, lo shock anafilattico, nessuno ci credeva. Se non sbaglio, questo mio amico per questa storia si prese pure rapporto e recentemente è venuto a mancare per disseccamento dell’aorta (che comunque non è ha niente a che vedere col rapporto, non voglio responsabilizzare la scuola).
Tornando al presente narrativo, da buon cartesiano e grazie al metodo dell’induzione logica, scoprii ben presto che un telefonino serviva a ben poco se non avevi una SIM che ne fosse degna. E, ironia della sorte, anche questa si rivelava abbastanza futile senza un piano tariffario adeguato. Ai tempi l’unica compagnia telefonica era la Paggini Comunicare (che divenne poi Sip, poi TIM) e ne proponeva due: family e business. Mio babbo, direttore della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio (che divenne Banca Etruria, poi Ubi Banca), optò per il primo tipo di abbonamento. Niente ricariche, temendo che poi si sarebbe confuso fra “ricarica” e “caricabatteria”, bensì una bolletta mensile che arrivava a casa. Ricordo le tariffe dell’epoca: tremila lire al minuto se chiamavi tu, ma in compenso la stessa cifra per quelli che ti chiamavano (vorrei pure vedere!). Questi ultimi magari erano tutti contenti di fare quattro chiacchiere con te e farti provare l’ebbrezza di essere chiamati sul telefonino, senza sapere che già un “ciao carissimo, come stai?” gli costava come I Racconti del grottesco e dell’arabesco di Edgar Allan Poe, nell’edizione della Newton, più una sedia di plastica per sedersi e leggerlo. Una volta un mio amico chiuse male il cellulare e se ne accorse solo la mattina dopo: il debito che accumulò con la Sip fu stimato solo leggermente inferiore al costo di una collinetta (nemmeno brutta) qua vicino. Io comunque usavo il telefonino cum grano salis, solo quando serviva e quando mi picchiavano nei parcheggi sotterranei e mi tagliavano in sei pezzi con un grissino.
Venne il 1997, anno di Jackie Brown e dell’Università. Diversi miei amici andarono a studiare a Firenze, Siena e quelli meno performanti a Urbino, occupando appartamenti senza il telefono fisso, così che improvvisamente furono raggiungibili solo al telefonino. In pochi mesi mi trovai a dimezzare la mia cerchia di amici. Il fatto è che pensai bene di suggestionarmi conflitti che mi portassero a troncare certi rapporti con persone care che magari avevano tutte le qualità del mondo, tranne il fisso in casa. Ogni pretesto andava bene per mandare tutto all’aria: questioni su titoli nobiliari, rogiti finiti male o pelosi strascichi della legge Gozzini. In questo modo non avrei dovuto, per dimostrarmi amico, chiamarli al telefonino per discutere se la pizza è più buona alta o se Nick Raider era meglio disegnato da Caramuta o da Trigo, al costo di tre libri della Newton al minuto, magari le tre cantiche del libro Cuore di De Amicis con illustrazioni di Aligi Sassu e introduzione di Natalino Sapegno.
Io tra l’altro ho continuato a spendere un puttanaio per il telefonino fino a poco tempo fa. Davo per scontato che le compagnie telefoniche ti cambiassero tariffa, non dico dandoti in diretta la più vantaggiosa, ma almeno quando la vecchia spariva dal loro catalogo. E invece no, io non avendola mai cambiata perché confidavo nella saggezza pacificata e pacificante delle compagnie telefoniche (che reputavo un po’ le nuove Tiziano Terzani), continuavo a pagare un euro e mezzo a scatto anche nel 2019, anno di Critters 5. Avevo la letale Flash TIM di TIM, il cui vantaggio doveva essere quello di non pagare subito lo scatto intero, ma di pagare esattamente la frazione di scarto adoperata, anche se sovraprezzata. Un po’ come dire: non ti tolgo un polmone intero, te ne tolgo tre quarti ma mi prendo anche quattordici linfonodi a caso per riprendermi dallo stress del calcolo.
Ecco, vengo a sapere ora che uno di quegli amici con cui tagliai ai tempi dell’Università è stato ucciso. Flavio Zaurino, ritrovato in un boschetto del Mugello in auto insieme alla compagna, la fotomodella indiana Troiaio Barozzi.