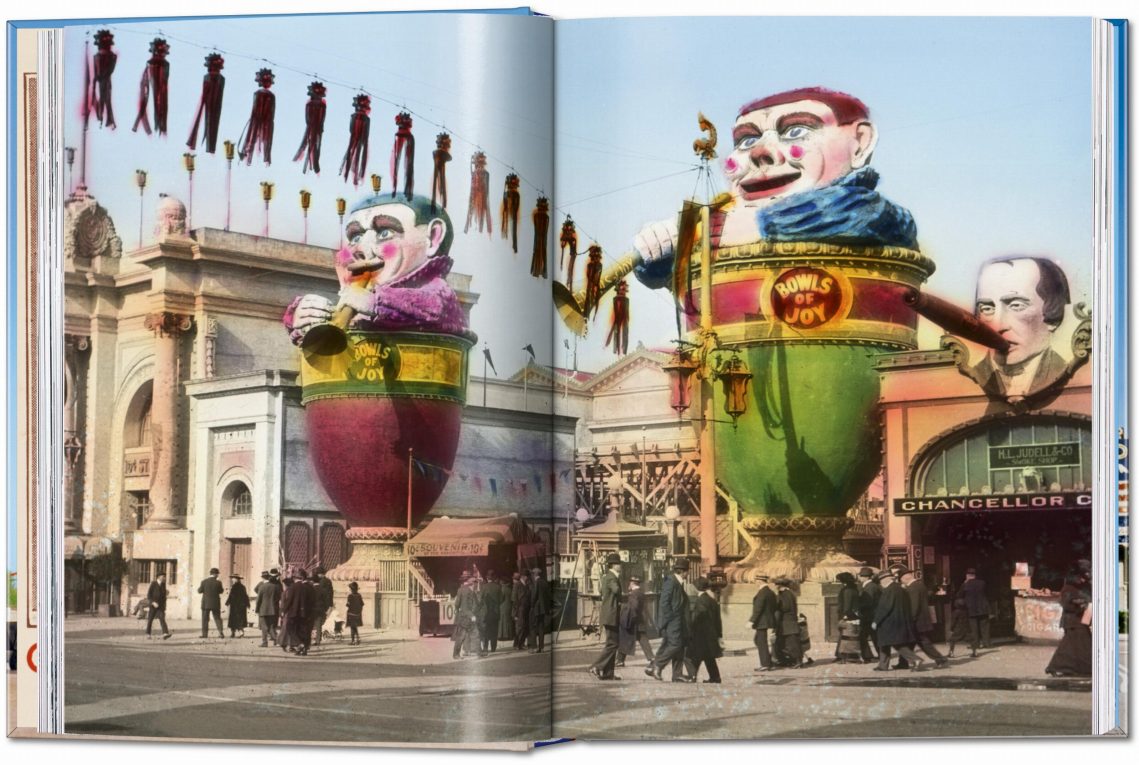Come evidenziano alcuni recenti studi istituzionali, il tema delle aggregazioni giovanili e della conflittualità urbana a esse associata è al centro del dibattito pubblico in Italia. Tali forme di aggregazione, soprattutto – ma non esclusivamente – se composte da giovani di origine migrante, vengono spesso rappresentate come una minaccia per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. Secondo il discorso egemone, il «problema» delle aggregazioni giovanili urbane consisterebbe nel fatto che la loro unica ragion d’essere risieda nella «violenza di strada», esercitata in gruppo e nello spazio pubblico – una questione che affligge le cancellerie europee da oltre settant’anni.
Riprendendo le parole della delegata generale dell’European Forum for Urban Security, «dappertutto in Europa, il discorso pubblico sulla sicurezza contribuisce a perpetuare l’immagine di un fenomeno, presentato come nuovo, che vede coinvolti in reati criminali dei giovani, spesso appartenenti alle minoranze» (Johnston 2013, p. 13).
Sono ormai all’ordine del giorno i titoli di giornale e i servizi televisivi dedicati alle famigerate «baby gang» di «maranza» che, con le loro Nike Tn, la tuta in acetato e il borsello a tracolla di ordinanza, spadroneggiano nelle città e nei paesi italiani, incarnando la figura dei «nuovi diavoli popolari» (Alexander 2000) del nostro tempo. Sebbene il tema venga spesso presentato come una novità storica e sociologica, si tratta in realtà di un meccanismo funzionale alla riscrittura storica che, come osserva Marchi, «vuole che i “cattivi” di un tempo diventano più “buoni” solo per sottolineare la “cattiveria” degli ultimi arrivati» (2014, p. 18). È ormai un dato acquisito, infatti, che le manifestazioni di turbolenza giovanile costituiscono una costante lungo il continuum della storia sociale e politica sin dall’età moderna.
Il giovane, nella storia, ha sempre rappresentato uno dei Folks Devils più gettonati: la sua figura ancora non del tutto definita, in qualche modo incompleta, facilmente strumentalizzabile, ha sempre funzionato da parafulmine per una società segnata da forti contraddizioni e distorsioni sociali, preda di sensi di colpa da tacitare con offerte sacrificali, appunto con capri espiatori […] il Folks Devils vi svolge un indispensabile ruolo di catalizzatore delle ansie, delle nevrosi, delle insoddisfazioni collettive suscitate da un modello sociale che nella crisi trova il proprio più conveniente equilibrio (Marchi 2014, p. 19).
Nelle dinamiche del «teppismo giovanile» si osserva un legame indissolubile tra culture popolari, istituzioni repressive e pedagogiche e produzione di categorie devianti. Queste ultime risultano tanto più spaventose quanto più si allontanano dalle forme comuni di devianza, divenendo funzionali alla costruzione di un «diavolo popolare» utilizzabile, nei momenti di crisi di consenso, a fini di governo. La costruzione dell’allarme sociale, infatti, «[…] consente di volta in volta di ridurre a questione morale ogni manifestazione di protagonismo e conflitto. La teppa […] diventa infatti funzionale ai processi di civilizzazione e di modernizzazione della società» (Bertoni, Caroselli, Sterchele 2022, p. 8).
Tale processo, inoltre, s’interseca fittamente e richiama le retoriche coloniali nella costruzione dell’alterità, nonché la trasposizione in Europa delle logiche proprie delle politiche coloniali. Esso rappresenta l’esito finale – e auspicato – delle campagne di panico morale che, a partire dagli anni Sessanta, sono state sempre più riconosciute come «[…] l’espressione di un’età dell’incertezza e dell’ansietà che, facilmente, possiamo far discendere dai mutamenti tecnologici […] dai conflitti passati e di quelli in corso, delle trasformazioni proprie della famiglia, dei ruoli di genere e altro ancora» (Saitta 2023, p. 18).
Ma cosa s’intende per panico morale? E come mai i giovani sono diventati la migliore rappresentazione di questo
allarme sociale?
Il concetto di panico morale inizia a diffondersi a partire dagli anni Settanta grazie ai lavori di Albert Cohen e Jock Young, a seguito dell’incontro tra teoria dell’etichettamento e sociologia critica. Riprendendo le parole di Cohen, si può definire il panico morale come:
[…] una circostanza, un episodio, una persona o un gruppo di individui [che] spiccano a tal punto da venire considerate una minaccia estrema ai valori e agli interessi dell’intero sistema sociale. La loro natura è presentata in maniera stilizzata ed estremamente stereotipata dai mass media, cosicché si giunge a erigere barricate morali grazie a giornalisti, vescovi, politici e altre persone fin troppo giudiziose. Esperti accreditati esprimono diagnosi e soluzioni che sono elaborate ex novo o, più frequentemente, riproposte ogni volta in modo diverso. In alcuni casi l’elemento scatenante scompare e sprofonda nel nulla, mentre in altri, si acuisce e diventa più visibile (Cohen 2019, p. 39).
Nonostante le successive evoluzioni del concetto, le intuizioni di Cohen restano ancora oggi fondamentali per chi si occupa di culture giovanili e questioni urbane, poiché mettono in luce come «[…] gli oggetti dei panici morali più noti sono piuttosto prevedibili, così come lo sono i discorsi utilizzati per rappresentarli» (Cohen 2019, p.2).
Alla base di questa operazione si trova una precisa volontà politica: instillare la paura nelle persone, spingendole ad abbandonare la complessità e i problemi sociali della vita quotidiana per rifugiarsi in una «mentalità da fortezza». Come afferma McRobbie, ciò genera «[…] un sentimento di disperazione, impotenza politica e paralisi che porta ad adottare un atteggiamento del “bisogna fare qualcosa al riguardo”» (1994, p. 199).
In altri termini, prende forma quella che viene definita la «sindrome di Andy Capp», una patologia sociale che colpisce la cultura egemone, portandola a creare i propri mostri e a produrre l’ansia di essere accerchiata da essi. In questo contesto, a diventare centrale non è tanto la pericolosità «oggettiva» degli eventi, quanto la loro percezione da parte della cittadinanza. Ciò che viene percepito come pericoloso finisce per influenzare la definizione stessa di pericolo rispecchiando le caratteristiche di una società fondata sull’idea di rischio, di cui i panici morali si nutrono.
Il caso emblematico di questa gestione politica della paura è rappresentato dal terrorismo internazionale di matrice jihadista. Pur trattandosi di una minaccia reale e complessa, che meriterebbe un’analisi articolata e multifattoriale, il fenomeno viene spesso strumentalizzato per creare panico, non tanto verso il terrorismo in quanto tale, quanto nei confronti dell’Islam. In questo modo, si costruisce un allarme attorno a un falso problema, mentre il dibattito sul problema reale viene silenziato, delegittimando chiunque tenti di portare avanti un discorso critico o contro-egemonico, etichettandolo come apologetico.
Nella costruzione di questo dispositivo, un ruolo centrale è svolto dal linguaggio, che deve essere semplice e immediatamente riconoscibile, così da perturbare quante più persone possibile. A dominare la narrazione mediatica è un linguaggio emergenziale, in cui viene utilizzata spesso la categoria di degrado. Si tratta di un linguaggio basato su una determinata struttura narrativa, che riflette una precisa visione del mondo e che funge da megafono delle idee dominanti. Come osserva Saitta, «[…] appare come un codice valido per differenti fasi e pericoli […] ed è dunque la forma mentale adatta a una società del rischio e dell’incertezza» (2023, p. 28).
In questo contesto, torna utile richiamare gli insegnamenti di Stuart Hall e della Scuola di Birmingham. Il loro contributo è stato decisivo nel leggere i panici morali come fenomeni strettamente connessi al processo di etichettamento e alla necessità da parte dello Stato e delle classi dominanti, «[…] di assicurarsi un controllo egemonico del piano dell’informazione pubblica» (Cohen 2019, p. 30). Hall e i Cultural Studies britannici hanno inoltre evidenziato come il concetto stesso di panico morale sia attraversato da linee di frattura coloniali, razziali e patriarcali.
Secondo Hall, a partire dagli anni Sessanta si assiste a un flusso costante di panici morali, generati per «salvare» una società percepita come insicura. È attraverso il panico che questa società identifica il nemico necessario, su cui catalizzare ansie e paure diffuse. La forza del concetto di panico morale è tale da essere diventato oggi un termine di uso comune: non soltanto un «semplice» dispositivo di controllo sociale, ma, come scrive Mellino, «[…] un fatto sociale ricorrente, strutturale e spontaneo […] sempre in attesa di una sua eventuale manipolazione […]» (2023, p. 204).
Un concetto ambivalente, dunque, che può essere mobilitato non solo dal potere, ma – ed è questo un ulteriore meritodella Scuola di Birmingham – anche dagli stessi diavoli popolari, che non restano passivi e inermi al processo di etichettamento, ma che rivendicano la figura di demoni urbani.