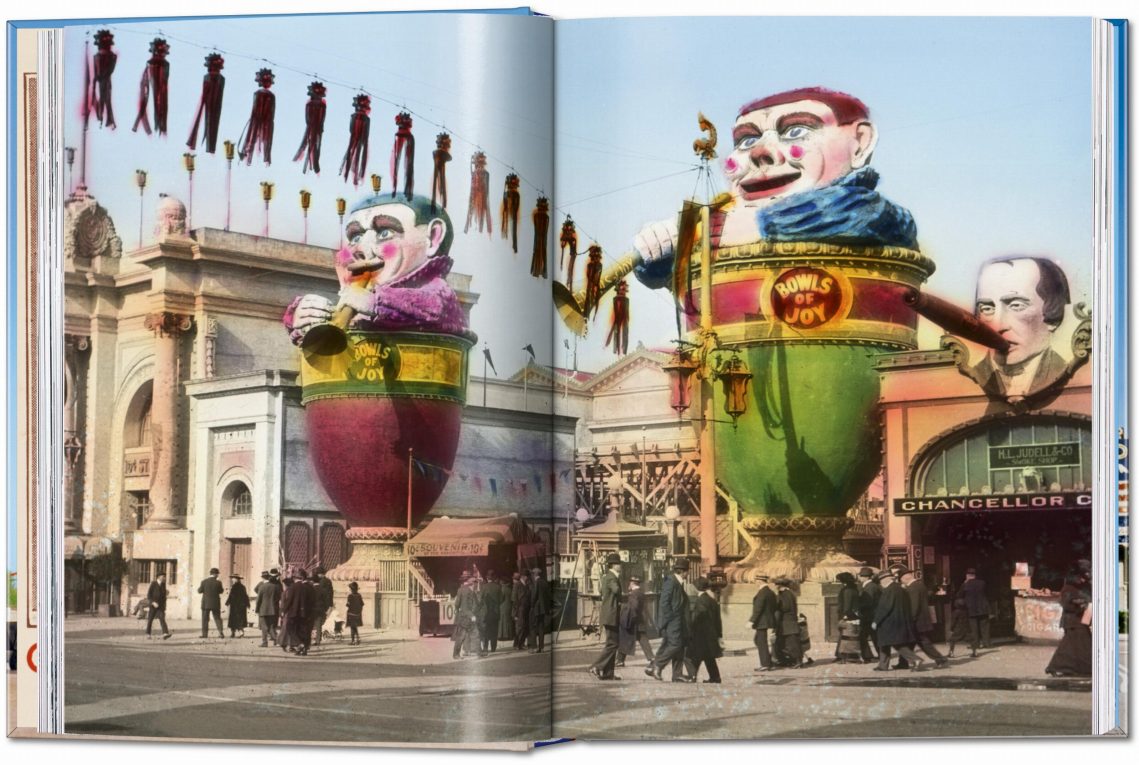Esistono luoghi in grado di produrre un’immagine materiale, pubblica e condivisa della forma e del funzionamento della realtà e tra essi nessuno è più antico e importante della città. Ogni città, situata in un preciso spazio e tempo, è latrice di una visione del mondo – di come era, è, o dovrebbe essere – che essa stessa, con la sua presenza, produce e diffonde. Nei secoli esse sono stati agenti culturali decisivi e motori di rivoluzioni e cambiamenti, luoghi fisici e ideali in grado di veicolare un’enorme mole di interpretazioni morali, politiche, sociali in bono e in malo.
Tuttavia la città, oggi più che mai, è scritta come un enigma ed è proprio per questa sua natura storicamente poliedrica che essa sfugge a una comprensione esaustiva e univoca: l’approccio allo studio della città in termini sociologici e culturali non può infatti che essere frammentario e situato, partendo sempre da un preciso posizionamento ideologico e culturale, inabile a rendere conto di un tutto. Che cos’è infatti una città? È un luogo di problematiche ecologiche o di manifestazione di segregazione e povertà? Di conflitto tra classi sociali o di controllo delle masse? Di sperimentazione tecnologica o conservazione del passato? E via così. Acclarato che le tradizionali caratteristiche quantitative che classificano la città sono profondamente sterili e insufficienti, la domanda rimane.
Lo storico Roberto Sabatino Lopez risponde che niente le è paragonabile: una città è una città, attraverso le epoche e le culture essa in fondo non muta affatto. Per il sociologo Lewis Mumford essa è un fatto naturale – «come una grotta, un nido, un formicaio» – e insieme al linguaggio si costituisce come sede di memorie e testimonianze permanenti, a un tempo artefatto umano, immagine del mondo ed espressione culturale in continuo rinnovamento. Ma per la città parliamo anche di “giungla”, sappiamo di poterci perdere, la conosciamo anche come luogo di pericoli, che nasconde, cela, talvolta imprigiona. Per tutti questi motivi, accanto alla percezione di una sorta di promessa culturale, sotto la sua superficie ancora oggi operano forze vecchie come le nostre origini e di ciò abbiamo un costante presentimento. Un mistero, insomma. Suona familiare?

Foto: press
Questioni di prospettiva
Se osservassimo il quadro della fine del Quattrocento – di dubbia attribuzione tra Piero della Francesca e Leon Battista Alberti – intitolato La città ideale avremmo davanti una piazza circondata sui tre lati da edifici armoniosi in rapporti di proporzione perfettamente razionali; il modello di come una città dovrebbe essere secondo il pensiero rinascimentale. Ambienti retti, forme geometriche precise e nette, una prospettiva centrale concorrono a formare un luogo ideale, forse della mente, un’utopia urbana tra le tante che costellano la modernità. Se ci proiettassimo poi nel Novecento e osservassimo invece un quadro di De Chirico, quei medesimi ambienti ci risulterebbero mutati, lievemente deformati o scomposti, popolati da statue fuori posto, ombre che si allungano, con colori pastosi ora densi ora spenti e prospettive sghembe e distorte. Alla magnifica nettezza della razionalità rinascimentale è qui subentrato un alto grado di inquietudine, un rapporto straniante tra gli elementi, un silenzio che dice qualcosa, ma chissà cosa.
C’è stato un tempo in cui l’immagine del mondo era la polis greca, con le sue dinamiche di partecipazione, oppure l’urbs romana, che denunciava una razionalizzazione dello spazio volta al controllo, fino al castello o al comune medievale, altre forme chiuse arroccate attorno alle loro mura e alla loro comunità. Col passaggio dal medioevo al Rinascimento e poi all’età degli assolutismi, la città si costruisce invece attorno all’idea di razionalità e spazializzazione. È proprio a partire dall’età moderna infatti che quella distinzione tra luoghi e spazi che abbiamo operato nel primo capitolo volge a favore dei secondi: l’epoca delle grandi scoperte, dicevamo, semplificherà il mondo sotto il potere dell’occhio, della mappa che, riducendo le tre dimensioni a due, permetterà la progressiva formazione di quello sguardo aereo – lo stesso di Dedalo e di Alberti – in grado di sciogliere i misteri delle terrae incognitae.
Rispetto al Medioevo e all’età classica, dove la città era un’entità autonoma, un luogo conchiuso, terminato, un organismo autosufficiente, la città della modernità, dal Rinascimento all’Illuminismo e oltre diventa un luogo ancorato non più alla conservazione, ma al progresso, non più fondato sulla chiusura, ma sull’apertura, non sulla staticità, ma sulla dinamicità. Essa diviene regolata dalla tecnica, dalla tecnologia, dall’economia, si trasforma in spazio di flusso e in punto nodale di tutte le strategie di organizzazione razionale della società e della cultura.
In una suggestiva lettura della città Rosario Rogel Salazar dell’Universidad Autónoma del Estado de México riflette sul rapporto che la città intrattiene con la sua immagine e il suo senso, accostandone l’evoluzione proprio a varie forme di labirinto. Da un lato, le città antiche e medievali corrispondono per Salazar alla forma del labirinto classicamente inteso: un’entrata che è anche un’uscita, solide mura a tracciare un confine netto tra il dentro e il fuori, un organismo concluso, un archetipo disegnato e costruito per specifici motivi con un’intenzione alle spalle. La città strutturata in questo modo, così come il labirinto, ha sempre un centro attorno a cui è costruita e questo le dona non solamente un senso e una gerarchia, ma, come abbiamo visto, rivela una verità – cioè l’immagine prodotta da quella stessa città –, concretata negli edifici che al centro della città stanno e che ricoprono una funzione di potere, sia esso spirituale o temporale.
Ma con l’avvento della modernità cambiano i paradigmi culturali. Le coordinate di progresso, antropocentrismo e razionalità trasformano progressivamente gli spazi e con essi la forma stessa del labirinto, suggerisce Salazar, in una configurazione arborescente – la raffigurazione ad albero del labirinto non rientra tra le sue rappresentazioni ed è tipica, invece, di formulazioni moderne in una sorta di variante di quello unicursale.
Costruito attorno a un singolo sentiero ricco di ramificazioni cieche, esso costringe a scegliere biforcazioni continue delle quali una è sempre sbagliata e l’altra corretta e, per questa sua conformazione, si attornia su una linea principale che tende tuttavia a perdere il concetto di centro fisico. Salazar associa il sentiero corretto di questo labirinto proprio all’idea di progresso culturalmente inteso nella modernità: le ramificazioni cieche non sono altro che tentativi, i quali contribuiscono però al procedere dell’idea centrale. Non c’è un singolo sentiero ma differenti progetti che confluiscono tutti nella stessa idea la quale tende così, però, a farsi più astratta, a non risolversi più in un solo punto centrale.
Perciò, più ci accostiamo alle città di oggi più è questo fenomeno a presentarsi ai nostri occhi. La città che prima aveva un centro e dei confini, riplasmata da idee di apertura e dinamismo esponenziali – soprattutto dall’Illuminismo in avanti –, modella quello spazio che ancora i rinascimentali inquadravano come fisso, come misura delle cose e dell’uomo, nella direzione di una velocità di progresso sempre più acuta, sciogliendo le proprie coordinate in una massa informe, un blob di cui oggi non distinguiamo più i confini. E, lo abbiamo già detto, là dove vengono meno i confini, ecco che spunta il labirinto.