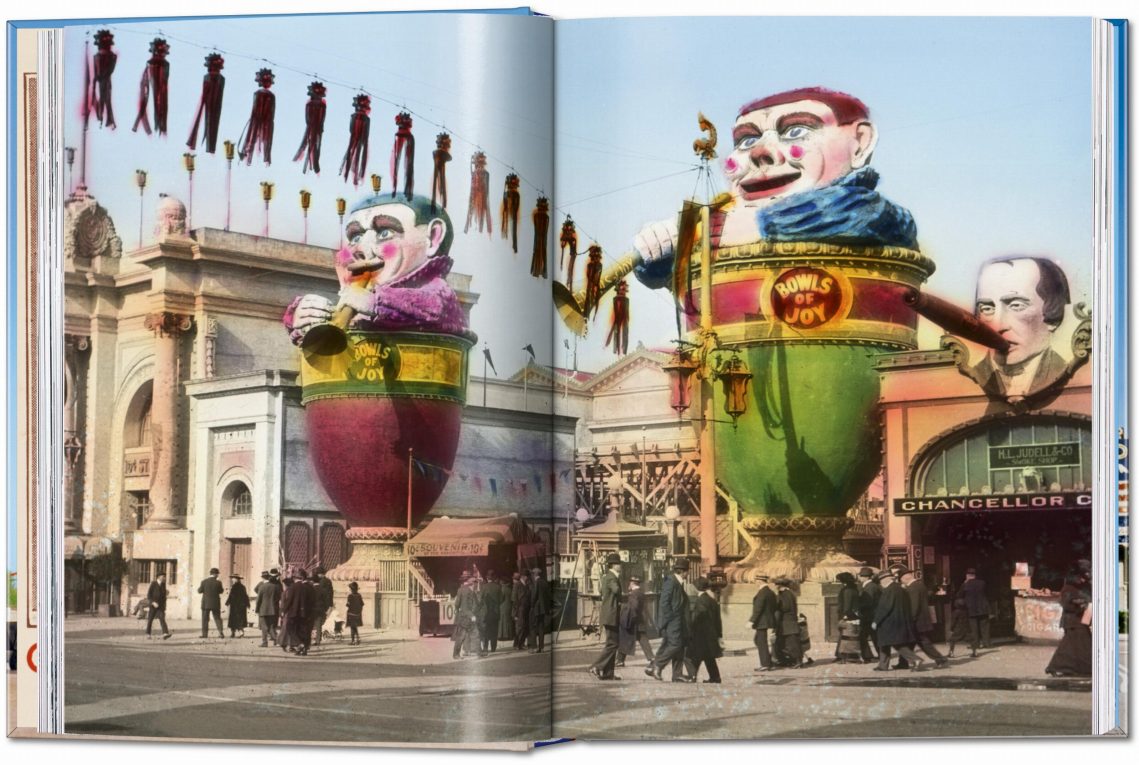Un giro dei bar nella Milano che fu potrebbe cominciare dalla Briosca del “Pinza” – Luciano Sada – sul Naviglio Pavese, aperta nel marzo 1968. Un’osteria vera, di quelle di una volta, dove si respira ancora l’aria autentica della vecchia Milano.
Da lì, spostandoci verso il centro, ci fermiamo in uno dei tanti trani, quelle tipiche bettole gestite da pugliesi sparse per la città, dove operai e malavitosi si ritrovano per bere vino e giocare a carte tra nuvole di fumo acre e conversazioni sottovoce. L’arredamento è spartano, i tavoli di legno consumati, l’atmosfera è densa di storie.
Con l’arrivo degli anni Settanta, Milano si trasforma. Il nostro tour ci porta inevitabilmente al Jamaica di via Brera 32, epicentro della bohème milanese dove artisti come Mimmo Rotella si mescolano ai politici emergenti come Bettino Craxi, tra pareti piene di opere d’arte, discussioni che si protraggono fino all’alba e l’odore di sigarette francesi.
Poco distante, ecco Oreste di piazza Mirabello ed El Tombon de San Marc di via San Marco 20, dove la sera si respirava aria di contestazione e di cambiamento. Spostandoci verso il Santa Tecla di via Santa Tecla 3, assisteremmo alle performance di una intera generazione del beat italiano.
Non possiamo perderci I Ronchi in via San Maurilio, un’enoteca con intrattenimento dove degustare vini mentre la musica dal vivo accompagnava le serate. Sempre in San Maurilio, Il Refettorio di Roberto Brivio (ex dei Gufi) e il Si o si di Primo Moroni completano il quadro di una Milano in fermento culturale.
Per chi vuole continuare la serata, l’appuntamento è al Teatro Gerolamo, gestito da Umberto Simonetta, dove si può ascoltare da Maria Monti a Paolo Poli, o addirittura assistere a concerti jazz indimenticabili, come quella serata leggendaria con Billie Holiday.
Gli anni Ottanta portano una ventata di modernità e trasgressione. Il nostro tour non può che passare dal Derby Club di via Monte Rosa 84: seminterrato con pedana, pianoforte e batteria. Dal 1962 il Derby di Enrico Intra mescola cabaret e jazz, pubblico trasversale (professionisti, artisti e mala). Da qui passano Jannacci, Cochi e Renato, Teocoli, Boldi.
Sui Navigli, Ca’ Bianca è l’approdo più informale: ristorante–locale con sala ampia e prezzi accessibili, frequentato da pubblici diversi e non meno vivo del resto del circuito. Sotto il bar Tre Gazzelle, l’Intra’s Club ospitava il jazz infrasettimanale e nel weekend lo spazio diventava Tricheco Club, che più tardi si sposterà in viale Monza (ex Teatro Officina, oggi Zelig).
Per i pranzi che contano, bisognava andare da Gigi Dazi in piazza Tricolore o al Matarel di via Solera Mantegazza, quella stradina nascosta che sbuca a metà di corso Garibaldi. Qui, ogni lunedì, quando Craxi è ormai diventato Craxi, il ristorante si riempie di aspiranti cortigiani in cerca di un tavolo nella sala dove pranza uno degli uomini più potenti d’Italia.
Ma Milano non è solo centro. Verso via Forze Armate, prima dell’ospedale militare, ci sono quei bar di periferia dall’arredamento anni Sessanta che non si vergogna di mostrarsi: sedie in plastica, finti legni, specchietti e vetrini alle colonne, lampadario di cristallo rosé, minuscoli tavoli rotondi e bancone in finto marmo.
Luoghi poco frequentati dagli impiegati della zona, ma dove è facile incontrare malavitosi, operai, dignitosi superstiti degli sfratti e anziani coriacei che grazie alle carte bollate hanno resistito alla deportazione verso le periferie. Autentici ritratti di una Milano che resiste al cambiamento.
Come scriveva Umberto Simonetta: per l’aperitivo non si andava mai dal solito posto: «Ci piaceva cambiare, una volta un bar una volta l’altro, ci metteva allegri l’idea di provarli tutti». Tra piazza del Duomo e via Torino, fino giù alla stazione di Porta Genova, ogni locale aveva la sua storia, ogni bancone i suoi segreti, come ricorda Umberto Simonetta: «Non c’era mai stata una ragione vera e propria per cui un bar ci andava più di un altro, la ragione l’inventavamo noi».
Il nostro tour immaginario si conclude con la consapevolezza che questa Milano – quella delle osterie vere, dei trani fumosi e delle notti torbide di cabaret – esiste ormai solo nei ricordi e nelle pagine ingiallite dei cronisti dell’epoca. Una città che sapeva essere popolare e aristocratica, trasgressiva e tradizionale, spesso nello stesso momento e nello stesso bicchiere di vino rosso, versato con generosità su un bancone di finto marmo. Magari quello del famoso bar del Cerutti Gino:
Il bar Cerutti era un posto speciale, io ça va sans dire, ero veramente di casa. Ci stavano i balordi e i regolari, in perfetta armonia. Ci incontravo a volte anche il grande scrittore Giorgio Scerbanenco. Lo conoscevo perché sarà venuto al vecchio Beccaria una dozzina di volte (…). Dimenticavo che al Cerutti non mancava il flipper, accanto al juke-box, ero bravino a sbatacchiarlo a dovere, ma non è che mi facesse impazzire. Ma soprattutto c’erano ben sei tavoli da biliardo. Io sono per natura un iperteso cronico che ha sempre dormito, al più, un paio d’ore a notte, eppure, per uno che ha l’incazzatura facile, che non sa stare fermo neppure da legato, potrà sembrare strano ma, se ci sono un paio di cose che riescono a darmi una tranquillità serafica in un battibaleno, queste sono una battuta di pesca sportiva e una partita a biliardo (da un Memoriale inedito di Renato Vallanzasca).
Luci rosse: la Milano dei night. Lello Liguori, tra Milano e la Riviera
Per trent’anni Raffaello “Lello” Liguori è stato l’uomo che decideva chi poteva entrare nei locali più esclusivi tra Milano e la Riviera. Ex calciatore che aveva giocato come mezzala nella nazionale marocchina, “Liguorino velenoso” – come lo chiamavano amici e nemici per la lingua tagliente – è morto a 87 anni in una casa di riposo a Milano il 23 febbraio 2023, dopo una vita passata tra palcoscenici e retropalco della notte italiana.
Nel 1970 approda a Milano e la sua prima mossa è rilevare il Ciao Ciao di Largo Augusto. Un locale mitico che il precedente proprietario, appassionato collezionista, aveva arredato appendendo alle pareti quadri di Dubuffet, Picasso e Léger. Qui fa l’incontro destinato a cambiare radicalmente la sua vita.
C’era un cliente al quale la vecchia gestione aveva permesso di accumulare debiti su debiti. Liguori decide di dargli uno stop. «Ci sarebbe un sospesino…», lo affronta una sera. Tutto si aspettava, tranne che quello sconosciuto gli puntasse la canna di un revolver in bocca. Era Francis Turatello. Di fronte a un argomento così convincente, Liguori capisce che non è il caso di insistere. E dopo essersi informato sul conto dell’interlocutore, decide di trasformare lo spiacevole incidente in una grande amicizia.
La protezione di Francis lo fa decollare. Inaugura il Fitzgerald di corso Europa, poi apre il Number One, le Cupole (in seguito ribattezzato Caffè Roma) e infine lo Studio 54, ispirato all’omonimo locale newyorkese. A Milano Liguori arriva a gestire undici locali in contemporanea. Lo Studio 54 milanese ne diventa il simbolo: stessa estetica internazionale, stesso immaginario di eccesso controllato. Una foto d’archivio del 1979 lo ritrae sorridente davanti all’insegna: è il volto “pulito” di un sistema dove si intrecciano artisti, imprenditori, politica e, inevitabilmente, zone grigie.
Gli anni del Covo
Il suo fiore all’occhiello però è il Covo di Nord Est a Santa Margherita: la più bella discoteca della riviera ligure. La scopre nel 1966, prima ancora di approdare a Milano; prima la frequenta, poi la compra. Da qui il racconto si fa cartolina: Mina, Sinatra, Ray Charles, James Brown, Stevie Wonder, Gloria Gaynor. Per decenni il Covo è un tempio della dolce vita ligure e Liguori ne è il cerimoniere. Proprio al Covo inizia la società con Epaminonda.
È qui che la biografia scarta. Liguori è amico di Bettino Craxi. Nel 1978, durante il sequestro Moro, riceve dal leader socialista un incarico informale: andare al carcere di Cuneo e parlare con Francis Turatello per «muovere il suo ambiente», compreso quello della Magliana, alla ricerca di notizie sul covo romano. Contemporaneamente deve provare ad avvicinare Renato Curcio, sfruttando la sua reputazione di uomo vicino alla sinistra milanese. La circostanza è nero su bianco nella Relazione finale della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro (2017-2018): «Parlai prima con Turatello e poi con Curcio», riferisce Liguori ai commissari. La missione non produce risultati: Curcio lo liquida, Turatello rimanda a contatti romani. Craxi poi gli affida una seconda missione: un sopralluogo riservato in un appartamento romano che «poteva essere stato la prigione di Moro».
La scia giudiziaria
A metà anni Ottanta il suo nome ricompare nell’orbita dell’inchiesta milanese sulla “scalata” al Casinò di Sanremo (Operazione San Martino). La sua posizione è quella tipica dell’imprenditore della notte lambito da un’inchiesta più grande di lui, in un settore dove politica locale, denaro e malavita si sfiorano continuamente.
Il profilo pubblico di Liguori, specie nei necrologi, tiene insieme mondanità e sottobosco: amico dei socialisti, ben introdotto nell’ambiente di Turatello, figura-ponte fra palco e retropalco della città. Non è un “capo” della mala: è piuttosto uno snodo, un mediatore naturale, qualità che lo rende utile ai politici come Craxi e presentabile agli artisti, e che allo stesso tempo lo espone alle cronache giudiziarie.
Negli anni 2010 concede interviste “a cuore aperto”, talvolta colorite, sulla Milano che fu e sulle notti di Santa Margherita; nel 2022 la stampa milanese lo ritrae ottantasettenne, ancora lucido, tra ricordi e aneddoti. Muore dopo quattro matrimoni e undici figli. Le testate liguri e lombarde lo salutano come “il re della notte”, custode e regista di un’epoca irripetibile.
I night e l’austerity
Capodanno ’74 a Milano è un brindisi smorzato: i veglioni nei night saltano, chiusura a mezzanotte per bar, ristoranti e locali pubblici. Persino le luminarie vengono ridotte e le domeniche diventano “a piedi”: niente auto, in piazza Duomo sfilano biciclette, pattini e carrozze come in un film virato in seppia. La tv chiude prima, la città abbassa i fari e si scopre, suo malgrado, mattiniera.
In risposta alla crisi petrolifera del 1973 il governo Rumor aveva varato, a fine novembre, un pacchetto di risparmio energetico che ridisegna le abitudini quotidiane. Arrivano i distributori chiusi nei festivi, si accorciano gli orari, si abbassano le luci. Scendono anche i limiti di velocità (50 km/h in città, 100 sulle extraurbane, 120 in autostrada), la Rai riduce i palinsesti e il Tg1 passa alle 20. Nella primavera del 1974 si sperimenta perfino il traffico a targhe alterne, poi allentato a giugno.
Ma i nottambuli non ci stanno. Il 1° febbraio 1974, compare una tenda sul sagrato di piazza Duomo, ai piedi del monumento equestre: è il “quartier generale” dei lavoratori dei night. Dopo mezzanotte, artisti e ballerine mettono in scena uno spettacolo-protesta all’aperto ‒ piume e paillettes al freddo ‒ per chiedere una deroga: «Almeno fino alle due». La mezzanotte imposta ha già fatto saltare orchestre e ingaggi; l’idea è semplice e geniale: se i locali devono spegnersi, il locale si sposta in piazza. E il pubblico c’è, perché i milanesi, anche sobri e in bicicletta, la curiosità non la spengono mai.
Quella Milano “a luci basse” ricorda un po’ i recenti lockdown. La notte però, testarda, trova un varco e suona piano pur di non sparire. È la stagione in cui la città impara che può andare a letto prima, sì, ma ogni tanto ha ancora bisogno di ballare. Anche se sul sagrato.
La tribù della notte
Beppe (Giuseppe) Piroddi (1940–2022) è impresario e volto della notte milanese. Con l’amico Gigi Rizzi apre il Number One in via dell’Annunciata 31 (inaugurato nel 1968, talvolta indicato 1967), spesso citato come prima discoteca “moderna” in Italia. In seguito sviluppa il format Caffè Roma (che prima si chiamava La Cupole/Le Privé), con aperture a Milano e Roma e repliche all’estero (Londra, New York, Los Angeles).
Ha raccontato la sua storia nel libro L’Amateur, dove ripercorre l’apertura del Number One e del Caffè Roma e le incursioni nel mondo della finanza.
Per Piroddi, negli anni Sessanta la notte milanese ruota attorno a 200-300 habitué che escono ogni sera: un micro–mercato coeso, dove passaparola, telefonate e tam-tam decidono la sorte dei club. Questa domanda iper-selettiva può riempire o svuotare un locale in 24 ore, lanciare mode, attrarre staff e clientela d’élite. Fra fine anni Ottanta e anni Novanta il quadro cambia: la vita notturna si sposta sui weekend, la clientela diventa molto più ampia e i modelli di business meno elitari.
Le persone che escono di sera non sono più 200 o 300, ma molte migliaia, decine di migliaia. E hanno una particolarità: escono solo il venerdì e il sabato. In mezzo a tutto questo c’era stata la crisi degli anni Settanta, le strade e i locali vuoti, la paura, il terrorismo, la crisi economica e il flop dell’entertainment. Il Caffè Roma arrivò proprio alla fine di quest’epoca di crisi.
Il Caffè Roma diventa un luogo di moda anche perché riesce a sfruttare l’euforia post crisi dei Settanta: «La gente aveva voglia di uscire, di divertirsi, di rivivere la notte».
E soprattutto aveva un desiderio a lungo represso di poter tornare a fare liberamente ciò che faceva prima o, nei casi delle generazioni più giovani, ciò di cui aveva sentito parlare, anzi favoleggiare. Il Caffè Roma era un riconoscimento anche in Italia del successo che avevo avuto a Los Angeles: come nome, come ambientazione, come gusto, come architettura, si ispirava ai caffè parigini o londinesi degli anni Venti e Trenta. Marmo alle pareti, specchi, Art déco. Era più grande del Number One, e soprattutto non era una cave, ma copriva tutto il pianoterra, circa 350 metri quadri di superficie, un rettangolo perfetto, un’area molto pulita nel senso che non c’erano né colonne né altre strutture murarie. Il Number One, invece, era sinuoso, fatto a curve e non spazioso e ampio a open space come il nuovo locale. Tutti dovevano vedere tutto e tutti. Il Caffè Roma era anche ristorante, ma aperto solo alla sera, e discoteca con una musica molto trendy per quell’epoca. Ma trendy erano soprattutto le decorazioni: non c’erano più a Milano quelle decorazioni che ricordassero gli anni Venti e Trenta; i locali di quell’epoca avevano tutti lo stesso stile decorativo, legato ai neon, alle insegne luminose della Coca-Cola, ai bar degli anni dell’immediato Dopoguerra. Il personale era composto da ex dipendenti del Charlie Max che aveva chiuso da poco, guidati dal maître Bruno Vanoli e dal suo secondo, il mitico Bossi.
L’unica concorrenza, per Piroddi, era rappresentata dal Nepentha, dove lavorava lo stesso personale che in passato aveva prestato servizio al Number One.
La magia si interruppe, purtroppo, in modo improvviso e imprevedibile, alla fine della prima stagione, nel giugno del 1984, in quella maledetta serata che vide come protagonisti Terry Broome, Giorgio Rotti e il povero Francesco D’Alessio.