Claudia Zanella ha una di quelle biografie che sembrano scritte da un autore con un debole per le sliding door: “E se a quindici anni non avesse partecipato a The Look of the Year? E se non avesse mai incrociato Salvatores, Bellocchio, Rubini? E se, invece di una carriera da attrice, avesse scelto la barca a vela e il Circeo come destino finale?”.
La verità è che Zanella ha sempre abitato due mondi: quello luminoso dei set, dove l’hanno diretta registi che fanno curriculum solo a pronunciarli, e quello più segreto della scrittura, dove si entra scalzi, in punta di voce, e da cui non è uscito soltanto Awake (ed. Rizzoli). Prima di affiancare Christian Brogna nel racconto di un chirurgo che opera pazienti coscienti, Zanella aveva già firmato due libri molto diversi tra loro: Tu e nessun’altra (Rizzoli, 2015), romanzo intimo e generazionale, e Meglio un giorno da vegana (Sperling & Kupfer, 2017), il memoir ironico e pratico di una scelta che le ha cambiato la vita.
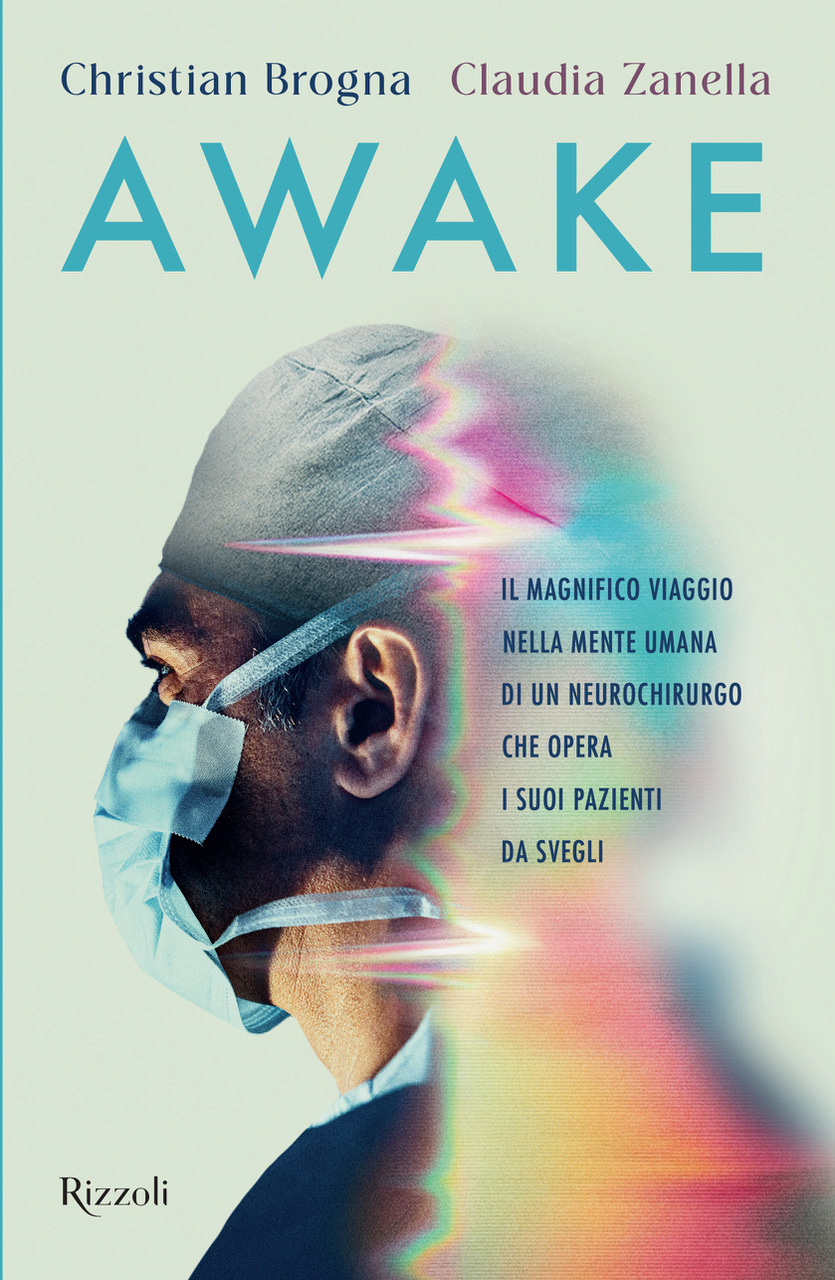
Foto cortesia Rizzoli
L’attrice che a 24 anni interpretava personaggi fragili come Ada Cantini in Quo Vadis, Baby? oggi si scopre anche narratrice di vite altrui: e non vite qualsiasi, ma quelle che si svolgono tra bisturi, coscienza vigile e cervelli che, mentre vengono operati, continuano a parlare, ricordare, suonare. Sì, perché Zanella, per raccontare la storia di Christian Brogna, ha passato più di un anno in sala operatoria: osservatrice silenziosa, attrice ma infiltrata in un teatro d’emergenza, impegnata a studiare gesti, sguardi, respiri.
E così l’intervista che segue non è solo la storia di un libro: è quella di un mestiere doppio, di una vocazione che non si accontenta di una sola vita per volta, e di una donna che ha trovato un modo tutto suo di trasformare l’esperienza – quella vissuta, quella immaginata – in racconto. Con grazia, ironia, e quella lucidità leggera che serve quando guardi un cervello aperto e capisci che, in fondo, il miracolo è tutto lì: restare umani.
Awake nasce da un incontro fortissimo con Christian Brogna. Qual è stato il momento in cui hai capito che questa storia andava raccontata da dentro?
Io e Christian ci conosciamo da quasi vent’anni. Ci siamo incontrati in un centro di yoga: lui stava finendo medicina, voleva diventare neurochirurgo e già allora diceva una cosa che ci sembrava assurda – il suo sogno era operare i pazienti da svegli. Io lavoravo come attrice. Nel gruppo lo consideravamo tutti un po’ un marziano: parlava di cose che sembravano irrealizzabili. A me però quella storia è rimasta proprio incollata in testa. Per diciotto anni mi sono chiesta: “Ma ce la farà?”. Quando ho letto la notizia dell’operazione al sassofonista sveglio, ho capito che era lui. L’ho rintracciato, ci siamo rivisti, e al primo caffè ho sentito che era necessario raccontare quello che stava mettendo in pratica: una tecnica che non salva solo la vita biologica, ma l’identità delle persone. E per raccontarla bisognava renderla “cinematografica”, dal suo punto di vista. Ed è lì che l’attrice in me ha iniziato a lavorare più della scrittrice.
Nel libro c’è un equilibrio delicatissimo tra tecnica ed emozione. Come hai lavorato per far convivere precisione scientifica e pathos narrativo?
La verità è che io di neurochirurgia non sapevo niente. Zero, come tutti. Avevo un’idea vaga di cosa fosse un intervento al cervello, ma niente di più. Quando sono entrata per la prima volta in sala operatoria, ero vestita come loro: cuffia, camice, mascherina. Mi sedevo lì con un quaderno e prendevo appunti come una studentessa al primo anno. Christian mi spiegava tutto passo passo: “Qui c’è la corteccia motoria primaria”, “Qui stiamo stimolando questa zona”, “Questo è un fascio di fibre che serve a…”.
Io scrivevo tutto, ma ovviamente non bastava. Tornavo a casa e studiavo. Davvero: ho passato un anno a studiare neurochirurgia. Non per diventare medico – anche se a volte scherzo dicendo che potrei quasi operarti (ride, nda) – ma perché non potevo permettermi di raccontare qualcosa che non avevo capito. Gli dicevo continuamente: “Spiegami come se fossi una bambina, non dare nulla per scontato”. È un po’ come quando io parlo del metodo Stanislavskij o Strasberg: per me è ovvio, per chi non recita non lo è affatto. Con Christian era lo stesso: per lui parole come “neuroplasticità” sono normali, per me erano arabo. Il lavoro è stato questo: ascoltare, farmi spiegare, studiare da secchiona e poi tradurre. E per tradurre intendo due cose: passare dal linguaggio medico a un linguaggio comprensibile, e poi da quello a un linguaggio narrativo, emotivo, romanzato. Io scrivevo la scena, lui la ricontrollava, correggeva la parte tecnica se serviva. È stato un lavoro a quattro mani molto intenso.
La difficoltà più grande è stata proprio non perdere l’emozione. Perché in sala operatoria non c’è solo un cervello: c’è una persona sveglia, con le sue paure, il suo passato, la sua famiglia, i suoi ricordi. Io dovevo tenere insieme queste due dimensioni: la precisione chirurgica e il tremore umano di chi sta lì, sul lettino, a mente lucida.
Dopo un anno passato in sala operatoria: qual è la cosa che ti ha colpita di più?
Tantissime cose. La prima è il lavoro di squadra. Nelle awake surgery è come assistere a una coreografia: la neuropsicologa, la neurofisiologa, l’anestesista specializzata sul cerebrale, lo strumentista… basta uno sguardo e tutti sanno cosa fare, come muoversi, cosa accade due secondi dopo. È quasi danza. Ma la cosa che mi ha sconvolto di più è questa: quando il paziente dorme, il chirurgo è un chirurgo. Ci vuole la mano ferma, la precisione, la conoscenza. Ma quando il paziente è sveglio, il chirurgo è due cose insieme: chirurgo e supporto emotivo. Deve rassicurare, parlare, calmare l’ansia, gestire la paura, capire le reazioni. Perché lì non c’è solo un cervello: c’è una mente. Una persona che sa che hai la mano dentro la sua testa, che può avere paura, panico, sollievo, speranza. E tu devi monitorare contemporaneamente il tessuto cerebrale e la sua emotività, la sua fragilità, la sua presenza. Quando l’ho visto la prima volta ho pensato: “Questa cosa è pazzesca. Va raccontata al mondo”. È stata la scintilla definitiva.
Dopo aver visto così da vicino la mente “aperta”, cosa la spaventa davvero?
Mi inquieta la malattia. Il fatto che tutto possa cambiare in un attimo. Oggi stai bene, tra un’ora no. Una preoccupazione enorme oggi domani diventa una sciocchezza, e viceversa. Questo ribaltamento continuo mi fa paura.
E cosa, invece, ti dà adrenalina pura?
Quest’anno mi ha dato anche una speranza enorme: ho visto persone dichiarate inoperabili tornare a vivere. Ho visto destini cambiare completamente grazie a un team e a un approccio diverso. Giorgio, un paziente che racconto nel libro, era considerato senza speranza. Tre anni dopo sta bene. Questo mi ha insegnato che a volte è davvero una persona – un medico – a cambiarti il destino.
Dopo Awake, che cosa ti piacerebbe raccontare?
Mi sono resa conto che scrivere una storia che inizialmente non riguardava me – nel senso che non veniva da una mia esperienza diretta, come i romanzi – ma che ho imparato a conoscere a fondo, mi è piaciuto moltissimo. Mi piacerebbe continuare a lavorare così: raccontare vicende eccezionali di persone che hanno vite incredibili, ma non saprebbero o non potrebbero scriverle. Non come ghostwriter, ma come autrice accanto a loro, come con Christian. Anche perché, diciamocelo, il cinema italiano dopo i 40 anni offre pochissimi ruoli alle donne. Non è come in Francia, dove scrivono ancora ruoli meravigliosi per attrici di 40, 50, 60 anni. Qui spesso vedi attori bravissimi di 55 anni con accanto sempre la ventisettenne. E tu, a 40, quasi scompari. Io però ho ancora voglia di vivere tante vite. Se non posso farlo sempre davanti alla macchina da presa, posso farlo scrivendo. Lo ridico: voglio ancora vivere tante vite, abitare le storie degli altri, provare le loro emozioni e trasformarle in racconto.












