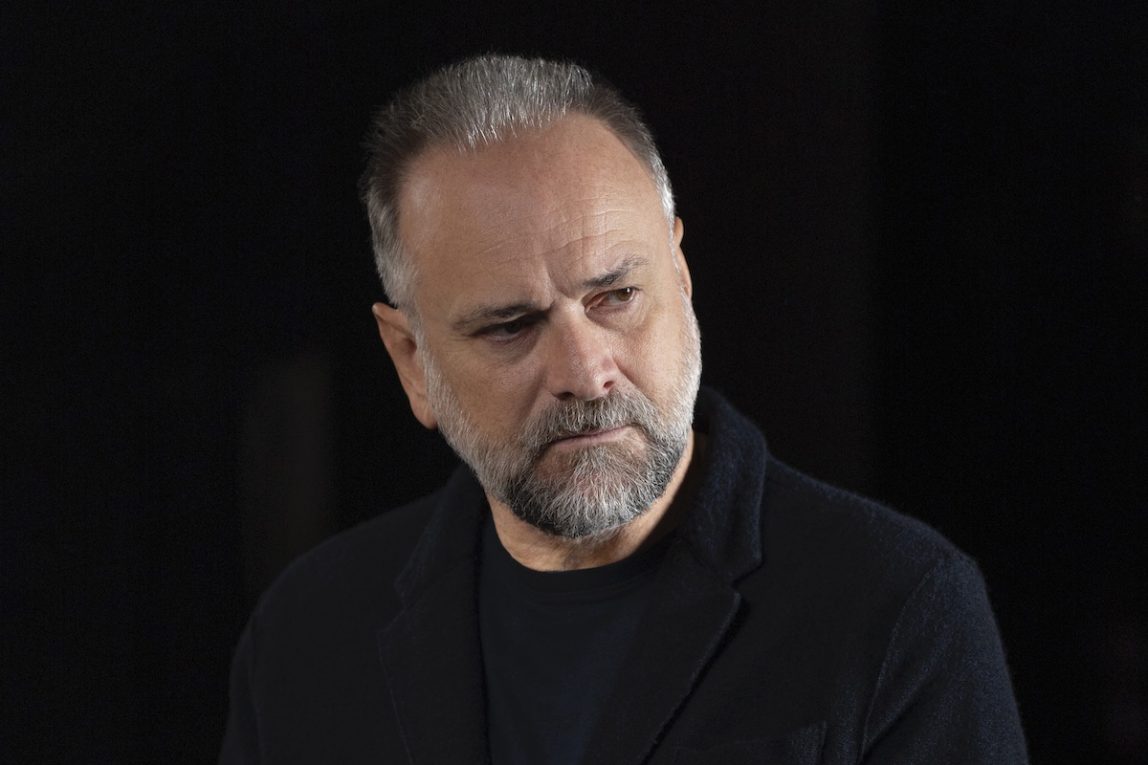Non è da tutti aver coniato un termine che poi è finito nel dizionario Treccani. E non ci riferiamo a “petaloso”. Le parole, più che essere importanti, possono addirittura cambiare il corso di un’esistenza. A lei è accaduto: con il neologismo “abbandonologa”, la scrittrice Carmen Pellegrino ha conosciuto la grande svolta della sua carriera, dal primo saggio storico a un libro che è diventato un caso letterario e in seguito è rimasto un cult all’interno di un ambito che, finora, non conta nessun altro collega (il poeta Franco Arminio è definito “paesologo”, ma ci sono delle differenze).
L’intervista che state per leggere ha una particolarità, forse, unica nel suo genere. È iniziata prima della pandemia e si è conclusa in seguito, pochi giorni fa. È sembrato di rivedersi dopo otto anni, non otto mesi. Il Covid, infatti, ha segnato irrimediabilmente le nostre vite – anche se molti ancora non se ne rendono conto – e riascoltare quell’audio registrato prima dello sconvolgimento che abbiamo attraversato ci è apparso come un salto temporale in un’epoca remota.
Non eravamo più gli stessi. Né chi domandava, né chi rispondeva.
E così è venuto naturale parlare di tutto. Del nuovo libro, di cui ci ha anticipato l’ultimo capitolo (influenzato proprio dal lockdown), provando a tracciare un profilo di un’artista inquieta sin da piccola, che però rappresenta una delle più alte espressioni culturali del nostro Paese.
Che bambina sei stata?
Sono cresciuta in un paese piccolo e poi ero particolarmente solitaria. Desideravo che si materializzasse una libreria nella piazza principale, come quelle che c’erano a Salerno, ma noi avevamo una cartolibreria e tanto bastava. Ho vissuto a lungo in campagna, ancora più in là del centro della comunità. A ripensarci, era inevitabile che cominciassi a parlare con quello che avevo attorno, con gli alberi, miei fidati confidenti, e anche con chi non c’era. Ero affascinata dalle case ferme nel tempo, quasi cristallizzate, lasciate da chi era partito per andare a cercare fortuna altrove. Però non ero spaventata da quel vuoto. Grazie a quelle visioni ho cominciato a scrivere racconti in cui immaginavo il ritorno dei vecchi abitanti. Qualcosa si è fissato per sempre nel mio immaginario, per esempio una pianta che continuava a fiorire anche se non riceveva mai cure.
A scuola eri la prima della classe?
Mi piaceva studiare, ero curiosa come una scimmia, lo sono ancora, mi sembrava che i libri schiudessero mondi altrimenti inaccessibili. Ricordo che compravo dei libri per corrispondenza e poi un dizionario Zanichelli a rate, 9.900 lire al mese per tanti mesi. Alle medie un insegnante ci parlò di Don Milani, soffermandosi sulla fiducia che riponeva nelle parole. Tra un padrone e un operaio, diceva, corrono diverse centinaia di parole: il primo ne conosce 1000 e l’altro 100. Mi colpì. I miei nonni da parte paterna erano contadini, ma conservavano i libri dei figli e si sono spaccati la schiena nei campi per farli studiare.
Avevi già come obiettivo di diventare una scrittrice?
Non con chiarezza, ma di certo sapevo che avrei fatto qualcosa legato alla scrittura. Quando ho pubblicato il mio primo saggio storico mi dissero che era un po’ troppo “narrativo”. Se non avessi ricevuto l’incoraggiamento che poi ho avuto, forse avrei continuato a girarci intorno. Ma una parola detta al momento giusto può indirizzare il corso di un’esistenza.
Sembri una persona molto riflessiva: hai mai fatto qualche follia?
Ne ho fatte abbastanza. Una era prendere e partire. Andavo alla stazione senza avere una meta, cercavo una destinazione, facevo il biglietto e andavo. Ho sempre avuto questo bisogno. Nel mio lavoro, nella fase che viene dopo la scrittura, bisogna spostarsi parecchio e talvolta diventa faticoso, ma è anche la parte che più mi manca quando non posso farlo. Malgrado sia legata alla mia terra, mettere stabilmente radici non mi riesce. Sento ancora questo desiderio di partire senza pensare al ritorno. Il problema è più per i familiari o se sei legata a una persona. Sparivo. Facevo perdere le tracce. Non so spiegarlo, avvertivo questo bisogno di non rendere conto a nessuno.
E come reagiva chi ti era vicino?
Con grande difficoltà, perché prima o poi devi tornare e ricomporre un rapporto. Quando hai una relazione, c’è un “dover essere” di cui tener conto, che è anche una forma di rispetto dell’altro e il mio modo di fare veniva sentito come una mancanza. Invece era un desiderio di allontanarmi e riprendere un dialogo con me stessa per poi tornare pacificata. Difficile da spiegare all’altro.
Non senti il bisogno di crearti una famiglia?
Fatico un po’ proprio con il “dover essere” delle cose e delle età. Non ho avuto figli, forse sono ancora troppo figlia. Mio padre lamenta che fra tutti i suoi amici soltanto lui non è diventato nonno. Quindi si consola con i pomodori nell’orto, che gli riescono anche a gennaio, nonostante il clima freddo del paese. Vivo da sola da quando avevo 18 anni, sono stata coraggiosa quando è stato il momento di andare contro le aspettative dei genitori, specie per inseguire un sogno, però la responsabilità di una vita che nasce da me non sono in grado di sostenerla. Perlomeno così me la racconto. Mi sento inadeguata e le relazioni, inevitabilmente, risentono di questa inquietudine.
Dopo la pandemia, però, sembra essere cambiato qualcosa.
Abbiamo trovato un linguaggio che ci ha avvicinati. È bizzarro. Forse la sospensione del tempo ci ha dato una chiave per entrare più in intimità. Una dimensione così incomprensibile, evidentemente ti porta a delle considerazioni. Sperimentare la possibilità che da un momento all’altro ti possa accadere qualcosa, come durante una guerra, ci ha portato a scoprire ciò che fino ad allora non ci eravamo detti. Mi è accaduto anche con gli amici che non sentivo da tempo. Forse è questo uno dei pochi aspetti positivi di questo periodo così angosciante: ci ha ricordato quanto gli altri siano importanti.
Oggi tutti cercano la felicità. Per te cosa rappresenta?
È una delle parole più ricercate sul web e utilizzate sui social. È anche un po’ uno specchietto per le allodole per la pubblicità. Non tanto come anelito, ci mancherebbe, è sano desiderare di essere felici, ma pare che anche questo sia ormai un “dover essere”. In questo tempo sembrerebbe una conquista facile, se poi ci pensi è uno concetto ambiguo e indefinibile. La società ha definito quale dovrebbe essere l’orizzonte della felicità di ognuno e siamo a un livello molto elementare, schiacciato sul presente, sull’avere delle cose, sull’esser-ci nel senso del condividere sui social. A volte sembra quasi che si viva per raccontarlo in un post. Ma io credo che la nostra sia una società attraversata in modo sotterraneo da un profondo senso di tristezza. Quanto più è radicato, tanto più lo si deve nascondere agli altri.
Come te lo spieghi?
Per il rischio di essere isolati, quasi si possa essere contagiati dalla tristezza altrui. Chi ha un malessere interiore, chi non riesce a stare al passo con quello che ci viene richiesto, ovvero di essere leggeri, vivaci, performanti, è quasi costretto a nascondersi, avendo anche difficoltà ad ammettere con sé stesso il proprio malessere. Quindi si finge e i social aiutano a costruirsi una sorta di identità virtuale. Gli archeologi la chiamano anastilosi: è la tecnica di ricostruzione a seguito di un evento distruttivo.
Sarà che le nuove generazioni guardano al futuro con sempre maggiore preoccupazione?
È come se fosse venuta meno la promessa di futuro. Questo senso continuo di instabilità, insicurezza, precarietà si ripercuote sulla tua identità e ti senti vacillare, per cui ti ricostruisci una sorta di identità parallela dove va tutto bene. L’eccesso di iper-connessione poi corrisponde a questo sostrato di tristezza. Più racconti di essere felice e tanto più il retroscena è dolente. Non è una operazione truffaldina, ma una sorta di autoinganno. Siamo costretti a farlo per restare in questo tempo che altrimenti ci escluderebbe.
Se ti guardi indietro in questo percorso letterario, cosa vedi?
Il primo libro fu un saggio sui movimenti del ’68 a Napoli, edito da una piccola casa editrice sarda. L’unica che non mi chiese soldi per pubblicarlo. Un libro che aveva la prefazione dello storico Giovanni De Luna, mio professore elettivo, da lui ho imparato tutto quel che so sulla ricerca storica, senza che me lo abbia mai insegnato: è un ex sessantottino e guai a chiamarlo maestro! Quel libro fu pubblicato sette anni prima di Cade la terra. Poi ho scritto racconti di narrativa con degli spunti di cronaca. Parallelamente, per passione, mi occupavo di paesi abbandonati e ne ricostruivo le vicende per Il Mattino, quando ancora c’era Francesco De Core. Massimo Onofri, scrittore e critico letterario, lesse un mio racconto su Roscigno vecchia e mi suggerì di trarne un romanzo. Così è andata.
E sei diventata “abbandonologa”.
Andare per abbandoni, che siano paesi o case, mi riporta a una quiete interiore che difficilmente conquisto altrove. In Italia sono circa sei mila i paesi in via di abbandono. Se consideriamo che i comuni italiani sono circa otto mila è una cifra impressionante. Due mila sono abbandonati.
Non è da tutti coniare un temine che finisce nella Treccani, lasciando da parte “petaloso”.
Ho sempre lavorato con le parole, ne riconosco l’importanza e le insidie. L’ho interpretato come un segno di incoraggiamento a proseguire lungo una strada accidentata, visto che i miei sono temi non proprio popolari tra la gente.
Quando hai capito che questi temi potevano funzionare?
Un po’ prima dell’uscita di Cade la terra, quando Andrea Di Consoli, che è stato autore di programmi Rai tra i migliori del palinsesto, mi chiamò al Caffè di Raiuno proponendomi di parlare di borghi abbandonati in trasmissione. È stato coraggioso, perché proporre il tema dei borghi abbandonati al mattino presto è un azzardo. Forse è piaciuto il modo in cui li racconto, una prospettiva diversa rispetto al semplice rudere che tutti possono vedere nel suo naturale disfacimento. Non devi per forza vederci la fine di qualcosa, la triste soccombenza al tempo. Piuttosto l’inizio di un tempo diverso, il tempo delle cose che non risponde più alle logiche utilitaristiche dell’uomo. E poi, mettendoci ancora di più sulla soglia, attivando una sorta di sguardo che coglie oltre il visibile, chi di noi non ha ferite e non è sopravvissuto a qualcosa? Con quella stessa forza un rudere, costruito con un anelito di eternità, continua a resistere, nonostante gli spacchi e le crepe e il tetto caduto. C’è come un furore di eternità in ciò che resiste, malgrado la guerra del quotidiano.
Che rapporto hai con le altre forme d’arte?
Amo l’arte, i pittori della luce, Caravaggio o Georges de La Tour, come quelli delle ombre, penso a Vilhelm Hammershøi. E poi la musica classica, così come il rock. Mi affascinano figure come quella di Roky Erickson dei The 13th Floor Elevators. Mi piaceva la sua voce e la sua storia. Una personalità controversa, oggi direbbero drop-out. Apprezzo questa parte del rock, che contiene come la sottotraccia delle vite difficili. Seguo poi Paolo Conte, lo seguo nel senso che vado a quasi tutti i suoi concerti, l’anno scorso sono andata a Perugia e a Genova soprattutto per sentire dal vivo la sua Diavolo rosso che è meravigliosa nella parte strumentale, i suoi musicisti poi sembra che si consumino durante i concerti, sono grandiosi. Avevo già il biglietto per il concerto di quest’anno che doveva tenersi in giugno a Mantova, ma per le ragioni che sappiamo è stato rimandato all’anno prossimo. Ultimamente ho riascoltato Montesole di Giovanni Lindo Ferretti, è davvero emozionante: quanta bravura nei nostri cantautori. Riascolto spesso Piero Ciampi, Enzo Jannacci, Luigi Tenco…
Come donna, hai avuto problemi in un mondo culturale ancora dominato dagli uomini?
Devo ammettere che solitaria ero e solitaria sono. Vivo questo ambiente in maniera un po’ defilata. Scrivo e mi limito alle frequentazioni professionali. Quando il libro viene pubblicato, mi impegno nella promozione e negli incontri, ma non so fare pubbliche relazioni, non partecipo alle feste editoriali, nemmeno a quelle del mio editore. Piuttosto rivedo i vecchi amici, quando vado a Milano li costringo a portarmi in vecchie locande dove ci sono ancora le tovaglie a quadroni e il vino aspro della casa. Resta la questione della esigua presenza di donne nei ruoli e nei luoghi decisivi, ma è un riflesso di ciò che accade nella società italiana, che anche da questo punto di vista mi sembra incamminata fieramente verso l’involuzione e il regresso.
Oriana Fallaci considerava i libri i suoi figli. Anche per te è così?
Preferisco non sentirli così, li disconoscerei di sicuro. Per esempio, il mio secondo romanzo Se mi tornassi questa sera accanto, penso che avrei dovuto scriverlo meglio. Rispetto a Cade la terra è di più facile lettura, ma è maggiormente emotivo. L’ho scritto mentre attraversavo un immenso dolore familiare e penso che risenta di quello stato d’animo. Durante le presentazioni facevo molta fatica, infatti ne ho annullate parecchie. Alla prima presentazione a Roma, ricordo che mi si è incrinata la voce e non sono riuscita a proseguire. Alessandro Leogrande che era uno dei relatori, oltre ad essere un amico che non smetteremo mai di piangere e rimpiangere, prese la parola e mi salvò dall’imbarazzo. L’avrei scritto comunque, ma in un altro momento.
C’è mai stata una parola che ti ha tormentato?
Per Se mi tornassi questa sera accanto giravo sempre intorno alla parola “riconciliazione”. Una parola che ricorreva continuamente. Ci sono delle parole guida in certi periodi della vita. Così con Cade la terra era “disfazione”, cioè disfacimento. Adesso ricorre: “partenza meravigliosa”. Come gli uccelli, che fanno queste partenze meravigliose migrando. Nel libro in uscita ritorna spesso.
Da intellettuale, come vivi il dibattito politico di questi anni?
La vivo male, perché avverto un senso di impotenza. Da ragazza ero una rivoltosa! A Genova nel 2001 c’ero anch’io. Poi con l’età ti adegui o ti rassegni a pensare che forse è meglio cercare di cambiare te stesso prima di poter cambiare il mondo. Chi lavora nel mondo della cultura dovrebbe avere un ruolo più incisivo. Invece mi sembra che siamo totalmente tagliati fuori dal dibattito. Se ricordiamo l’importanza che hanno avuto gli intellettuali negli anni ’50-’60… Pensiamo alle avanguardie, che certo non avevano l’obiettivo di arrivare a tanta gente, ma dialogavano con la classe politica attraverso i loro scritti. Al riguardo mi viene in mente La ragazza Carla, il poemetto scritto da Elio Pagliarani, di cui qualche politico tenne conto per capire cosa stava accadendo nella società italiana di quel tempo. Oggi gli intellettuali vengono per lo più sfottuti da certi politici.
Vi chiamano “professoroni”.
In parte perché, negli anni, gli intellettuali stessi si sono progressivamente ritirati dal dibattito pubblico. E poi perché molti dei politici attuali non leggono. Hanno invece una grande smania comunicativa e usano tutto ciò che è funzionale a un post sui social. Se fai il politico è giusto che affermi le tue idee, ma non puoi invalidare gli intellettuali, gli scrittori o semplicemente chi ne sa più di te in un certo ambito, generando odio e irridendo la competenza. Le conseguenze sono enormi. Per esempio, un pauroso analfabetismo di ritorno.
Ultimamente hai deciso di impegnarti in politica, candidandoti in una lista civica nel tuo comune, Postiglione degli Alburni. Cosa ti ha spinto a farlo?
Deborah Amoruso con la lista civica “Postiglione che Vogliamo” me lo ha proposto e sono rimasta colpita dal desiderio che ha mosso quei candidati. Quasi tutti giovani, che hanno preso in affitto uno spazio dismesso (un ex bar) e tra gli obiettivi avevano l’istituzione di una biblioteca pubblica. Il mio è uno di quei paesi a rischio spopolamento, di cui dicevamo prima. Due mila abitanti e quasi tutto chiuso. Sono rimasti tre bar e nessun luogo di ritrovo. Un paese di immensa bellezza paesaggistica, che vale una visita anche solo per godere della vista dei monti Alburni e dei faraglioni di Capri in un solo sguardo prospettico. Ma d’inverno è dura. Per questo i ragazzi chiedono un luogo dove ritrovarsi a leggere e a stare tra loro. Non ci ho pensato un attimo, anche se un intellettuale oggi ha solo da perdere con l’impegno diretto, dato che rischia di attirarsi degli odi spaventosi. Tra le cose che ho dovuto sentire, c’è stata persino la voce che l’avessi fatto per vendere i miei libri, il che fa sorridere perché sono voci rimasticate senza avere il minimo senso della realtà. L’esito elettorale non è stato per noi propizio, ma io continuerò a sostenere il progetto e la mia sindaca! Dicevano anche che il paese non era pronto per un sindaco donna. Quando lo saremo sarà sempre troppo tardi.
Come hai trascorso il lockdown?
A Napoli, all’inizio, non ho avvertito un grande cambiamento. Venivo da mesi di “clausura” per completare il romanzo. Dopo un po’ è diventato insopportabile persino il luogo che di solito mi è più familiare. Ho sofferto di non poter uscire a camminare, questo sì, qualche volta sono stata fermata dai carabinieri per aver superato i limiti del quartiere. Ma c’è chi ha sofferto cose peggiori, quindi fermo qui le lamentele personali. C’è da dire però che il periodo ha offerto diversi spunti di riflessione sulle libertà che diamo per scontate. Anzi, sulla libertà che a un certo punto ci è stata tolta, in un modo che in questo tempo, in questa parte del mondo non si pensava potesse più accadere. In più, avevo già un rapporto conflittuale con le città, dove è quasi totale la mancanza di verde. Ormai abbiamo introiettato questa cementificazione della visuale, che a me causa mancanza di respiro. La fame d’aria il virus l’ha portata con sé anche da questo punto di vista. Purtroppo, ci siamo rassegnati a vivere in una condizione che ha ben poco di poetico.
Da scrittrice, quali immagini ti sono rimaste più impresse?
Mi ha colpito il Papa da solo in San Pietro, la pioggia a scrosci, a parlare a un’umanità dolente. Mi ha colpito così tanto che ho immaginato una piccola storia confluita nella parte finale del nuovo romanzo. La storia di una persona avulsa dalla realtà che, passando in quei paraggi, si ritrova a ricevere l’indulgenza plenaria e una grande benedizione. Ciò lo gratifica: lui che si è sempre sentito l’ultimo degli uomini è grato a Dio per quel momento inaspettato, per tutta quella considerazione.
Hai parlato anche di fenomeni umani inquietanti.
È stato qualcosa di dirompente. Ha tracciato una linea tra il prima e il resto. Sembra quasi che nulla possa tornare com’era, anche se non è che fosse il migliore dei mondi possibili. Abbiamo assistito al dilagare della diffidenza verso gli altri. Un sentimento che era già largamente diffuso, aizzato spesso da un certo modo di fare politica, ma che ha trovato una sua giustificazione, è stato legittimato. Quando non era ancora obbligatoria la mascherina, ho assistito a scene di insulti e violenza verso chi non l’aveva o se l’era solamente dimenticata. In nome di un diritto alla salute, che è sacrosanto, si sono calpestati molti altri diritti. Odiare l’altro per la sua eterodossia è diventato legittimo.
E gli altri?
Si è verificato come un capovolgimento delle priorità, dei valori. Una sera al telegiornale diedero l’annuncio del fermo di 4-5 persone che erano state sorprese a fare un pic-nic. Venne annunciato con un tono così grave che la notizia di un furto con scasso sarebbe stata meno eclatante. Un capovolgimento del senso del lecito al quale ci siamo adeguati rapidamente. Così come alla delazione, che è diventata accettata, anzi, addirittura incoraggiata. Non dimentico poi il quotidiano bollettino dei morti della Protezione civile. L’ho seguito per un po’, poi ho smesso. Era qualcosa di molto violento, a ripensarci ora, eppure alle sei del pomeriggio eravamo davanti agli schermi. La morte faceva irruzione nelle nostre case con una conta numerica. Per non parlare delle immagini delle bare di Bergamo che ci hanno ricordato qualcosa che avevamo rimosso, ovvero che si muore.
E poi nuove parole sono entrate nell’immaginario collettivo, come “congiunti” o “distanziamento sociale”.
Distanziamento sociale che vuol dire? È qualcosa di molto rischioso associare il distanziamento alla dimensione sociale. Invece è stato lanciato con leggerezza nel calderone della comunicazione. Bastava un semplice “distanziamento”. Non ce ne libereremo facilmente e non ne avevamo bisogno. Come la diatriba sul termine “congiunti”. Chi può stabilire il livello di intimità che abbiamo con gli altri? Decisamente invasivo. Tutta questa rigidità è poi venuta meno quando è stato possibile uscire: la gente ha reagito in maniera incontenibile e di sicuro sono andati in vacanza o nelle piazze anche quelli che nei mesi passati fotografavano dalla finestra i dissidenti della camminata. Ed è giusto così. L’essere umano non può vivere isolato, in perenne assedio interiore rispetto agli altri. La relazione umana è necessaria.
Nella tua terra d’origine c’è uno stretto rapporto con i morti.
Un rapporto non atterrito, diciamo così. Di prossimità. Non si può espellere o ignorare questa parte della vita, anche perché quanto più la confini tanto più la ingigantisci. È qualcosa di inevitabile, è il ciclo naturale della vita, un albero non nasconde le foglie che appassiscono e cadono, le assorbe pian piano nelle sue radici. Gli alberi sono grandi e muti maestri. Al paese ho un ulivo su cui ho un piccolo sedile, mi ci rifugio ogni volta che non capisco gli uomini, per quanto mi sforzi. Gli ultimi due mesi li ho passati lì sopra, pensa tu.
Ma è vero che andavi ai funerali di sconosciuti?
È un modo per esprimere una vicinanza. Ho cominciato da ragazzina, al paese, dove i funerali sono un rito aggregante, ci vanno davvero tutti anche se il defunto non era un amico o un parente. In quel momento si acquieta ogni ostilità. Quando mi sono trasferita a Napoli, mi colpì che sui manifesti venisse riportato anche il soprannome del defunto. Mi sembrava un modo anche giocoso di esorcizzare la morte. Mi rattristano i funerali con poche persone, nelle grandi città accade spesso, a volte non c’è quasi nessuno.
Il funerale più particolare al quale hai assistito?
Quello di ‘O tubato, così era soprannominato. Avevo interpretato in maniera semplicistica, è cioè che il defunto per buona parte della sua esistenza avesse vissuto intubato, al punto da prendere il soprannome. Invece, era “il turbato”, ovvero un irregolare: si vestiva di tutto punto alle undici di sera e, attraversando il quartiere e salutando gli sconosciuti, annunciava la rivoluzione.
E tu ci hai mai pensato a come vorresti morire?
Ci penso spesso. Vorrei che accadesse nel sonno e lontano dai miei cari. Vorrei addormentarmi e non avvertire il passaggio. Non ho paura della morte, solo che preferirei sparire, lasciare agli altri la sensazione di una morte lontana. Come gli animali che si appartano quando sentono che è il momento, senza lasciare a chi resta lo strazio di rendersene conto. “Il nostro silenzio avrà una voce”, scriveva Alfonso Gatto, “di là, di là, e non son cupole, non son chiese, ma bambini, bambini che gridano”.