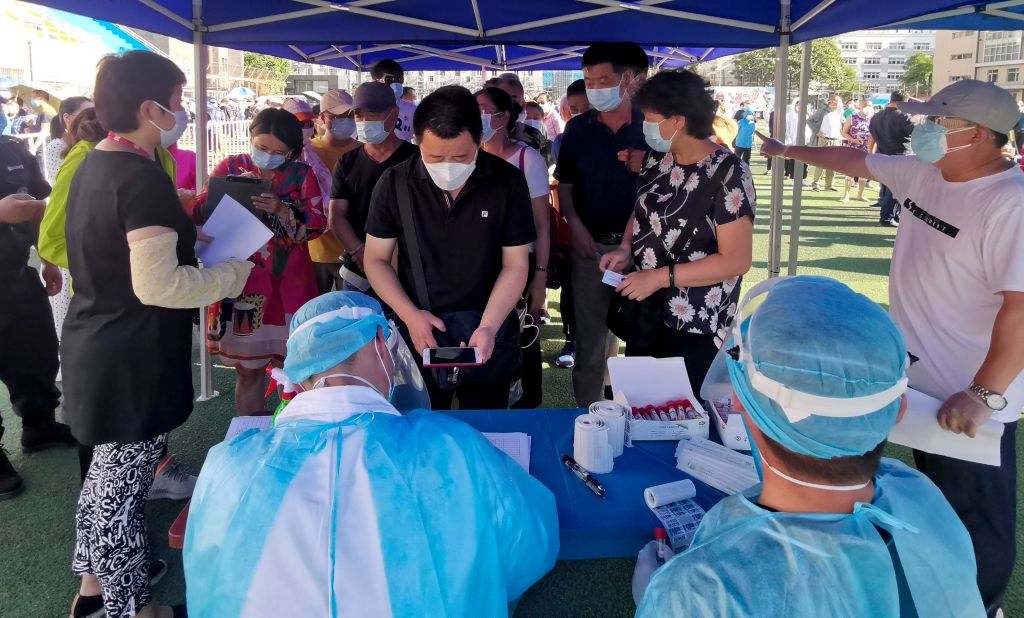I primi giorni pareva che cascasse il mondo. Non poteva essere arrivato qui. C’era un caso in paese. Qui tra Lucca e l’Abetone, qualcuno lavorava a Codogno. Ma se la gente non esce dalla Bientinese e va solo al mare in Versilia, come è possibile che qualche cristiano si sposti a Codogno? Esiste davvero Codogno? Poi settimane uguali e lunghe. Un silenzio tetro. Adesso è passato un mese ci siamo abituati. Il Covid-19 si è plasmato a noi e ha infestato anche questo posto dimenticato da Dio in cui non succede mai nulla, divenendo anch’esso qualcosa che non si sa se succede ma che ci impaurisce. E si sta in casa.
Il sole sembra un tuorlo d’uovo che cola come uno sputo su un vetro. Sparisce dietro le montagne dell’Appennino come ingoiato da quelle vette spigolose. C’era e poi non c’è più. Anche oggi. E non so più che giorno sia ma rimangono nell’aria quella bellissima foschia rosa e blu e qualche nuvola tersa che mi portano via coi pensieri. È il momento più bello della giornata. Mi alzo all’alba e guardo tutta la vallata sotto di me. Ogni tanto passano i tir che vanno alle cartiere, sempre accese, per il resto si sente un silenzio lungo chilometri.
La mia vita non è così diversa da prima, solo che non vado più all’Esselunga. Ci sono le persone ammassate già alle 7 del mattino e mi irrita troppo. Sembrano dei grossi sacchi gonfi di vecchi vestiti che stanno in piedi solo perché si appoggiano al carrello. Cristo, l’Esselunga per loro è il Tempio, devono andare a fare un’offerta al loro Dio. D’estate sembra un reparto di geriatria occupato da pensionati in cerca di fresco che leggono i quotidiani senza comprarli, d’inverno il punto d’incontro di tutta la comunità. Decine di piccoli negozi si sono messi a disposizione per portare il cibo a casa, ma all’Esselunga c’è la fila di trecento metri, fino alla stazione quasi. Sentono che devono andare all’Esselunga, hanno timore del virus ma vogliono comunque fare la fila per comprare verdure che sono state surgelate per mesi e pesci che sembrano vecchi. E poi cazzo: devono collezionare i punti! Poveri cassieri, gente della comunità che tutto l’anno se ne sta a sedere e strisciare sul rullo chili e chili di prodotti in eccesso che i loro concittadini portano a casa. E si beccano sempre starnuti, partacce, rimbrotti. Il cassiere è un lavoro orrendo, spero veramente che sparisca e che ci affideremo solo alle macchine per svolgere questa mansione ripetitiva e alienante.
Io che ho vissuto dieci anni a Milano so cosa vuol dire una comodità come la spesa a casa. Quindi mi affido a questi nuovi amici, i bottegai. Spendo il triplo, ma viene Daniele col furgoncino e la mascherina tutto bardato. Vuoi mettere? Le patate sono sporche di terra e sulle uova del contadino ci trovi spesso le piume della gallina o delle piccole scagliette di merda. Daniele deve essere uno che non batte tanto pari, gesticola e sbaglia sempre qualcosa nell’ordinazione. L’altro giorno mi ha venduto una scatola di pesce surgelato aperta e richiusa con lo scotch, ma non gli ho detto niente. È come in tempo di guerra, ci si abitua. Il farmacista ad esempio mi vende le mascherine sfuse, due euro l’una. Le prende e me le mette in un sacchettino di carta. Si sente in colpa a chiedermi dieci sacchi per cinque pezzi, ma lo fa. Mi conosce, eppure non riesce a esimersi.
La mattina alle 11 passa il panettiere con un furgone, si piazza nella strada in cui vivo e suona il clacson. Uno a uno escono dalle case e vanno a prendere la loro ordinazione. Daniele quando mi consegna la verdura si porta pure il POS che qui è come possedere un’astronave. Non ho mai visto nessuno pagare col POS in paese prima del Covid. Non mi azzardavo nemmeno a chiedere se c’era la possibilità per non rimanere antipatico ai commercianti: «Oh questo qui crede di essere a Milano ancora?». In paese c’è un bancomat solo e spesso i liquidi son finiti. Ora, allo sportello, il cestino per le ricevute che era pieno di scontrini e sigarette è rigonfio di guanti mono uso buttati via.
Le giornate sono scandite da due telefonate sul fisso. È sempre il sindaco. Chiama ogni giorno alle 12 e la sera alle 19 con un messaggio registrato in cui invita i cittadini a stare a casa. È prolisso. Dà anche i suoi numeri di telefono e dice che lo possiamo chiamare fino a mezzanotte, poi deve dormire. Ha due numeri sempre attivi a cui risponde personalmente. È sovraeccitato e si propone in una diretta quotidiana su Facebook che ogni sera dura almeno un’ora, iniziando più o meno appena dopo la conferenza stampa della Protezione Civile. Il sindaco si presenta con un giubbotto catarifrangente con su scritto “sindaco” o con un look stile Salvini con le felpe dell’Arma, e parla in dialetto stretto di gente che conosce di persona. «È morto Tizio, sono addolorato… ma dobbiamo reagire!» e si esalta, pare che stia facendo la diretta tv nazionale, spara anche parecchie cazzate. Il sindaco di un comune qui vicino invece è un over 60 che gli è presa la mano con Facebook e posta foto di lui che fuma tre sigarette assieme dalla mascherina, o status pseudo ironici in cui minaccia di sputare a chi trova in giro. Seguo anche lui. La gente gli fa like e lo ama. C’è tutta questa ondata di sindaci pazzi della provincia che fa il giro del mondo su social e tv, ed è la gente vera.
Il primo giorno di corona virus siamo stati colpiti anche nel mio minuscolo comune. Un tizio che lavorava a Codogno. Assurdo. Nessuno sapeva chi fosse. Mi chiama Marcello e mi fa: «Il sindaco era al carnevale in piazza sul palco vestito da ranocchio. Penso fosse ‘briao (ubriaco). Siamo in mano a questa gente». Ma non ci penso, non vorrei mai essere al suo posto.
In paese ci sono due bar. Uno vecchio e storico, anni ’70, frequentato solo da gente anni ’70, l’altro nuovo e tutto di plastica, con la new generation di quarantenni. Io vado a quello dei vecchi. La mattina c’è Garibaldi fuori dalla porta, arriva prima del barista anche quando d’inverno è sotto zero e parla pure da solo. Ho paura per Garibaldi che ha 80 anni e la stufa a pellet. Mi raccontava che non ha mai preso medicine in vita sua, che una volta col febbrone ha fatto bollire delle erbe nel vino come uno stregone e la mattina dopo non aveva più niente. Si chiama così perché faceva il DJ. DJ Garibaldi alle feste di paese a mettere i dischi con la polka negli anni ’50. Non ho sue notizie e spero che a fine quarantena sia vivo e che il bar non chiuda. Sarebbe una tragedia per me.
I primi giorni di isolamento passava un’auto dei vigili urbani con il megafono acceso, ora per fortuna ha smesso. Il passo lento giù nella via evocava più l’immagine del carro funebre più che dello stato. Dagli altoparlanti, il solito messaggio registrato del sindaco, una scorreggia loffia con qualche variante rispetto a quello serale. Osservo scene come questa dalla finestra della mia cucina che ha le inferriate (come tutte le altre finestre al piano terra), una vera e propria grata, e la considero una prigionia romantica.
A Milano vivevo in 20 metri quadrati, una casa quadrata fatta di una sola stanza. Qui vivo in una casa di famiglia che conserva ancora l’arredamento di mia nonna. Ho cinque stanze, un lembo di giardino sul retro e la mattina mi svegliano i galli e gli uccelli. Dormo letteralmente con la porta aperta ormai, perché mi scordo di chiuderla. Di notte non c’è nessuno. Solo il rumore di un’elicottero della protezione civile che fa le ronde per beccare chi cerca di sconfinare. Solitamente verso mezzanotte.
Abito in fondo a una strada quasi sterrata, tra la statale e i campi della Toscana del nord. Ci viviamo solo noi delle stesse famiglie da cinquant’anni. Mia nonna la chiama “la via”. Tutti conoscono tutti. Saremo una decina. Non esco dal 4 marzo se non un paio di volte per comprare mascherine e prodotti. Non vedo veramente nessuno. Le uniche persone che vedo passare dalla finestra sono una signora che sta cinquanta metri più sotto e altri tizi che non conosco. Passano perché il cassonetto è vicino alla curva. Solo per quello.
I rami di un pero da giardino oscillano mossi dal vento con uno sciacquettio calmo. Sono così vicini che quasi mi arrivano alla finestra, ma realizzo che è l’albero del mio vicino. Ormai i giardinieri non vengono più e qui in campagna chi ha l’orto e sa fare, fa da solo, le famiglie senza un uomo o qualcuno col pollice verde, hanno lasciato andare l’orto. Io non so fare. E non ho gli attrezzi. Servirebbero la motosega e un furgoncino per portare i sacchi dei rami a un punto di raccolta apposito. Così ho l’erba alta cinquanta centimetri e ogni sera sento fruscii e rumori animali. D’inverno c’è il riccio. Ora più che altro insetti. Settimana scorsa ho fatto fuori uno scorpione. In casa. È stata la roba più terrificante che mi sia successa in quarantena.
Per il resto fumo e guardo l’orizzonte, pensando solo che ho tanta voglia di andare al bar e abbracciare il mio amico Gari. Ce la faremoooo. E divento un meme.