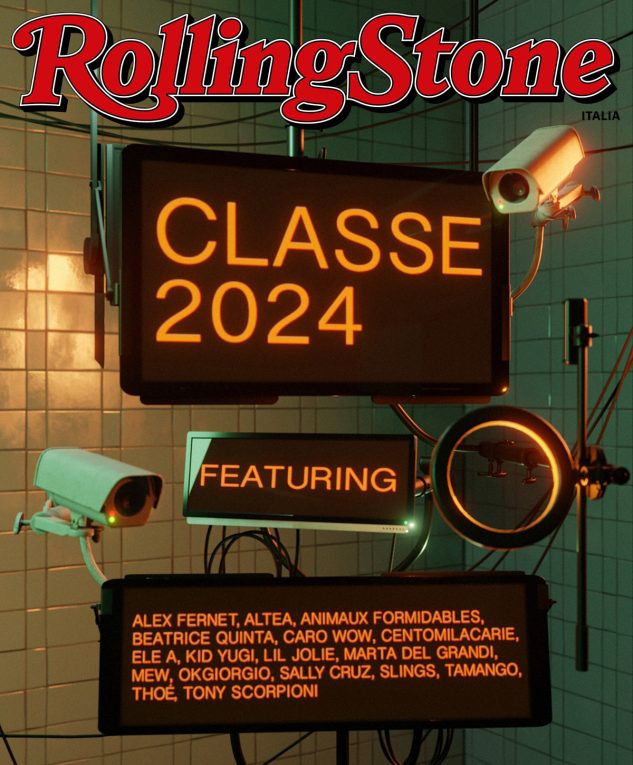‘Il primo re’: Roma è nata nel fango e nel sangue
È un kolossal che cambierà il cinema italiano, una sfida logistica e commerciale vinta alla grande, come ci raccontano Alessandro Borghi e Matteo Rovere
Foto Fabio Lovino
Il regista Matteo Rovere è un pazzo. Perché solo un pazzo poteva immaginare un film così. E ovviamente ci piace proprio per questo. Quindi Il primo re lo abbiamo seguito dalle fondamenta, da quando Alessandro Borghi e tutto il cast sguazzavano nel fango giorno e notte: ci siamo andati pure noi a Manziana, una quarantina di chilometri da Roma, a insozzarci con loro, ovviamente con un outfit del tutto inadatto. Non vi anticipiamo le conseguenze, solo che abbiamo incontrato anche la mascotte del film. Che no, non è un tenero gattino.
E poi Il primo re lo abbiamo visto e abbiamo voluto Borghi e Rovere in redazione, li abbiamo messi uno di fronte all’altro a ripercorrere quell’esperienza folle. Ed è stato fighissimo vederli chiacchierare e tirare fuori aneddoti in esclusiva per noi (vi avvertiamo, si parla anche di copiose quantità di moccio). Inoltre abbiamo chiesto a Marco Giusti di raccontare perché Il primo re è così importante per il cinema italiano, e non solo. Spoiler: lo è, fidatevi.
Lontani dal cinema borghese, fuori dalle borgate romane
di Marco Giusti
La cosa più difficile, come nei film sui cavernicoli o legati al wilderness, è distinguere i nostri eroi, tra barbona, pelliccia, fango e pelo. Almeno distinguere Romolo da Remo. Anche se Remo ha gli occhi inconfondibili di Alessandro Borghi. E poi, alla fine, la storia la conosciamo.
Detto questo, non possiamo che essere fan totali di questo Il primo re, diretto e prodotto da Matteo Rovere, che lo ha scritto con Filippo Gravina e Francesca Manieri, fotografato da Daniele Ciprì, musicato da Andrea Farri, dove ancora una volta, ma non sono così tante, viene rispolverato il mito di Romolo e Remo, anche se qui è più Remo e Romolo. Pesa sui due beauty brothers, cioè Alessandro Borghi e Alessio Lapice, non solo il disegno degli dèi, che vogliono che uno solo dei due fratelli sopravviva per fondare l’impero di Roma, ma la fratellanza stessa, il difendersi uno con l’altro, visto che per oltre metà film Remo lotterà per salvare la vita a Romolo. Cosa che evidentemente si scontrerà con quello che vogliono gli dèi per loro. O forse no. Forse nel disegno stesso degli dèi c’è la forza e la tragedia dei due protagonisti che devono arrivare a questa terribile scelta di perdere un fratello per la grandezza non tanto dell’altro, ma di tutta la stirpe. Come se Romolo e Remo fosse un corpo unico. Al punto che perfino il titolo, Il primo re, non è chiaro se si riferisca a l’uno o all’altro.

Foto Fabio Lovino
Rovere gioca così col mito reinventadosi le regole del mito, gettando i suoi protagonisti in una sorta di marana da peplum trattata come il selvaggio west di Revenant o la giungla di Apocalypto. Spazza via qualsiasi voce da cinema romano e impone un protolatino studiato dai ricercatori della Sapienza che, grazie ai sottotitoli, funziona come nei dialoghi di Gomorra – La serie. Il suo Romolo e Remo, così, si modernizza, si toglie la patina da vecchia storia dei libri di scuola, per prendere quelli del grande cinema d’avventura di oggi. Riprese pericolose, un gruppo di maschi mezzi nudi al freddo. Basta col cinema borghese. Molte cose funzionano, a cominciare da Alessandro Borghi, che domina interamente il film, e da suo fratello, Alessio Lapice, ma funziona anche in gran parte l’impostazione generale. Magari il limite di tutta l’operazione è proprio essersi dati delle regole, a cominciare dal latino, dalle riprese realistiche, ma pochi film hanno osato tanto in questi ultimi tempi come Il primo re che, inoltre, porta avanti un cinema, quello di Rovere, che da anni cerca strade diverse e difficili per esprimersi.
Alessandro Borghi e Matteo Rovere a Rolling Stone
La video intervista (Parte 1)
Il racconto dal set tra trincee, pellicce e alluvioni
di Boris Sollazzo
Manziana, vicino Roma. Fango, tanto. Da critici e cronisti cinematografici diffidenti, ci eravamo illusi di andare sul set di un film italiano in cui, per una volta, non ci si sporca troppo le mani. Perché è quasi sempre così. Figuriamoci se potevamo pensare di insozzarci pure scarpe, pantaloni, persino i capelli. L’inferno di quella che sarà Roma, di Romolo e Remo alla conquista del proprio destino, passa per quell’odore di terra bagnata, per quel paio di scarpe buttate al ritorno a casa perché abbiamo sbagliato l’outfit per venire a spiare alcune scene de Il primo re. Siamo arrivati con un furgone, con ammortizzatori che avevano avuto, un tempo, prestazioni migliori e siamo stati accolti da Borghi. Un abbraccio caloroso, in cui si sentivano tutti i sacrifici del ruolo: la magrezza – «eh sì, ma oggi è il mio compleanno e una fetta di torta me la faccio» –, gli strati di sporcizia che si mischiano a sudore e trucco di scena, una barba alla Giancarlo Giannini dei bei tempi. «Come ho fatto con Stefano Accorsi», ci racconta Matteo Rovere «ho portato un attore molto noto, e molto bello, in un contesto totalmente ignoto. L’ho sporcato, smagrito, costretto a mettersi in discussione. Una star nel fango: Ale ha risposto facendo un lavoro sul suo corpo pazzesco, si è dato al personaggio così tanto che sono convinto che vi dimenticherete di lui e vedrete solo Remo».
Il cineasta romano, reduce dal successo di Veloce come il vento (e produttivamente ha spaziato dalla saga di Smetto quando voglio a Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio), ci tiene subito però a sottolineare che «non è solo il primo kolossal italiano di queste dimensioni, anche di budget, è un’opera sulla fratellanza, su due gemelli che vogliono salvarsi l’un l’altro, sulla disperata ricerca di una casa, è un film sentimentale che va oltre il grande intrattenimento, che pure c’è e abbiamo portato al massimo livello. Più Fitzcarraldo e Valhalla Rising che Revenant, un action più carnale, corporeo, sporco».

Foto Fabio Lovino
Cammino, appena mi consentono di farlo e riesco a metter fuori la testa dalla tenda in cui i monitor ci rimandano le immagini di quelle che diventeranno le scene iniziali. Il villaggio che vedete all’inizio è stato costruito per intero. Vengo accolto da un enorme maiale che grugnisce qualcosa di simile a un tonante rutto: è la mascotte del set, ma anche un elemento fondamentale di quella comunità brutale, affamata. Rischio per un attimo di finire nell’inquadratura della scena che stanno girando, quella in cui i futuri fondatori di Roma e i loro uomini sono stati catturati e condotti al villaggio come schiavi, pronti a essere sacrificati in un barbaro rito di lotta.
Mentre gli parli senti un mix di entusiasmo, determinazione, anche un filo di timore, in questo regista, per l’enormità delle difficoltà affrontate e da affrontare. «La scena che più mi ha terrorizzato? L’esondazione del Tevere, per mezzi, risorse e difficoltà una sfida quasi impossibile».
Niente di simile era stato nemmeno immaginato prima qui da noi. «Stiamo girando in ambienti ostili, dalle paludi alle lande fangose, non è propriamente il classico cinema italiano definito due camere e cucina. Questo più che altro è due boschi e una montagna. Non so se cambierà qualcosa, so che io ho un bisogno patologico di sfide e complessità, di stimolare lo spettatore a prendere strade che non sa di poter percorrere, di vedere film che non immagina di poter chiedere. Potevamo parlarci in un caldo bar dei Parioli» – e freddo e fango mi fanno rimpiangere persino Roma Nord – «sotto al set di una commedia italiana tipica e invece siamo qui, a pochi passi da una palude, a sporcarci di fango, io e te». E a far sporcare le mani al cinema italiano.
Sono colpito, nel percorrere le centinaia di metri del set, dall’accuratezza delle baracche, del campo di battaglia, dei visi di un cast scelto per talento e fisicità, non per sedurre il box office. Casco in una buca dove poco dopo se le daranno di santa ragione, mi perdo a guardare con quanta ossessiva precisione preparino i dettagli di una scena che sullo schermo prenderà solo pochi secondi.
Spio un’altra tenda, in cui ci sono molti costumi del film: apparentemente pelli, stracci. Ma poi, visti sugli attori, scovi il rigore con cui sono stati realizzati. A partire dalla puzza.
Vengo accolto da un enorme maiale che grugnisce qualcosa di simile a un tonante rutto: è la mascotte del set, ma anche un elemento fondamentale di quella comunità brutale, affamata
C’è una concentrazione allegra, su questo set, capisci che la grande avventura la vivono tutti, dentro e fuori al film. Persino il critico che, possiamo confessarlo, dopo quella gita ha dovuto buttare pure i jeans.
Arriva Alessandro Borghi. È il giorno del suo compleanno, ma del divo che conquista tutti si vedono solo gli occhi: è magrissimo, fisico nervoso, ovviamente coperto di fango, ma ha un sussulto. «Stasera niente dieta, solo torta e doccia», ripete, questa volta per tutti. Lo sfottono, da lontano. «Sì, così domani per risporcarti ci vogliono tre ore!». Le vecchie, meravigliose maestranza della vecchia Cinecittà, altro che antica Roma. La verità è che al trucco Borghi, Lapice e la loro tribù passano molto tempo: basta vedere le ferite, i denti distrutti, le unghie massacrate, i giochi di ombre sul corpo per sembrare ancora più emaciati. I ritocchi, dopo che uno dei prigionieri viene picchiato e cade, sono velocissimi e accurati.
Daniele Ciprì sbuca da un’altra capanna – sua è l’incredibile fotografia, è concentratissimo –, mentre Riccardo Tozzi, produttore, viene a salutare tutti. Non si sporca, nell’invidia generale, o almeno ce lo fa credere. La seconda unità, con una macchina a mano, ci guarda di traverso: pensavamo di non aver disturbato, ovviamente non era così.
Rovere, sorridente e affaticato, dice «a 35 anni, dopo tutta questa fatica, chiudo qui! Vado in pensione col botto, è il mio ultimo film!». Ride, immaginando già la prossima follia, prendendo al volo una jeep scassatissima. Lo seguo, affondando miseramente in un fosso in cui poco prima aveva combattuto la sporca dozzina che avrebbe creato Roma. Dal fango, appunto. E la scrofa (ma poi lo è davvero un suino, quel mastodonte scuro?) fa il suo grugnito ruttante: avrà capito che sono un intruso.
Alessandro Borghi e Matteo Rovere a Rolling Stone
La video intervista (Parte 2)