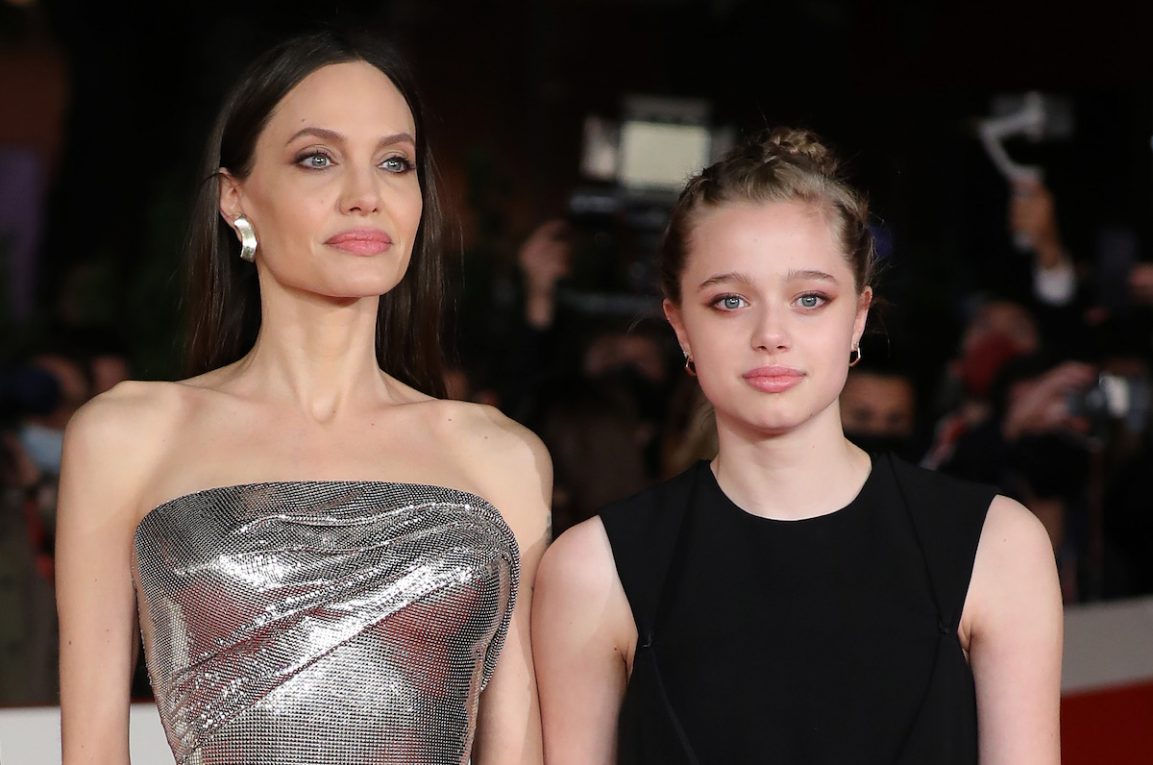Troppe uscite e noi proviamo, da rabdomanti, a mettere ordine. Deludono i big, sanno sorprendere invece i giovani e quelli che sperimentano di più. Fosse così anche la serie A, saremmo ai mondiali.
Smetto quando voglio – Ad Honorem Voto: 8+
E ora che curiosità di vedere Sydney Sibilia fuori dall’universo di Smetto Quando Voglio. Perché siamo di fronte a un cineasta di grande talento, ambizioso, una sorta di spugna creativa che sa metabolizzare l’immaginario moderno del cinema di genere e della serie televisiva per farne un racconto originale e pieno di cambi di campo e ritmo. Smetto quando voglio – Ad Honorem è un gran finale, in tutti i sensi: tanto da nobilitare l’incompreso secondo capitolo, che ne era inevitabilmente propedeutico e propulsivo. C’è più coralità – Edoardo Leo non spicca come in passato -, una sfida tecnica e visiva ancora maggiore (sia pure senza un treno da assaltare), una scrittura serrata e equilibrata tra azione, dramma (quello dei cattivi: che bravi Marcoré e Lo Cascio) e commedia. Commedia all’italiana moderna: non si ride a crepapelle, ma si riflette con ironia e profondità sulla natura di una società ingiusta e opportunista, su una generazione dimenticata – quella che viaggia sui 40 -, su chi ha ancora la forza di ribellarsi anche se la logica gli suggerirebbe di rassegnarsi. Le migliori menti della nostra generazione, ripete ossessivamente Edoardo Leo, uno che il successo l’ha trovato (quasi) fuori tempo massimo e solo perché ci ha creduto nonostante tutto e tutti. Ed è il suo personaggio, motore di tutta la storia (alla fine l’unica certezza di SQV è che qualsiasi cosa sia successa in più di 5 ore di film, è SEMPRE colpa di Pietro Zinni) a dirci che razza di paese siamo. Di come abbia costretto le generazioni più giovani ad essere le kapò di se stesse. La banda – di attori, produttori, regista – deve tornare. Ci sono ancora tanti colpi da fare, tante storie da raccontare e tanta rabbia da rendere sorriso e poesia, ci sono troppi re da denudare. Senza dimenticare che si può essere cialtroni anche citando formule incomprensibili, pensatori raffinati e con quel genio di Peppe Barra, splendido inserto di questo terzo capitolo.
Riccardo va all’inferno Voto: 7,5
Il cinema italiano che preferiamo. Quello folle, sperimentale, inventivo, coraggioso al limite dell’incoscienza, rivoluzionario. Roberta Torre è una maestra indipendente di un cinema da sempre non conforme: non ha mai avuto paura di sbagliare un film (e un paio di volte è successo), ma non ha mai cercato di rifugiarsi in facili certezze. Qua porta in sotterranei barocchi di una periferia romana di cui sentiamo evocare il Tiburtino Terzo e di cui scorgiamo, sulle note de L’inverno del nostro scontento, il Corviale, lo Shakespeare del Riccardo III. Riccardo Mancini, gangster capitolino pazzo, qui, interpretato da un Massimo Ranieri che esplora il suo lato oscuro, che accetta una trasformazione radicale del proprio corpo e che spicca per voce, carisma e talento interpretativo su tutti, illuminando di volta in volta una scenografia e dei costumi tanto belli quanto carichi e una regia generosa, non di rado muscolare, di Roberta Torre. La regista si appoggia a un universo visivo affascinante, al suo protagonista che scala una famiglia di malviventi tra delitti e veleni (veri e non solo) e a una Sonia Bergamasco che in tanti anni ancora non abbiamo saputo apprezzare come merita (ma chi va a teatro, sa). E ancora alla colonna sonora sontuosa di Mauro Pagani, a interpretazioni canore potentissime (Antonella Lo Coco su tutti). Bravissimi i comprimari – grande la coppia Calderoni-Giambanco, ottima la Gallerano, le solite certezze Ragno e Franek – che sono note ben suonate su uno spartito che ha picchi e acuti, cambi di tono e melodia e che adori anche nelle imperfezioni e negli eccessi. Perché questi sono film seminali: di quelli che danno il coraggio ad altri di fare ciò che non conviene, ma ciò che è bello, audace, emozionante. Alla faccia del cinema fighetto, godiamoci questo musica.
L’età imperfetta Voto: 7
Quando arriva un giovane regista che come esordio decide di prendere Il cigno nero e Eva contro Eva per portarlo in una provincia e in un rapporto tra due giovani adolescenti, ti siedi e lo guardi con interesse. Se poi dimostra sicurezza nei suoi mezzi, mani saldi sul timone (leggi macchina da presa) e una bella narrazione allora cominci a sorridere. E’ bravissimo Ulisse Lendaro a offrirci un’opera asciutta ma che non cerca la sottrazione, che tocca sentimenti ed emotività forti senza calcare la mano, che indaga la femminilità acerba di due donne a ridosso della loro linea d’ombra senza banalità né facili scorciatoie. Merito anche di due ottime attrici: Paola Calliari, già apprezzata in The Start Up, ballerina anche nella vita e ottima interprete al cinema, e la sorprendente Marina Occhionero. Con una macchina da presa attenta, presente, mai calligrafica – sa riprendere con efficacia il ballo, come i litigi, senza mai farsi mancare un tocco di sensualità – seguiamo il percorso di crescita e di dolore, di delusione e di scoperta di sé di due giovani che, come tutti coloro che si affacciano alla vita non hanno paura di cadere di sotto. La fotografia, sobria e che sa giocare sulle sfumature, sa farti calare negli interstizi di animi, di rapporti che solo apparentemente sembrano “normali”, con tanti slittamenti che portano Camilla (Marina Occhionero) alla deriva mentre il mondo attorno a sé si scopre inadeguato a gestire i suoi sogni e i suoi incubi. Lendaro gestisce questo slittamento di senso e sensi con maestria, anche grazie a un’ottima scelta degli interpreti secondari: Anita Kravos, capace di incarnare quella pragmatica mediocrità provinciale che genera il sonno della ragione e quindi i mostri, così come Anna Valle, diligente e incisiva in un paio di scene chiave. O quel Diego Pagotto, caratterista sopraffino, che con uno sguardo sa dare una direzione al film. Senza possibilità di ritorno.
Gli eroi del Natale Voto: 6,5
C’è una storia più conosciuta, almeno in Occidente, della Natività? Ci sono personaggi più famosi di Gesù, Giuseppe e Maria? No, appunto. E’ semplice e geniale decidere di tirarla fuori, cambiando la visuale, che diventa quella degli animali: la pecora ribelle Ruth che fugge dal gregge per ritrovarsi al centro della Storia, l’asinello che cerca rifugio in una casa dove c’è un uomo che ha ben altri problemi, i tre cammelli dei Re Magi. Il tutto con ironia elementare, comprensibile al nipote come al bisnonno, con una modernizzazione dei caratteri principali (Giuseppe è un uomo che ha paura di essere inadeguato alla prova che deve affrontare, Maria un teenager volitiva e “femminista”) e un’animazione senza fronzoli. Il risultato è piacevole, divertente e in alcuni momenti anche sorprendente. Niente male, visto che si ispirava a un best seller su cui sembrava essere stato già detto tutto.
Happy End Voto: 6
Haneke, la morte, la vecchiaia, il cinismo e il nichilismo. Cambiano trame e facce (e neanche tutte, la Huppert c’è sempre, qui piace Kassovitz), ma non il piano inclinato di un cinema che rimane in alcune scene straordinario, ma ormai stancamente diretto verso una resa morale, una totale mancanza di speranza nel futuro e un’incapacità di uscire fuori da automatismi visivi e narrativi che si sentono ancora di più quando manca la grandezza delle interpretazioni di Amour e un nucleo emotivo forte. Qui è troppo fragile l’idea di Eve, nipotina che guarda tutto appiattito dal suo cellulare, così come le ganasce di fisicità decadenti o di rapporti slabbrati dall’incapacità di amare ma solo di essere egoisti. Haneke sa regalarci dieci minuti da par suo, poi porta a casa un’opera minore, senza il suo vigoroso seppur glaciale impeto quasi leopardiano verso la società e i suoi centri di gravità permanente, e alla fine si rinchiude, rattrappito, in un’opera non riuscita.
Daddy’s Home 2 Voto: 5,5
Perdonate la sintesi. Vi è piaciuto il primo? Sì? Vuol dire che non avete molte pretese, ma possiamo capirvi. Questo secondo può passare l’esame del vostro non raffinatissimo senso critico anche grazie a un Mel Gibson versione nonno che fortunatamente non è stato cancellato dal cinema pur essendo un pazzo antisemita. Sul set funziona ancora alla grande, soprattutto in un buddy movie doppio e incrociato in cui si raccontano i rapporti padri-figli con dosi di testosterone abbondanti che, si sa, se affidate a buoni attori e a un regista umile, la risata un po’ grassa la strappano sempre. Vi basta? Beati voi.
Amori che non sanno stare al mondo Voto: 4
Una donna femminista attacca un collega anaffettivo e vagamente maschilista a un convegno. Le basta però mangiare insieme per diventare un agnellino: iniziano una relazione che è costellata dalla prudenza comprensibile di lui e le isterie di lei. Lui un giorno arriva pure a denudarsi per strada in una fredda notte d’inverno pur di calmarla. Poi ovviamente capisce che è meglio scappare a gambe levate. Lei diventa una stalker non violenta (forse) poi prova a cambiare sponda con una scelta che se fosse stata maschile ne parleremmo nei talk di prima serata. Ora, sembra una barzelletta o forse la trama di un film erotico, invece è l’ultima opera di una delle migliori registe italiane, Francesca Comencini, che però nei suoi ritratti femminili in melodrammi più o meno moderni, non riesce a trovare la felicità creativa che aveva in passato (e dire che le donne di Gomorra, invece, tutto sono fuorché stereotipate). A questo film manca quasi tutto: un ritmo, una credibilità nelle caratterizzazioni che sembrano uscite da feste di addio al celibato e nubilato, tanto sono piene di stereotipi sessisti da una parte e dell’altra, un equilibrio. Affascinante l’idea di raccontare un modo di amare tipicamente femminile, frutto di una passione insopprimibile e di un’inquietudine naturale (ma esiste davvero? Ed è davvero tipicamente femminile?) ma il risultato è grottesco. E’ un peccato perché Lucia Mascino sa in alcuni momenti catturarti e Thomas Trabacchi interpreta bene il disorientamento un po’ cinico di chi non sa gestire tanto amore: ma anche visivamente sembra di vedere la puntata più importante di una soap un po’ troppo sopra le righe.
E la domanda alla fine è: e se avesse fatto un film del genere un uomo? Non osiamo neanche immaginare il destino che gli sarebbe toccato.
Assassinio sull’Orient Express Voto: 3
Agatha Christie in uno dei suoi capolavori, soprattutto per quel finale che è iconico, geniale, unico, incontrò nel 1974 uno splendido adattamento di Sidney Lumet. Ora, il confronto con quel lungometraggio è quasi ingeneroso: per il cineasta – Lumet contro Branagh è impietoso anche solo a scriverlo – e per il cast. Qui ci sono facce, lì talenti unici. Il punto è che, rivolgendosi questo lavoro a giovani che magari avevano evitato romanzo e predecessore, si poteva portare a casa un lavoro dignitoso: bastava farsi dettare i tempi da Agatha e la struttura da Sidney. Ma Kenneth Branagh è troppo vanitoso e presuntuoso per farlo e, ahinoi, qui non fa solo il regista ma si affida anche il ruolo e i baffi (sic) di Poirot. Il risultato è un’opera dozzinale nelle caratterizzazioni e in riprese, montaggio e fotografia che vorrebbero essere classici e sono invece solo mediocri e piatti, in ruoli secondari ridotti quasi a camei e in un ispettore che dava il meglio (con Finney) come spalla del protagonista di scena in un delicato gioco di equilibri di scrittura e di regia e che qui invece, gigioneggiando, ruba la scena a tutto (treno e paesaggio compreso) e tutti (persino a una Pfeiffer che meritava molto più spazio). La brutta notizia, peraltro, è che è già in produzione Assassinio sul Nilo. P.S.: ah, il doppiaggio italiano peggiora il tutto, se possibile.