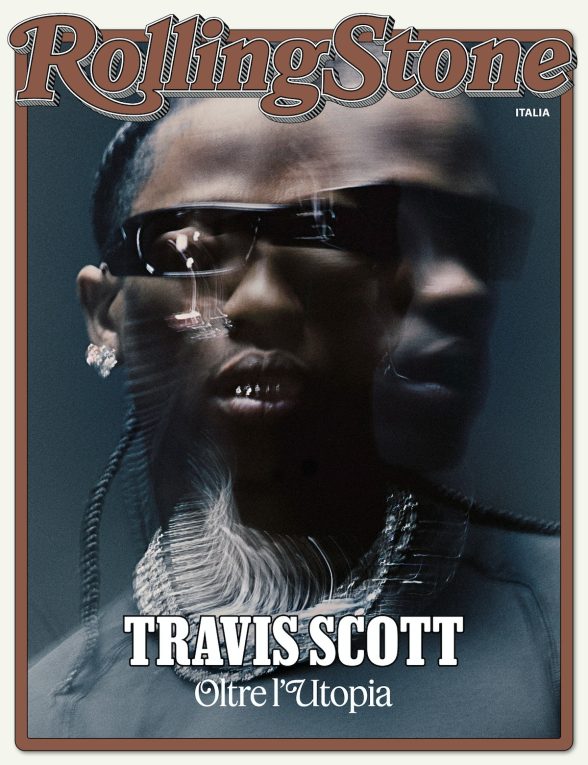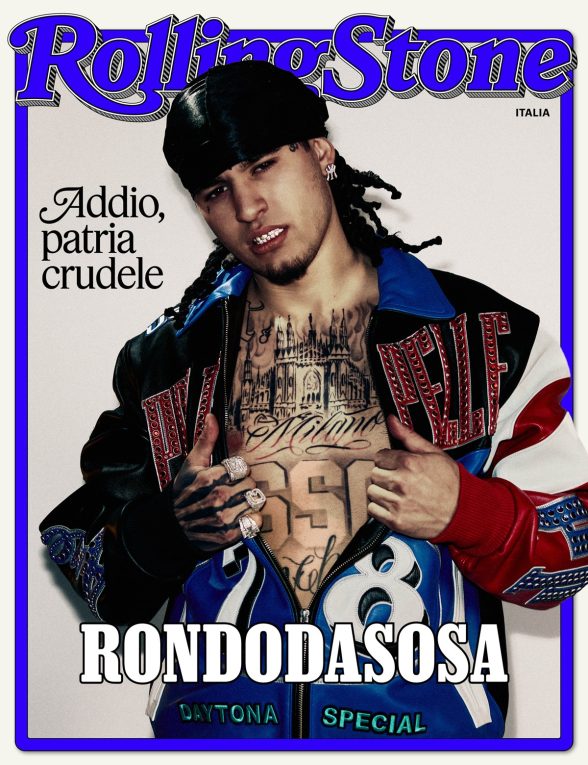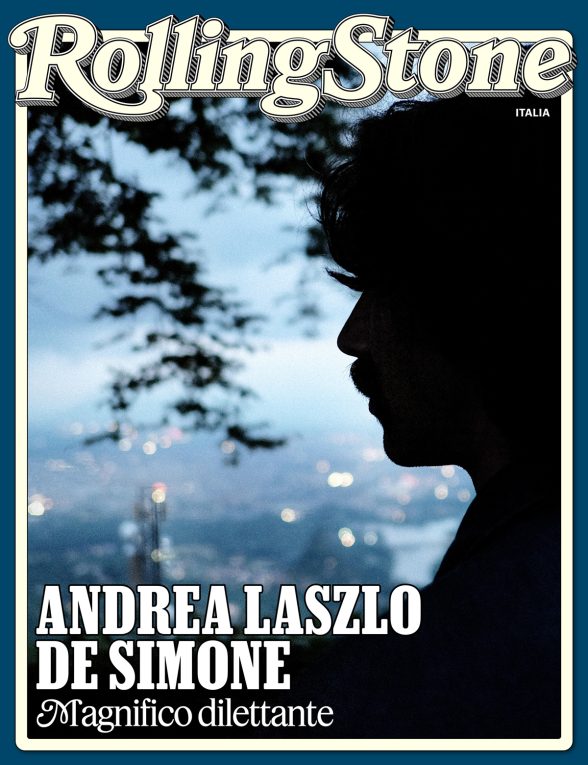Jim Jarmusch: «A modo mio»
Una chiacchierata tra caffè doppi, Tom Waits e Wu-Tang Clan per attraversare il suo nuovo film, 'Father Mother Sister Brother', e un’idea di cinema che toglie tutto il superfluo e lascia spazio al tempo, ai gesti, alle relazioni
Foto: Carole Bethuel
Joe Strummer che qualche settimana prima di morire gli disse: “Non dimenticare, il nostro compito è proteggere l’empatia a ogni costo e vivere vite fighissime”, e che è diventato il manifesto di vita del regista. Ma anche le bevute con i Wu-Tang Clan dietro le quinte del loro concerto newyorkese. E poi 40 anni di avventure pazzissime con l’immancabile Tom Waits. Ho passato poco meno di mezz’oretta con Jim Jarmusch e mi pare di essermi fatta un’overdose di coolness e di umanità.
Siamo a Venezia 82, il giorno dopo la proiezione per la stampa (e quindi ben prima del Leone d’oro che sarebbe arrivato di lì a una settimana), e questa è una delle primissime interviste in cui il poeta degli outsider, maestro di minimalismo dentro e fuori dallo schermo, portatore sanissimo di malinconia e deadpan humor, parla del suo nuovo film Father Mother Sister Brother (al cinema dal 18 dicembre con Lucky Red), un pezzo di cinema jarmuschiano in purezza, un lessico familiare teneramente disfunzionale in forma di antologia, tre storie autonome che si osservano, si rispecchiano e si accumulano, fino a diventare un’unica esperienza, emotiva e non solo.
Jim è puntualissimo. Look total black a contrasto con la poltrona bianca su cui è seduto in una lounge del Lido, occhiali da sole scurissimi che ne nascondono lo sguardo («assonnato», dice lui) e il ciuffo candido che è diventato firma, chiede con una cortesia che non ha nulla di costruito un altro caffè («espresso!») doppio («double!») per «combattere il jet-lag».
Il caffè arriva: «Grazie! Grazie!». Possiamo cominciare.
Il titolo Father Mother Sister Brother sembra quasi un mantra, o forse una preghiera. Era quello che volevi?
No, in realtà ho avuto un problema col titolo, perché di solito mi piacciono quelli poetici. Only Lovers Left Alive (Solo gli amanti sopravvivono), roba del genere. E questo invece… il titolo provvisorio era semplicemente Father Mother Sister Brother. Poi, una volta fatto il film, non riuscivo a pensare a nulla di più appropriato. Mi sono detto: “Be’, è proprio questo, no?”. Sono tre capitoli, quindi, ok, quello è il titolo. Non so, non è tra i miei preferiti.
Però ti rimane in testa.
E soprattutto non avrei proprio saputo come altro chiamarlo… (ridiamo)
Nei tuoi film spesso hai parlato della famiglia che ti scegli, outsider, vagabondi, coppie bizzarre. Qui invece affronti proprio la questione di petto. C’è qualcosa che ti ha spaventato e qualcosa che invece ti ha fatto ridere?
È stato un film interessante da girare perché ero molto, molto concentrato. Tornavo a casa la sera distrutto, non per scene d’azione o fisiche, ma perché passavo ore a studiare il movimento di una mano, di una palpebra, di uno sguardo, di un gesto. È più faticoso che avere degli zombie che ti assaltano, capisci? (ridiamo) Non è stato fisicamente estenuante, perché stavamo sempre nello stesso posto, ma mi stancava l’attenzione ai dettagli. Non è stato spaventoso, ma sì, interessante: cercare di tradurre quello che avevo in testa sullo schermo con dei collaboratori meravigliosi, molto vicino a come lo avevo immaginato.

Vicky Krieps, Cate Blanchett e Charlotte Rampling in ‘Father Mother Sister Brother’. Foto: Yorick Le Saux
È un trittico, eppure sembra davvero un unico film, anche grazie a dei piccoli dettagli che hai intrecciato nelle storie: gli abiti coordinati, la battuta “Bob’s your uncle”, i brindisi, e in ogni capitolo qualcuno ha un Rolex…
Li metto soprattutto per divertirmi io. Ma ho lavorato davvero tanto per rendere il film un’esperienza cumulativa. Se qualcuno mostrasse un episodio da solo, ne sarei mortificato, perché cancellerebbe tutto il mio lavoro. Il terzo capitolo non funzionerebbe emotivamente senza gli altri due, in quell’ordine preciso.
Permettimi la metafora: è un po’ come un concept album?
Forse sì, per via di quell’accumulo, dei richiami interni. Un concept album da ascoltare dall’inizio alla fine, senza saltare un pezzo. Ho lavorato tanto su questo, e nel finale ho come liberato tutto.
Father Mother Sister Brother è una continuazione della tua meditazione sulla mortalità da Paterson e Only Lovers Left Alive? Perché è come se il film dicesse: i genitori magari sono inadeguati, imbarazzanti o freddi, ma quando non ci sono più mancano e rimandiamo il momento di fare i conti con la loro assenza. Era questo che volevi catturare?
Forse sì. Non analizzo molto, e non so nemmeno da dove sia venuto fuori questo film. Ho perso entrambi i miei genitori, ma non stavo pensando ossessivamente a questo, alla mortalità o alla famiglia. Pensavo piuttosto: “E se Tom Waits fosse il padre di Adam Driver e Mayim Bialik, che sono dei tipi un po’ inquadrati, e lui invece fosse un bohemien recluso?”. Mi sembrava interessante. E se la madre del secondo capitolo fosse Charlotte Rampling? Non lo so. Ho scritto la sceneggiatura in tre settimane, è stato tutto velocissimo. Non so nemmeno io da dove sia arrivata.
L’hai definito un anti-action.
Sì, quello nasce perché mi hanno chiesto di scrivere qualcosa per presentare il film. E me ne sono reso conto solo dopo averlo fatto: aspetta un attimo, qui non c’è azione, non c’è dramma, non c’è sesso o nudità, non c’è nessuna di quelle cose che la gente si aspetta da un film. E allora ho pensato: “Oh, cavolo, ho eliminato tutto ciò che di solito ci si aspetta”. Ma in realtà è proprio la natura del film: non vuole, e non ha bisogno, di nessuna di quelle cose. È semplicemente un’osservazione dei personaggi, senza giudicarli.
Si capisce che è un tuo film anche solo dal cast: Tom Waits, Adam Driver…
I miei attori sono stati tutti straordinari. È una gioia lavorare con loro, ognuno ha un suo stile. Ti faccio un esempio. Eravamo al primo giorno di riprese. Adam e Mayim scherzano e sono assolutamente flessibili, ma anche sono molto precisi, rigorosi. Tom no. Alla fine della giornata lui mi ha preso da parte: “Jim, hai ingaggiato due killer professionisti. E io che faccio?”. Gli ho risposto: “Tom, tu fai a modo tuo. Sono io la tua guida, andrà benissimo”. E ha funzionato. Gli altri seguivano la sceneggiatura parola per parola, Tom improvvisava. E alla fine tutto si incastrava.
Lavori con Tom dai tempi di Daunbailò.
Sì, abbiamo fatto cinque film insieme.
Hai scritto questa parte apposta per lui?
Sì, assolutamente. Per lui, per Adam, per Mayim. E anche per Charlotte [Rampling], Cate [Blanchett], Vicky [Krieps] e per Luka [Sabbat] e Indya [Moore]. Avevo già lavorato con loro due e mi sono immaginato subito che fossero gemelli. Proprio come nella terza storia di Father Mother Sister Brother, mia madre aveva un gemello che si chiamava Bob. Erano legatissimi, quasi telepatici: squillava il telefono e lei sapeva già chi era. E anche mio padre si chiamava Bob. Quindi a Natale c’era sempre questo: “Dov’è lo zio Bob?”, “Il tuo o il mio?”. Poi quando ho passato del tempo in Inghilterra con alcuni miei amici del giro rock’n’roll e sentivo dire continuamente “Bob’s your uncle”, che in pratica vuol dire “et voilà” , mi faceva ridere da morire perché in America non l’avevo mai sentito. E l’ho infilato nel film.

Tom Waits in ‘Father Mother Sister Brother’. Foto: Frederick Elmes
Tom ormai fa parte del tuo cinema da quasi quarant’anni.
Siamo molto amici e condividiamo ispirazioni e passioni. Amo Tom perché usa il linguaggio in un modo unico. Fa le interviste migliori del mondo perché non risponde mai alla domanda. Gli chiedi: “Da dove viene l’ispirazione per questo disco?”, e lui: “Sai che a Las Vegas vive una colonia di ratti albini?”. È così, è sé stesso. E poi con lui ho vissuto mille avventure strane, veri e propri regali della vita.
Raccontami la più bella.
Ce ne sono troppe! Te ne dico una: durante Daunbailò avevamo preso in prestito una Jaguar nuova fiammante per il film. La sera Tom diceva: “Jim, andiamo a prendere le chiavi nell’ufficio produzione e facciamoci un giro a New Orleans”. È successo per tre notti di fila. Nell’auto c’era una sola cassetta: Julie London che cantava Cry Me a River. Alla terza sera gli ho detto: “Tom, ascoltiamo solo Julie London, è l’unica musica che abbiamo”. E lui: “Be’, cos’altro ti serve, amico?”.
Ok, se ne avessi un’altra adorerei.
Una volta Tom aveva questa macchina nel Nord della California, una El Camino. È una specie di pick up. E sua moglie voleva che andassimo a recuperare questa gigantesca ruota di carro da mezza tonnellata da un tizio. Non so come, ma con un po’ di aiuto siamo riusciti a caricarla dietro. Partiamo, ma il peso era troppo. A un certo punto gli faccio: “Tom, esce un sacco di fumo da dietro”. Guidiamo ancora un po’ e le gomme posteriori prendono letteralmente fuoco. Non so come sia successo. Allora ci fermiamo: lì vicino c’era un uomo che annaffiava il prato con una canna. Tom gliela strappa dalle mani e la usa per spegnere le gomme, che nel frattempo esplodono.
Dalle esplosioni al passaggio di uno skateboard, che nel tuo film diventa un momento di pura poesia…
Io amo gli skater. Sono anarchici, selvaggi, liberi. Nel film è come quando alzi lo sguardo e vedi un volo di uccelli. Non ha una motivazione narrativa, non serve alla storia. È solo una deviazione poetica. Ho anche usato il ralenti, ed è l’unico effetto che ho utilizzato. È un piccolo tributo da parte mia agli skater. Una volta a New York due skater mi hanno fermato: “Ehi, fai film tu?”. Io: “Sì”. E loro: “Sei David Lynch, vero?”. Io: “No, non sono David Lynch”, e ho continuato a camminare. Poco dopo mi hanno fermato ancora: “Ok, se sei David Lynch e non vuoi ammetterlo, sappi solo che ci piacciono molto i tuoi film”. E se ne sono andati. Mi hanno fatto ridere per giorni. Pazzissimi skater.
I tuoi film sono più che storie, sono una vibe: cinema minimale, outsider, malinconia, umorismo impassibile, musica. Quanto costruisci consapevolmente questa atmosfera e quanto ti viene naturale?
Costruisco tutto in modo consapevole, ma non con l’intenzione che sia “mio”. È solo il mio ritmo naturale, il mio modo di parlare, di pensare. Non provo a fare film in stili diversi. Però sto molto attento al ritmo dei miei film. Conosco altri registi che invece cambiano stile continuamente e mi colpisce sempre: come fanno? Per esempio Mika Kaurismäki, il fratello di Aki, sa fare film in stili molto diversi, oppure Steven Soderbergh che riesce a passare da un registro all’altro, ha una mano incredibile. Mi fa impressione, perché io non potrei mai: sto ancora cercando di capire come fare le cose a modo mio. E ogni volta imparo un po’ di più.
E come riesci a restare così meravigliosamente indie in un panorama in cui il mainstream sembra inghiottire tutto?
Sono testardo. Devo farlo a modo mio. Totale controllo creativo: scelgo i miei collaboratori, nessuno interferisce. O così o niente, perché la vita è breve. Non lo faccio per i soldi, non voglio essere un regista di Hollywood. Voglio solo fare cinema, che per me è una delle cose più belle che gli esseri umani abbiano mai creato. Non mi interessano tutte le altre cose del “mondo del cinema”. Io cerco solo di imparare a modo mio, e ho un rispetto profondo per i film che amo, sin dagli inizi del cinema. Amo moltissimo i film muti. A un certo punto, a metà-fine anni Venti, erano diventati incredibilmente sofisticati. Straordinari. Quindi non so. Non voglio ripetermi, ma lo faccio davvero a modo mio. Lo faccio perché lo amo. Sono un dilettante, e va bene così: amateur vuol dire che lo fai per amore.
Ricordi il primo film che ti ha fatto pensare: “Ecco, voglio fare questo nella vita”?
Non proprio, ma da bambino vidi quasi per caso Thunder Road (Il contrabbandiere) con Robert Mitchum. Automobili veloci, criminali, violenza: wow! Prima avevo visto solo Bambi, capisci? Fu uno shock. Poi a vent’anni andai a studiare a Parigi, dove passavo le giornate alla Cinémathèque: film indiani, giapponesi, italiani, Hollywood classica. Mi si è aperto un mondo. Da allora non ho più smesso. Ancora oggi guardo un film al giorno.
Segui il cinema italiano? C’è qualcosa che ti piace?
Sì, lo amo. Di recente Roberto [Benigni] mi ha detto: “Non hai mai visto Io la conoscevo bene?”. E allora l’ho recuperato. Folgorante, imperdibile. Poi, certo, conosco Sorrentino, Garrone… mi piacciono le loro voci, diverse e profondamente italiane. Sono uniche. Qualcuno mi ha detto: a Venezia sei in concorso “contro” Sorrentino, ma a me non interessa la competizione. Va bene perché è utile per la distribuzione dei film, per come vengono presentati. Ma competere? Davvero, è ridicolo. È come se andassimo tutti insieme in un museo e poi dovessimo scegliere collettivamente il miglior quadro. E poi il miglior pittore. Dài, è assurdo. È per questo che ho sempre rifiutato di far parte di una giuria quando mi è stato chiesto.

Luka Sabbat e Indya Moore in ‘Father Mother Sister Brother’. Foto: Carole Bethuel
Senti ancora Benigni?
Certo! Ci siamo visti di recente a Bologna: io avevo un concerto lì e lui è venuto a trovarmi con Nicoletta. E poi parliamo ancora al telefono, quasi sempre una volta al mese, di solito la domenica. È diventato un appuntamento, non sempre preciso, ma è una benedizione, davvero. Le cose che mi racconta, i progetti a cui sta lavorando o che sta immaginando… È il migliore, così divertente e generoso. E siamo ancora molto uniti, sì. Adoro Bob, come lo chiamavamo sul set di Daunbailò. Oppure per me anche “Robertino”.
Che posto ha la musica nella tua vita in questo momento?
La musica è sempre la mia prima ispirazione. Amo il cinema, ma la musica è la cosa più pura in assoluto. Ieri notte, mentre non riuscivo a dormire, pensavo a come non esistano giovani gruppi musicali che promuovono il totalitarismo, anche se sta dilagando nel mondo. Forse ci sono band hardcore naziste in Germania, ma non contano nulla. Quindi la musica resta una cosa pura. È una guida all’empatia, in un certo senso. Amo tutti i generi, dall’hip-hop underground al jazz d’avanguardia, dal reggae all’elettronica. Tutto, tranne gli show tunes, non sono la mia cosa. Bob Marley diceva: “Una cosa bella della musica è che quando ti colpisce non senti dolore”. La musica è la cosa più bella che facciamo come esseri umani. E non serve nemmeno capirla, comprendere le parole: arriva lo stesso.
A proposito, perché hai scelto Spooky di Dusty Springfield come tema del film?
Colonna sonora a parte, è l’unica canzone che ho comprato per il film. All’inizio c’è una cover (di Anika, che ha scritto con lui le musiche, nda), ma poi arriva Dusty, che è incredibile. A Parigi avevo una crew francese composta in gran parte da donne e sono le migliori con cui abbia mai lavorato. Andavo sul set in macchina con una giovane autista francese e le chiedevo mettere dei pezzi che le piacessero. Un giorno è partita Spooky. Le ho detto: “Questa è una delle mie canzoni preferite di sempre”. E lei: “Anche per me”. Poi ho pensato che nel film, nella macchina, il brano preferito della madre dei gemelli dovesse essere Spooky. Così l’ho scritto in sceneggiatura. Non era previsto. È nato per caso, ma dava al film una vibrazione pop che mi piaceva.
Che cosa stai ascoltando in questo periodo?
Ascolto davvero di tutto. Sono molto affasciato dalle voci femminili. Nel rock and roll, per esempio, mi piacciono Devon Ross, Courtney Barnett… E di recente sono andato all’ultimo concerto dei Wu-Tang a New York, al Madison Square Garden. Siamo amici (e infatti c’è un bell’Easter Egg nel film, nda), è stato come essere in una navicella spaziale che sollevava tutta New York. L’energia positiva dei Wu-Tang è incredibile, sono intellettuali, ma non troppo perfezionati dall’educazione classica. Sono brillanti e anche molto generosi, molto affettuosi. Dopo il concerto stavo con loro nel backstage e mi hanno dato da bere del mezcal. Poi: “Yo, mettici dentro un po’ di brown Wu juice”. Non ho la minima idea di cosa fosse quel brown Wu juice. Ma sono a malapena riuscito a tornare a casa.