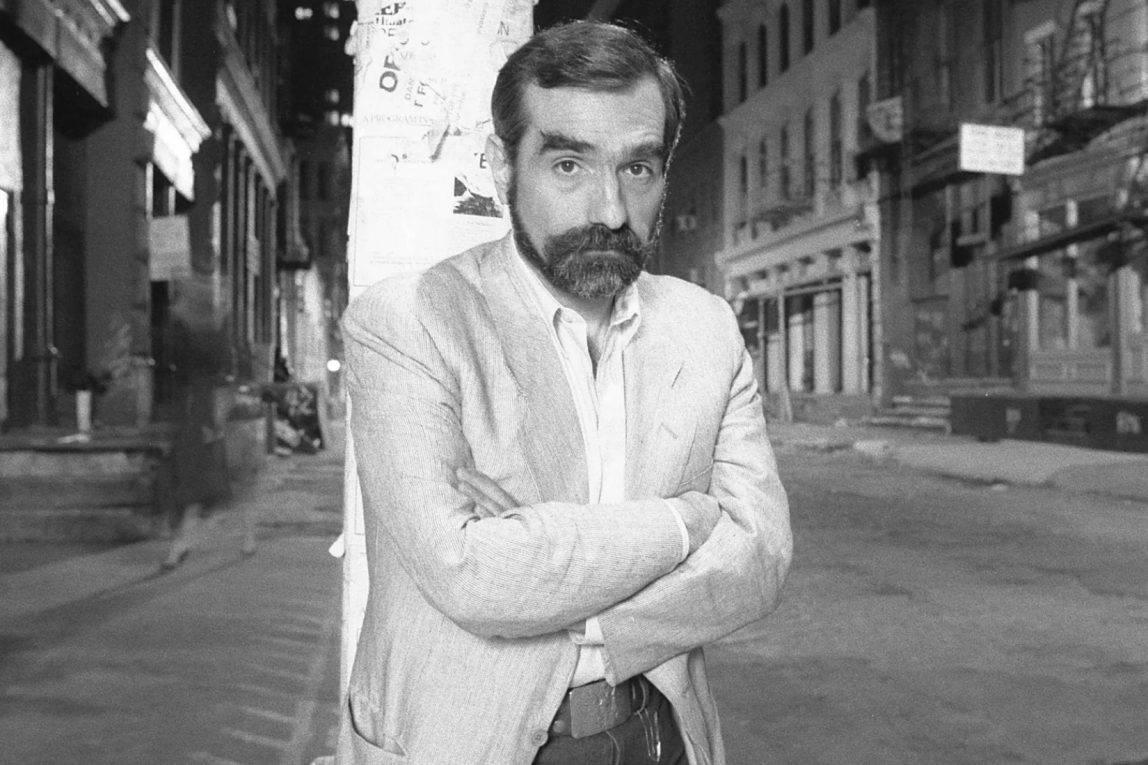«Il Doge è morto». E lo dice senza abbassare la voce, come se stesse mettendo un punto definitivo alla sua esistenza precedente. «Non rimane Giampaolo Manca, rimane Gianni». Non è una battuta, ma un ritorno alle origini. Prima del soprannome da mito criminale e della narrazione che ha trasformato la sua storia in una leggenda nera. Ora è tornato alla leggerezza del ragazzo «rompicoglioni ma che non andava oltre i furti». Poco prima, in pratica, della trasformazione da bandito a criminale che gli è costata una permanenza in carcere per ben 36 anni, 8 mesi e 2 giorni: «Dopo aver espiato la pena, non devo più niente a nessuno». Il conto, però, non è ancora chiuso: «Sto bene con me stesso, ma convivo con dei rimorsi enormi».
Ci incontriamo a pranzo al Ristorante Latterie 1952, Milano. L’occasione è l’uscita del documentario Il Doge – Un ritratto della redenzione, realizzato dalla regista canadese, e sua attuale compagna, Gianna Isabella Magliocco, in tournée nei cinema da gennaio e febbraio 2026 in Veneto e poi a livello nazionale. Nella pellicola viene ripercorsa «la vita nella vita» all’interno della Mala del Brenta – o, come preferisce definirla lui, «nelle varie bande» che misero a ferro e fuoco il Nord Est tra gli anni ’70 e ’90 – e che è stata ratificata come mafia dalle sentenze «grazie alle balle di Felice Maniero». Un racconto crudo, in bianco e nero, che non edulcora nulla del male attraversato, ma dove, in fondo al tunnel, c’è una luce. Ricorda le violenze subite e inflitte, le celle «con i topi che spuntano dai bagni», lo Stato di diritto che, in un clima da guerra civile, chiudeva un occhio sulla «tortura all’ordine del giorno», le regole spietate delle organizzazioni criminali: «Si moriva per i sospetti».
Non manca il mito di Silvano “Kociss” Maistrello, “l’ultimo bandito”, che «saltava da un tetto all’altro di venti metri» e che distribuiva parte della refurtiva ai più poveri. È lì che nasce l’epica: i furti a raffica nelle banche, la ribellione come droga, prima che arrivasse quella vera. Poi il salto di scala con il traffico di stupefacenti, che indica come il momento di non ritorno anche se guadagnava 700 milioni di lire al mese. Soldi che non danno soddisfazione: «Rimaneva l’adrenalina delle azioni criminali». Il resto, sottolinea, «era una malattia».
Ancora i conti aperti con Felice Maniero, in un conflitto ormai più simbolico che reale. Infatti, se lo incontrasse oggi non avrebbe nessuna reazione: «A cosa servirebbe ucciderlo? Mi ridarebbe gli anni che ho passato in galera?». Poi Renato Vallanzasca, con cui ha condiviso anni di detenzione e che gli faceva assaggiare «la cassœula della sua mammetta»; le Brigate Rosse, incontrate quando venne classificato come detenuto politico e che paragona «a guerrieri giapponesi che, anche dopo che era finita la guerra, non uscivano più dalla foresta»; i camorristi legati a Raffaele Cutolo che finirono per proteggerlo, perché Fabio, il fratello gemello amatissimo («per lui sono cambiato»), era diventato amico della sorella del boss, Rosetta.
Il passato, però, non è qualcosa di sepolto per sempre. O almeno, non per tutti. Appena uscito dal carcere, nel 2018, rivela di essere stato cercato da vecchi sodali decisi a regolare i conti: «Ho capito che quella persona era venuta per uccidermi». La scelta di non reagire, né con la vendetta né con la delazione, lo riporta paradossalmente dalla parte dello Stato: quelle persone finiscono di nuovo dentro. Come Maritan, che vede alla finestra della cella quando organizza i tour per Venezia: «Silvano, hai rotto i coglioni, vuoi davvero morire lì dentro?». Il suo presente, invece, è un altro. Parlare ai ragazzi, senza sconti né retorica: «Nelle scuole dico: vuoi metterti a uccidere la gente? Le alternative sono due: o vai in galera o vieni ammazzato». E il futuro è nella raccolta fondi, con tutti i suoi progetti, per l’associazione Alphabeta: «Voglio morire quando la mia casa sarà pronta ad accogliere questi ragazzi, per aiutare chi ha figli autistici dopo che loro non ci saranno più».

Il poster del documentario ‘Il Doge – Un ritratto della redenzione’. Foto: press
Il primo aspetto che stupisce del documentario è che metti subito in chiaro: «Il Doge è morto». Rimane Giampaolo Manca?
L’ho rimosso, ma non rimane neanche Giampaolo Manca, ma Gianni. Perché il Gianni ragazzino, che era di certo un rompicoglioni, era un tipo vispo ma che non andava ancora oltre.
Perché il diminutivo Gianni?
Avevo 14 anni, sono andato in Comune a Venezia e non vedevo l’ora di avere la carta d’identità. Ho chiesto di poter scrivere sul documento “Gianni”, ma il funzionario ha rifiutato: «O Giovanni o Giampaolo», ha risposto. Giovanni era mio padre, con il quale ho avuto non pochi conflitti, come si vede nel documentario, così ho optato per Giampaolo.
Quanto è stato difficile sbarazzarsi del Doge? Immagino abbiano contribuito i 36 anni, 8 mesi e 2 giorni di carcere. Ma è solo grazie all’espiazione della pena?
È stata una liberazione, anche dal punto di vista umano, dopo tutto quello che con quel soprannome avevo fatto di male. Ma voglio essere sincero. Tutti sanno quanto mi identifico con la mia città, Venezia, e quindi mi piacerebbe, se possibile, mantenere il soprannome Il Doge, ma che fosse Il Doge buono. L’altro lato di questo personaggio, quello che dimostro oggi in varie forme. Vuoi o non vuoi ci sono tantissime persone, in particolare giovani, che mi vedono come un simbolo.
In quel periodo, tra gli anni ’70 e ’90, era più facile prendere una brutta strada?
Erano stagioni di ribellione, anche a livello studentesco. Io ero vicino ai militanti di sinistra. Mio padre e mia madre, invece, erano di destra. Mia mamma, con orgoglio, ricordava: «Ho dormito a casa di Benito Mussolini». Forse certe cose le ho fatte per ribellione, almeno all’inizio.
Come mai tua madre ha dormito a casa di Mussolini?
Era una vedova di guerra. Il suo primo marito era un soldato in carriera e sono stati ospiti a Salò di Mussolini. Per loro, che hanno vissuto tutto il Ventennio, era un onore. Pensa che anni dopo, mentre ero ricercato dalla polizia, decido di portare mia madre con me. Anche lei era ricercata. Avevo una villa al Lago di Garda e, ad un certo punto, mi dice: «Amore, ti me fa un piaser?». E io: «Dime mamma». La sua richiesta: «Ti me porti a Salò?». Voleva tornare a vedere dove aveva dormito a casa del Duce. L’ho accompagnata e la conosceva a memoria.
Dicevi che tanti ragazzi oggi ti vedono come un simbolo.
Sai cosa mi è successo qualche giorno fa? Giro per la città, passa un ragazzo in moto, mi guarda, mi riconosce, e per salutarmi va a sbattere. Oppure, un’altra volta, un amico comune mi blocca: «C’è una persona che ti vuole conoscere». Sai chi era? Sabrina Salerno. Ha detto che la mia storia l’ha fatta impazzire. Alla fine siamo rimasti un’ora e mezza a parlare.
Tutta questa popolarità, che deriva da esperienze molto negative, è anche una responsabilità oggi?
Nella maniera più stupenda e sorprendente. Ho fatto dei podcast dove, mi hanno detto, ho raggiunto 50 milioni di visualizzazioni. Neanche fossi una bella donna… Il merito è tutto suo (si riferisce alla compagna e regista, nda). A parte questo è vero, sento di avere una responsabilità enorme. Quando vado nelle scuole e parlo con i ragazzi mi ascoltano, molto più di tanti professori, perché sanno che parlo di cose che conosco e che ho pagato.
La regista e compagna è al suo fianco, non lo molla un attimo e lo sostiene con sguardi teneri e sorrisi di complicità: «Ho passato un anno a cercare i migliori canali per far conoscere la sua storia e ho individuato quelli che mi sembravano più forti per arrivare a tutti, in particolare ai più giovani. Ora ci fa impressione il ritorno che abbiamo avuto».

Gianna Isabella Magliocco e Giampaolo Manca. Foto: Joel Varjassy
La tua storia parte grazie a Silvano Maistrello, detto “Kociss”, una leggenda della Mala veneziana e considerato “l’ultimo bandito”. Anche nel documentario, quando ricordi com’è morto, è forse la parte in cui sei più commosso.
Ero più piccolo di Silvano, e da quando l’ho conosciuto la mia vita è cambiata. In città era considerato “il figlio di puttana”, perché sua madre, per dargli da mangiare e non per vivere nel lusso, faceva qualsiasi cosa. Erano in nove fratelli. Solo per ricordare un aneddoto, lui odiava la cioccolata. Voleva quella al latte, non quella fondente. Perché quella fondente la associava al cioccolato che i militari americani, nel Dopoguerra, regalavano a sua madre dopo averne approfittato. Ha passato le pene dell’inferno per tutte le botte che ha preso da piccolo. Invece di picchiarlo, avrebbero dovuto dargli da mangiare. Ma allora c’era la guerra dei poveri. Alcuni di quelli che lo picchiavano sono ancora in giro, sono sopra gli ottant’anni.
Perché “Kociss” ha lasciato un segno così importante?
Era l’unico ad avere il coraggio di saltare da un tetto all’altro, anche di venti metri, senza la corda. Noi spesso lo mettevamo in guardia che avrebbe potuto cadere. E lui: «Mi casco?». Era un gatto e aveva una forza incredibile nelle mani. E in più una tecnica tutta sua: usava, oltre alle dita d’acciaio, i gomiti e il colpo di reni per arrampicarsi su qualsiasi parete.
Distribuiva anche parte della refurtiva con le famiglie povere, giusto?
Certo, sapevamo chi erano i più poveri e non vedevamo l’ora di andare a rubare per portare gli sghei a quella gente. Ho avuto tanti soldi nella mia vita, ma non mi sono mai sentito un signore come quando, con “Kociss”, andavamo a rubare anche per la gente che era in difficoltà. Sai, io non ho una grande considerazione per i ricchi, salvo qualche eccezione.
Poi da bandito diventi un criminale e arrivi a guadagnare, grazie al controllo della droga e delle bische, 700 milioni di lire al mese. Come si spendono tanti soldi?
Non ho mai fatto i conti delle spese. Ma tutte le cose più effimere che c’erano in circolazione le compravo, come trenta o quaranta maglioni di cachemire alla volta. La polizia veniva a saperlo, mi chiamava e diceva che avevo fatto qualche rapina. Ma a quell’epoca c’erano già i soldi della droga e dei casinò, non avevamo bisogno di fare altre rapine. Il problema è che, dopo un po’, non c’è niente che ti dia più soddisfazione. Infatti, nel tempo, ho capito che era una malattia. Quella che rimaneva è l’adrenalina delle azioni criminali, il resto passa in secondo piano.
Com’era il rapporto con le forze dell’ordine?
Noi disprezzavamo chi faceva il doppio gioco. Ci servivano anche le forze dell’ordine a libro paga o infedeli, ma, a livello ideale, preferivamo uno che non tradiva i suoi compagni. Meglio sapere che una persona può spararti addosso di fronte, che quando sei di spalle.
Quando hai rischiato di più di morire?
Nel periodo in cui abbiamo fatto quindici rapine in Friuli-Venezia Giulia nelle banche. Finite queste, tornano i complici e mi chiedono di farne un’altra. Ma se abbiamo una valanga di sghei, gli rispondo! Loro insistono, dicono che è tutto già pronto, insomma non ci vuole tanto per convincermi. Partiamo al mattino, arriviamo e entriamo in banca. Non c’era nessuno in giro, solo i commessi. C’era qualcosa di strano. Apriamo la cassaforte, prendiamo i soldi, usciamo, io chiudo la porta e appena l’ho chiusa iniziano a spararci addosso. Sul Comune si erano appostati i carabinieri. Non ho neanche avuto il tempo di pensare a cosa stava succedendo. Mi prendono, mi buttano in una stanza e arriva un anziano con un badile in mano e mi colpisce in faccia.
Non era qualcuno delle forze dell’ordine?
No, era un cittadino del posto indignato per la rapina. Gli dico: «Pezzo di merda, i soldi sono assicurati». Tanto che devono intervenire i carabinieri per non farmi linciare. Ma non per salvarmi, perché poi, una volta buttato dentro la volante, me ne hanno date anche loro per farmi confessare tutto. Mi hanno massacrato anche in caserma. È dovuto intervenire un maresciallo, che sapeva chi ero, per dirgli: «Ma questo non vi dirà mai niente, neanche se lo ammazzate». Poi mi hanno portato in un campo, per terrorizzarmi, e hanno fatto la roulette russa.
Usavano metodi piuttosto spicci.
Era il periodo delle stragi, c’era la guerra civile in Italia. E la guerra, se la combatti, la devi combattere con tutti i mezzi che hai a disposizione. Per i diritti, anche dei detenuti, non c’era più posto. Figurati per i criminali e i brigatisti, infatti la tortura era all’ordine del giorno.
Felice Maniero, sul quale torneremo, ha detto che in Veneto le altre mafie non avevano accesso «perché avevamo un arsenale», che lui aveva acquistato dopo la caduta dell’ex Jugoslavia. Era solo per una questione militare?
Maniero è un buffone, non è vero! Secondo te quelli del Sud non avevano gli arsenali? Era un fatto di rispetto reciproco. Per alcuni che si erano messi in testa di venire in Veneto, ci sono stati altri, che conoscevano l’ambiente, che li avevano messi in guardia: «Se andate là morite».
Come eravate organizzati?
C’erano tante bande, non una sola. Partecipavano dei personaggi, che non voglio citare perché non so come sono messi con i loro processi, che solo a pensare potessero prendere ordini da Maniero mi viene da ridere. Se Felice si fosse permesso di provare a comandarli, gli avrebbero staccato la testa dal collo con le loro mani. Sai, in certi ambienti si moriva anche solo per i sospetti.

Giampaolo Manca nel documentario ‘Il Doge – Un ritratto della redenzione’. Foto: press
Perché Maniero è passato alla storia come il boss della Mala del Brenta?
Maniero conosceva tanta gente, come la conoscevo io, ma lui, una volta arrestato, ha detto: tiro fuori tutto quello che ho fatto con tutta questa gente coinvolta e la faccio diventare la mia “banda”. Lo giuro sulla vita delle persone che ho più care al mondo: non è vero che eravamo un’unica organizzazione, men che meno una mafia. Maniero è furbo, scaltro, audace, ma la storia della Mala del Brenta è una sua costruzione per non fare il carcere. Se i collaboratori di giustizia raccontassero la verità, cioè che Maniero, dalla galera, mandava i bigliettini per mettere chili di eroina a casa di uno, i kalašnikov da un altro e far ritrovare un miliardo e mezzo in un posto per raccontare che era il nostro covo, allora la storia verrebbe raccontata in modo diverso.
Quindi è stata tutta una costruzione giudiziaria?
E prima ancora mediatica. Il giornalista Maurizio Dianese, solo per far capire l’esagerazione, lo ha definito «il più grande bandito di tutti i tempi». Ha detto anche che i miei libri si basano sui racconti di mio fratello. Se fosse così, non avrei passato 36 anni in carcere. Quando stavo per uscire, mi ha chiamato chiedendo un’intervista. In quel periodo ero in semilibertà, e lui si è attivato dandosi un gran daffare con il magistrato. È riuscito ad avere il permesso, mi viene a trovare sul posto di lavoro e la prima cosa che mi dice è questa: «Giampaolo, però qualche nome lo devi fare». Nomi? «Non li ho mai fatti, figurati se li faccio con te. L’unico che nomino è Felice Maniero», gli ho risposto. Ha preso le sue cose e se ne è andato senza l’intervista. Da quel giorno me l’ha giurata!
Invece con Maniero?
Grazie a Maniero è diventato ricco. Tramite lui ha fatto i suoi “scoop”, tra virgolette. Come si può constatare anche negli ultimi tempi. Chi è che ha portato Maniero a Pulp Podcast da Fedez e Mr. Marra? Proprio il giornalista Dianese, che poi lo ha dipinto come “il boss dei boss”. Lo ha portato là anche se Felice, come è evidente dal video, ormai versa in pessime condizioni di salute.
In quell’intervista Maniero ti nomina, per la prima volta, pubblicamente.
Da quando sono popolare è andato giù di testa, non sopporta che sia diventato più famoso di lui. Così Dianese, che lo segue sempre, lo ha spinto ad andare nel podcast per rispondere a quello che dicevo io, cioè che ha raccontato un sacco di balle. Ma sai perché è andato da Fedez?
Per la grande audience che garantisce?
No, perché da Fedez ci vanno soltanto i collaboratori di giustizia.
Se oggi dovessi incontrare Felice Maniero, cosa succederebbe?
Ora mi fa pena. A cosa servirebbe ucciderlo, mi ridarebbe gli anni che ho passato in galera? No! Dopo tutto quello che ho attraversato sono un uomo libero, che ha trovato la redenzione, quindi in questa storia sono un vincitore a livello umano, lui uno sconfitto. Se entrasse adesso nel ristorante, lo farei sedere e gli direi: «Sai che quando sono uscito di galera il primo pensiero non l’ho avuto per la famiglia ma per te, Felice?».
Perché hai pensato a Maniero?
Mi è venuto in mente perché ho realizzato qual è la differenza tra noi: io ho scontato la mia pena e sono rimasto coerente con la mia vita, ho fatto un percorso in carcere, anche interiore col teatro, come si vede nel film, che mi ha permesso di espellere il male. Io sono guarito, lui no.
Durante gli anni d’oro dell’organizzazione criminale, o delle bande, che rapporti avevi con Maniero?
Di affari, oltre a quelli niente di particolare. Nel primo periodo ci si vedeva più spesso, poi sono arrivati i cellulari. Ma, anche se c’erano, quando dovevamo parlare li lasciavamo a casa e ci incontravamo in aperta campagna per non farci intercettare. Gli smartphone sono stati la sconfitta della malavita… Comunque, tra me e Felice prima c’era grande rispetto. Anche se non ricordo dei bei momenti passati con lui. Vallanzasca mi disse, dopo averlo visto in carcere: «Gianni, non mi è mai piaciuta quella faccia da cazzo. Quando è arrivato a Novara ho capito che era un pezzo di merda». Felice ha sempre avuto paura della galera, perché ti logora ogni minuto che ci stai dentro.

Giampaolo Manca con il figlio Armando. Foto: press
Il carcere cos’ha rappresentato per te?
Una vita dentro un’altra vita. Anche se sono uscito, mi sento sempre in galera. Tutte quelle manie, quei tic o quei modi di comportarmi in carcere non riesco ancora a togliermeli.
Nelle celle di alcune carceri, hai raccontato, una volta c’era l’acqua fino alle caviglie e i topi che risalivano dai sanitari.
È vero, dovevi stare attento a fare i bisogni perché ti mordevano. I topi, in certe carceri, erano talmente grossi che mangiavano i gatti. Non ho mai patito tanto freddo come in galera.
Quando sei uscito dal carcere, quarant’anni dopo, com’è stato riadattarsi al mondo esterno?
Mi sembrava di essere un alieno, ma per fortuna già quando ero dentro pensavo: «Non posso uscire come un rincoglionito». Per cui mi tenevo aggiornato. Ma i primi mesi è stata dura lo stesso. Pensa che anche solo fare la spesa era un casino. Stare in mezzo a tutta quella gente mi faceva paura. O una volta a casa, quando sono tornato, chiedevo il permesso persino per fare la doccia. Adesso, invece, dicono che sono diventato un influencer. Non è vero, io voglio solo parlare con più gente possibile, soprattutto con i ragazzi, e spiegargli di non fare i miei stessi errori.
Cosa ti chiedono più spesso i giovani che incontri nelle scuole?
Tanti mi dicono, dopo aver letto i miei libri o ascoltato le mie parole sui social, che aver conosciuto la mia storia li ha aiutati a non fare scelte sbagliate. Io quando vado nelle scuole non gli faccio tanti giri di parole, li guardo negli occhi e gli spiego esattamente le conseguenze di certe azioni: «Vuoi metterti a uccidere la gente?», li incalzo. E poi gli spiego cosa succede dopo: «O vai in galera o vieni ammazzato, non ci sono altre alternative».
Oggi è cambiato tutto, anche la criminalità.
Per fortuna non ci sono più certe dinamiche, anche grazie alla tecnologia.
Eppure, poco tempo fa, c’è chi ha svaligiato il Louvre.
Quando ho letto la notizia mi sono arrivati dei messaggi del genere: «Giampaolo, non è che sei passato per Parigi?». Pensavano ci fossi dietro io… Ma poi ho detto a Gianna: «Vedrai che li beccano». Infatti è successo. C’è troppa tecnologia per pensare di replicare i colpi che si facevano in passato. Sono rimasti solo alcuni che assaltano i portavalori. Come una batteria di serbi che, dopo anni di guerra, ha mantenuto le armi d’assalto e, non sapendo che cosa farci, le usa per fare le rapine. Le hanno fatte persino a Dubai. I più bravi, però, erano quelli delle Brigate Rosse.
Come mai?
Perché studiavano tutto a tavolino. Noi, anche se venivamo da lontano, eravamo affascinati dal loro modo di colpire. Erano “bravi”, sempre tenendo conto che parliamo di cose sbagliate da fare. Ci hanno influenzato a noi banditi per quanto riguarda la pianificazione dei colpi. Non a caso, dopo un po’ abbiamo seguito l’esempio di aumentare il numero di componenti nelle varie batterie. Se vai a rubare dieci miliardi, anche se sei in dieci invece di cinque, cosa ti cambia? Certo, guadagni un po’ meno, ma il gruppo fa la forza e riesci a colpire obiettivi più grandi.
Ora i colpi che pianifichi sono soltanto romanzati.
Esatto, ho scritto una storia perché Gianna ci vuole fare un altro film. Il libro si intitola Sequestro a Manhattan, una vicenda di fantasia che mi ha impegnato per tre mesi. Racconto dell’ultima rapina che mi sarebbe piaciuto compiere, ma è tutta una ricostruzione di fantasia. Non avevo mai scritto qualcosa del genere, di solito mi basavo sulla mia biografia, però mi sembra venuto bene.
E adesso fai anche i tour turistici a Venezia nei luoghi in cui hai compiuto i furti o dove sono ambientate le storie della Mala veneta.
E sono sempre pieni di persone che vogliono partecipare. Pensa che un giorno ho incontrato il governatore, Luca Zaia, e mi ha detto: «Sei un genio, solo tu potevi fare una cosa del genere». Ma l’idea non è mia, è di Gianna. L’ho visto al Festival del cinema di Venezia, mi ha fermato e gli ho chiesto: «Dove sei nato?». E Zaia: «A Conegliano». Allora sei un falso Doge veneziano, ho scherzato. Per un periodo ci siamo incontrati a diversi eventi, lui presentava il suo libro e io il mio. C’era sempre più gente alle mie presentazioni. Tanto che un giorno mi fa: «Mi stai seguendo?». E gli ho risposto: «Sì, perché stai usurpando il mio regno». Si gioca, ma per dire che riscontri sto avendo.
In uno di questi tour, quando sei passato nei pressi del carcere di Venezia, dalla finestra ti ha salutato un ex sodale come Silvano Maritan, tornato dietro le sbarre.
Incredibile! È vero che c’era uno che andava con la sua donna e hanno litigato, ma è stato anche sfortunato. Silvano girava con un coltellino, perché se hai un certo passato non si sa mai. Si incontrano, litigano, quello gli dà un pugno, Silvano cade a terra e quando si rialza gli sferra una coltellata e lo prende alla giugulare. Se ci riprova altre cento volte non ce la fa più. Così ha preso altri vent’anni, ma già prima sbagliava. Quando sei agli arresti domiciliari non puoi farti venire a trovare da altri pregiudicati, perché prima o poi finisce male. Quando urlava dalla finestra del carcere gli ho risposto: «Silvano, hai rotto i coglioni, ma vuoi davvero morire lì dentro?».

Giampaolo Manca e il fratello Fabio. Foto: press
Nel documentario emerge con forza il rapporto con tuo fratello gemello Fabio, che ha contribuito alle vostre scorribande. Anzi, all’inizio lui era il trascinatore.
Fabio è la mia vita e dico spesso: «Meglio duecento anni di galera che le malattie che lo hanno colpito». Il mio cambiamento è anche grazie a lui, però sarebbe stato meglio che non si fosse ammalato. Quando ho saputo che stava male, in carcere pregavo Dio: «Se lo fai guarire, ti prometto che cambio». Ha avuto tre ictus e si è curato per due tumori. E ogni tanto, da vigliacco, penso: «Vorrei morire prima io». Se non si fosse salvato, non so se sarei cambiato. A lui, però, il male lo ha temprato. Chi fa tanta galera si rinforza. Fabio ha un caratteraccio. Era più violento di me. Ma sai, noi Manca siamo gente dura a morire. Una volta mi ha fatto diventare un camorrista cutoliano…
Addirittura?
A Murano ha conosciuto Rosetta Cutolo, Roberto Cutolo e Vincenzo Casillo. Erano alloggiati all’Hotel Danieli di Venezia e sono diventati amici. E cosa fa Rosetta? Scrive al fratello Raffaele, il boss in carcere: «Ho conosciuto dei ragazzi meravigliosi a Venezia, si chiamano…», e fa i nomi. Poi gli chiede di avere un occhio di riguardo per noi. Un giorno cambio carcere e quando entro ci mancava solo che mi stendessero i tappeti rossi. Ero stato schedato tra i cutoliani, che in carcere allora dominavano. Il problema è che le guardie, di conseguenza, poi mi hanno messo un mese nelle celle speciali, e non nelle sezioni, proprio per questo.
Lo stesso Vallanzasca era stato accostato ai cutoliani.
Sì, ma non è che fossimo cutoliani. È che in quel periodo, visto che comandavano loro, spesso si lasciava correre e così venivi trattato meglio. Cosa potevamo fargli, la guerra? Se ne accoppavi uno ce n’erano altri trenta. Erano tanti e quindi in galera dominavano. Non bisogna dimenticarsi che una volta, in carcere, si moriva per uno sguardo sbagliato o mal interpretato.
Com’era invece Renato Vallanzasca?
Mi diceva sempre: «La mia mammetta mi porta la cassœula, come la fa lei non la fa nessuno». Aveva ragione, una volta l’ho assaggiata: una bomba! Abbiamo passato undici anni insieme in carcere. Renato ha una personalità dirompente, nel bene e nel male. Però è una persona vera. Ne ha fatte di tutti i colori ma, in fondo, è un buono. So che può sembrare strano, ma lo dicono tutti quelli che lo hanno conosciuto. È un ribelle, lottava per tutti e si è preso anche tante colpe non sue. Come l’ultima volta che l’hanno rimesso dentro, per quella stupidaggine non vera che ha rubato un paio di mutande in un negozio. Hanno voluto che marcisse in carcere, la polizia non gliel’ha mai perdonata.
Hai conosciuto anche diversi appartenenti alle Brigate Rosse.
A un certo punto si sono inventati che ero un detenuto politico, così dove mi portano? A Biella, dove c’erano i militanti delle Brigate Rosse, in particolare quelli della Colonna Walter Alasia. Di me conoscevano un po’ la storia, io invece ne ho conosciuti diversi direttamente in carcere. C’è chi non ha sparato mai un colpo e si è fatto quarant’anni perché non voleva i benefici dallo Stato. Come Paolo Maurizio Ferrari, con cui mangiavo a pranzo. Io cercavo di spingerlo ad accettare di uscire, ma lui niente, anche se aveva già scontato tutta la pena. I brigatisti mi sembravano come quei guerrieri giapponesi che, anche dopo che era finita la guerra, non uscivano più dalla foresta.
Da quando sei uscito ti sei mai sentito in pericolo?
Appena fuori, nel 2018, ho avuto una “visita non gradita”. Certi ambienti mi rinfacciavano le promesse che ci siamo fatti ai tempi. Cioè che dovevamo vendicarci tutti assieme di chi ci aveva tradito. Ma io gli ho detto: «Dopo aver espiato tutta la pena, non devo più niente a nessuno. La mia vita adesso è cambiata». Mi prendevano persino per il culo perché volevo aiutare i giovani. Certo, gli ho ribadito, volete che facciano gli errori che abbiamo fatto noi? Ma ho capito che, a parte la vendetta, c’era anche dell’altro. Siccome non sono nato ieri, ho percepito che quella persona, di cui non faccio il nome, era venuta per uccidermi.
Come hai reagito?
Avevo due strade: ammazzarlo o denunciarlo. Alla fine ho deciso per la terza via, che prima non avrei neanche preso in considerazione: non fare nessuna delle due e andarmene da casa. Nel frattempo, chi era venuto a trovarmi si mette a discutere al telefono con i residui della criminalità che era uscita per organizzarsi su come beccarmi, ma viene intercettato. Alla fine i carabinieri li hanno arrestati e mi hanno salvato la vita. Solo in quel caso ho collaborato con le forze dell’ordine. Ma io non ho fatto la spia o infamato nessuno, semplicemente la nave era affondata da tempo ed eravamo colati a picco tutti assieme. Per cui non è colpa mia se quelli non hanno capito il mio cambiamento. Sono andato a processo e mi sono costituito parte civile. Spesso prego Dio che anche loro possano guarire, ma è difficile. Mi piange il cuore se ci penso, siamo tutti 70-80enni, potevamo fare qualcosa di davvero importante per ridare tanto a questa società, invece loro non cambiano. Il male è ancora dentro di loro. Io invece sto bene con me stesso, anche se con rimorsi enormi.
Uno di questi rimorsi riguarda tuo figlio Armando, che nel film spiega quanto è stato difficile avere un padre criminale e che è stato minacciato per ritorsione.
Armando ha pagato colpe che non ha mai avuto. È un bravo ragazzo e un gran lavoratore. Lo hanno anche minacciato, è vero, quando non c’entrava niente con quello che facevo. Ma questa è la malavita: il male assoluto. Che investe tutto, persino ciò che hai intorno di più caro.
Riguardando il docufilm, qual è la prima cosa a cui hai pensato?
Non mi capacito di aver fatto così tante cose brutte. Quelle peggiori sono arrivate quando abbiamo preso il controllo della droga. Prima, da banditi e rapinatori, rischiavamo soltanto la nostra pelle. Dopo, smerciando tonnellate di droga che arrivava soprattutto ai più giovani, abbiamo messo in pericolo e portato alla morte chissà quanti ragazzi, in particolare i più deboli. Conoscevo un turco, che ci riforniva, che un giorno mi ha detto: «Sai come abbiamo fatto la guerra all’Europa? Con l’eroina». È stata inondata con conseguenze disastrose.
Giampaolo va a fumare una sigaretta con alcune persone che, nel frattempo, si erano avvicinate al tavolo per ascoltare la sua storia. Così ne approfitto per fare qualche domanda alla regista Gianna Isabella Magliocco, motore dei tanti progetti di Manca, che in America ha collaborato con registi del calibro di Alejandro González Iñárritu e Christopher Nolan.
Gianna, quando vi siete conosciuti?
Un mio amico canadese aveva trovato Giampaolo su Instagram e, dopo essere rimasto colpito dai suoi racconti pazzeschi, me lo ha segnalato. Mi sono informata, effettivamente erano storie incredibili, così gli ho chiesto di sentirci e abbiamo organizzato una videochiamata. Dopo averlo sentito parlare, anche delle sua vita attuale e del suo impegno per i bambini autistici, è nata l’idea del documentario. A lui l’idea è piaciuta, mi sono fatta mandare i suoi libri, ho cominciato a informarmi, a studiare, e mi sembrava giusto mettere in luce la sua redenzione.
Adesso avete tanti progetti paralleli.
Perché è una storia enorme che non può essere contenuta solo in 90 minuti di documentario. Per Il Doge – Un ritratto della redenzione sono stati fondamentali anche il direttore della fotografia Daniel Everitt-Lock, il compositore Thilo Schaller, il responsabile del suono Joel Varjassy e la grafica Erica Rossi per il poster. Ora stiamo sviluppando la serie per le piattaforme streaming, per riuscire, grazie alla serialità, a raccontare tutto il resto in modo molto più ampio.
Da qualche tempo, però, non siete soltanto una coppia artistica ma anche nella vita.
La complicità è scattata subito, appena ci siamo incontrati a Roma. Giampaolo è uno che va veloce, che non aspetta, soprattutto per il tempo che ha trascorso in carcere, per cui ti travolge con la sua energia e il suo entusiasmo. Ha una personalità dirompente, oltre ad avere una simpatia unica. Ridiamo tutto il giorno e lavoriamo su tanti progetti. Uno nuovo, al quale parteciperà, è un film horror dove interpreterà un prete, don Valentino. Come potete vedere ha delle qualità attoriali.
Giampaolo torna al tavolo. È il momento di raccontare l’aspetto più importante che si nasconde dietro a tutti questi progetti, dai libri al documentario fino agli incontri e i tour a Venezia: la raccolta fondi per sostenere i bambini autistici con l’associazione Alphabeta.
Come mai hai scelto proprio questa attività benefica?
Un giorno Fabiana, un mamma, mi contatta dopo aver letto un mio libro. La incontro e suo figlio Carlo, che è autistico, mi guarda e mi accarezza. E sua madre mi spiega: «Sa che lei va a genio al mio bambino?». Da lì è scattata una scintilla. Mi ha raccontato tutte le sue difficoltà, che sono quelle di centinaia di migliaia di genitori in Italia, e delle mancanze da parte dello Stato.
Qual è il tuo sogno futuro?
Raccogliere più donazioni possibile, infatti non sai cosa darei per incontrare di persona Robert De Niro e parlargli di questi progetti. So che anche lui ha un figlio nello spettro autistico, quindi sarebbe un testimonial perfetto per l’associazione, perché vive queste cose giorno per giorno. Lo dico sempre: voglio morire quando la mia casa sarà pronta ad accogliere questi ragazzi, per aiutare le persone con figli autistici anche dopo che loro non ci saranno più.