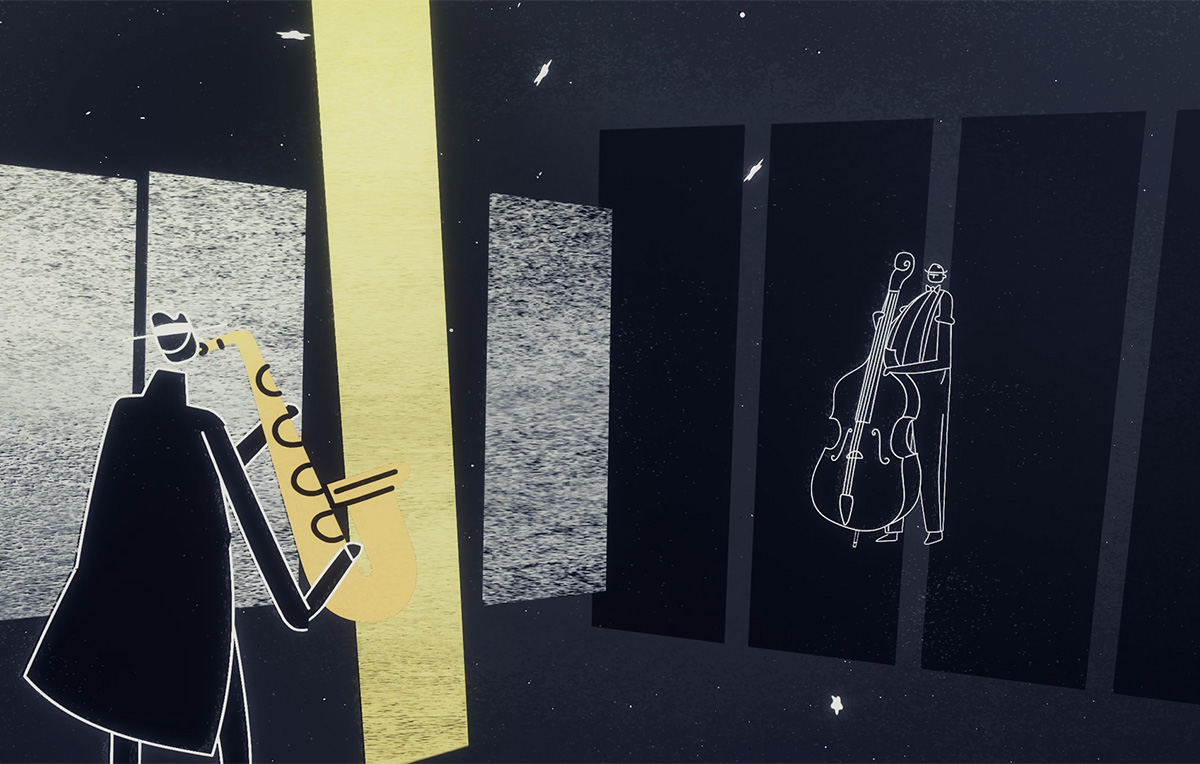Quando lo incontriamo, Bernardo Antoniazzi è appena sceso dal palco dove ha parlato del rapporto tra il suo lavoro e il realismo insieme a un ex incursore italiano. Ha appena raccontato di come sia diventato il punto di riferimento per la cattura di immagini e animazioni all’interno di Infinity Ward, il team che si occupa da anni di Call of Duty (qui la nostra recensione). È calmo e rilassato, un’espressione amichevole, una gran barba e una maglietta nera col logo di Modern Warfare, l’ultimo capitolo di CoD rilasciato da pochi giorni. L’impressione che quella che ci aspetta sarà una conversazione piacevole e divertente cresce di minuto in minuto, al punto che sarà il PR che supervisiona la sua giornata di incontri con la stampa a fermarci perché il tempo a nostra disposizione si è esaurito.
Ciao Bernardo. Oggi vorremmo parlare con te del percorso che ti ha portato a lavorare in Infinity Ward, partendo da Vittorio Veneto. Abbiamo grosso modo la stessa età, quindi immagino che la nostra adolescenza possa essere stata simile. Io ho iniziato con un Atari 2600, tu?
Io in realtà un Commodore 64, subito dopo un Atari 2600 anche io.
Ecco, già a quell’età, col pad in mano, sapevi che avresti fatto questo nella vita?
Forse in quel momento ancora no, avevo molto amore per la tecnologia però. Avevo amore per il PC, ma la mia famiglia non aveva la possibilità di comprarmene uno. Ho avuto il primo computer a 19 anni e ho iniziato una vera immersione. I videogiochi sono stati una cosa fondamentali però. Parliamo di Worldcraft, il primo, Starcraft, Diablo… Diablo è stato probabilmente il gioco preferito per tanti anni. Lì è nato un sogno: come potrei arrivare a fare le cinematiche della Blizzard? Te le ricordi? Incredibili. Dico Diablo perché alla fine sono riuscito a lavorare su Diablo III, sulle sue cinematiche, era il mio obiettivo. Ho fatto le espressioni facciali di Tyrael, l’angelo di Reaper of Souls.
Quindi hai impostato i tuoi studi per seguire quell’obiettivo?
In realtà ho iniziato facendo il classico. Avevo una zia che lavorava a Ginevra, ho provato un anno di Scienze Diplomatiche, ma mi sono reso conto che volevo essere altrove. Mi sono detto: cerchiamo di non soffrire più, di fare qualcosa di interessante. Non c’erano corsi di videogiochi all’epoca. La cosa più vicina era il web design. Mi sono iscritto a un corso all’Accademia di Belle Arti. Ho fatto un anno di grafica, mi è servito tantissimo, ho studiato le tecniche pittoriche, il fotoritocco. Ho avuto poi la fortuna di essere selezionato in un corso della comunità europea, c’erano solo 12 posti disponibili. Quel corso mi ha cambiato la vita. Visto che il titolo di studio comunque serviva ho finito l’Accademia a Milano, in Media Design. Poi ho avuto l’opportunità di fare un viaggio di scambio a San Francisco, alla SFU. Anche lì c’erano solo 12 posti per fare animazione tridimensionale, un posto molto professionale, 30.000 persone nel campus. Mi dicono: prepara un portfolio. Ho passato l’estate a studiare, ho perfezionato il mio inglese e quando ho mostrato i miei lavori al professore mi sono sentito rispondere: non c’è nulla che ti possa insegnare. E ora? Io vengo a SF e tu non mi vuoi insegnare niente?! E lui a quel punto mi ha proposto: perché non insegni tu? Così ho fatto 6 mesi come assistente e 6 mese come vero e proprio docente.

“Avevo un amore per il PC, ma la mia famiglia non aveva la possibilità di comprarmene uno. Ho avuto il primo computer a 19 anni.”
Tu credi che questa competenza che ti ha aperto le porte lì sia stata frutto della tua formazione o era innata, già dentro di te?
Credo sia una combinazione. Serve avere degli stimoli esterni, come il corso della CE e l’Accademia, ma è anche merito della mia predisposizione a risolvere problemi, un po’ frutto della mentalità italiana di cavarsela.
Ma nello specifico, credi che la formazione che hai ricevuto in Italia ti sia stata utile?
Ha contribuito a darmi una visione di quello che si poteva fare, più che dirmi come le cose andavano fatte. Prima un ragazzo mi ha chiesto cosa fare per imparare a fare videogiochi. Io gli ho detto: vai a scuola, apprendi quello che ti può insegnare che è il 20%, poi il resto studia da solo. Come ho fatto io. Ho passato ore in internet a scaricare tutorial e informazioni, ho letto pagine e pagine di stampato. Mi sono letto manuali di software senza avere il software. Tutto quello che impari prima o poi si accumula e ti consente di collegare cose che magari in teoria non potrebbero esserle.
Com’è stato il triplice salto Vittorio Veneto, Milano, San Francisco?
A me piace viaggiare. È stato molto bello e difficile, ovvio: ogni volta in un posto nuovo devi imparare anche le cose basilari. A San Francisco non c’era una vera e propria comunità italiana, o almeno non la frequentavo, anche se passavo molte tempo con la comunità di “expat” locali.
Che in un certo senso è anche un vantaggio, eviti di isolarti tra i tuoi connazionali.
Sì, forse sì. Ora sono 13 anni che vivo lì e non ho mai fatto parte della comunità italiana, anche se so che esiste. I primi anni è tutto nuovo e non mi interessava molto frequentarli, negli ultimi anni forse sto diventando vecchio e ho un po’ di malinconia, mi piace tornare ai sapori nostrani. Non so. Poi mia sorella ha avuto una bambina, quindi un po’ avverto la voglia di tornare ogni tanto.
Per quanto riguarda il lavoro, invece, è stata la SFU che ti ha trovato gli agganci? Ti hanno cercato le aziende?
Non ricordo precisamente. Lavoravo a Milano, in interneship per la scuola, mentre un ragazzo lavorava in un’altra compagnia a San Francisco, lui conosceva gente, un po’ per caso mi messo in contatto e così è partito tutto.

“È la bellezza della formazione italiana, non focalizzata, ma globale. È un po’ un’arte di sapersi arrangiare, no?”
E sei entrato subito nel settore dei videogiochi?
In quello delle cinematiche, più vicino all’animazione in realtà. In realtà insegnavo e lavoravo per questa compagnia, Cinematico, piccolina, formata da cinque persone. Appena ho iniziato facevo già un po’ tutto.
Formazione perfetta direi.
Sì, credo che sia la bellezza italiana: noi formiamo generalisti, persone che sanno fare un po’ di tutto. Magari non sanno fare una sola cosa benissimo, ma sanno farti un disastro di cose. È la bellezza della formazione italiana, non focalizzata, ma globale. È un po’ l’arte di sapersi arrangiare, no?
Poi è arrivata Activision.
Sì, lavoravo per Cinematico che prendeva commissioni da Activision. Passavano spesso a trovarci per vedere l’avanzamento dei lavori e un giorno un producer mi ha detto: “stai lavorando a tutti i nostri progetti, vieni a lavorare da noi”. All’inizio sono stato assoldato per lavorare nel campo dell’outsorcing. Visto che sapevo fare un po’ di tutto mi hanno messo a capo del reparto che si occupava dei progetti che venivano commissionati a società in Cina e Taiwan.
Il salto da progetti come Marvel Ultimate Alliance, dove immagino lavoraste a modelli di animazione più tradizionale, a CoD, come l’hai vissuto? Com’è stato l’impatto?
Un po’ un’emozione. C’è una aneddoto che ti posso raccontare. Nel secondo anno in Activision lavoravo a Modern Warfare 2 con Joel Emslie, e mi occupavo delle scansioni. Avevo fatto una scansione laser dei pantaloni, aveva milioni di poligoni, non si poteva ovviamente usare nel gioco. Ma l’avevo mostrata a Joel e lui mi guardava come per dire: come facciamo a inserirla, non si può usare. Lui poi è andato via, è andato in Respawn ed è tornato due anni fa e quando ha visto i miei lavori mi ha detto: io mi ricordo che nove anni fa ti avevo detto che non si poteva fare e tu invece oggi l’hai fatto! Forse al tempo avevo avuto una visione sulla cattura della realtà e sui livelli che ci avrebbe fatto raggiungere.

“Farah mi piace moltissimo. Anche l’attrice che la interpreta, mi ritengo fortunato ad avere lavorato con lei. CoD intende essere una storia inclusiva e rappresentativa di tutti.”
Tu da allora hai anche creato degli strumenti tecnologici nuovi per fare il tuo lavoro. Come si convince Activision a farteli fare?
Loro sono come San Tommaso: devi fargli vedere un prototipo funzionante. Ho passato weekend e notti ha lavorare ai miei progetti, che consentono di fare tutto, dalla cattura all’inserimento dell’oggetto in un unico processo produttivo. Se tu prendi un’artista e gli dici di creartelo ci vogliono due settimane. Io invece in una giornata posso arrivare ad avere un oggetto che sembra vero, con tutte le pieghe, le proprietà dei tessuti, con tutte le caratteristiche dell’oggetto che avrebbe fatto un artista digitale, risparmiando un sacco di soldi e tempo.
E non c’è modo migliore.
Eh già. Il problema finora era che Infinite Warfare era futuristico, non potevamo usare oggetti reali. Con Modern Warfare invece se vogliamo un’uniforme la ordiniamo, facciamo tutto il lavoro per far sì che non sembri nuova e la acquisiamo in digitale.
A questo proposito, che rapporto avete con le forze speciali statunitensi? Collaborano con voi, condividono?
Lavoriamo con dei consultant, ex marine, perciò abbia tutta l’esperienza di chi ha lavorato sul campo. Ogni tanto ho avuto la fortuna di essere ospitato in un campo di addestramento dei marine, mi dicono che sono grandi fan e quando sono in missione giocano a CoD. Abbiamo un buon rapporto e finanziamo anche un’associazione che si occupa di aiutare i veterani.
La rappresentazione della diversità negli ultimi anni come ha cambiato il tuo lavoro?
In realtà noi siamo anni che cerchiamo di rappresentare la diversità. Poi a me piace rappresentare le persone e faccio molta ricerca. Se un livello è ambientato a Londra io voglio essere sicuro che la gente in quel livello rispecchi quella che vedresti a Londra. Se è ambientato in Russia voglio che le facce sia giuste. Per me c’è sempre la volontà di rappresentare. Il nostro team è composta da gente di diverse nazionalità e mi piace rappresentare la diversità di chi lavora con noi. Sono molto attento a non trascurare anche etnie che appaiono di rado nei videogiochi. Per esempi, ho creato un personaggio samoano, una popolazione che per me ha lineamenti fantastici. Un po’ The Rock, ecco!
Torneresti in Italia a fare questo lavoro? Pensi che ci sia modo di fare un lavoro della tua professionalità anche qua?
Sono un po’ in conflitto. Vedo che ci sono talenti assurdi, c’è gente che viene dall’Italia di una bravura mostruosa. L’Italia ha il talento per fare progetti di questo tipo. Secondo me si potrebbe fare benissimo. Abbiamo una bellezza naturale impareggiabile, immagina cosa si potrebbe fare con le tecniche che ho realizzato, magari un livello ambientato a Lucca. Abbiamo già tutto, mancano i progetti. Certo servono budget importanti. Non so se l’Italia è disposta ad avere budget di questo tipo, ma anche il supporto strutturale. [Gli spiego la polemica del giorno sulla carta d’identità per i social.]. No, ok, sarà difficile.
Grazie Bernardo, mi sa che il tempo a nostra disposizione è finito.
Scusa, prima di concludere posso aggiungere due parole sul discorso di prima della diversità collegandomi alla figura di Farah? È un personaggio che mi piace moltissimo. Anche in Infinite Warfare abbiamo sempre avuto un personaggio femminile molto forte nella campagna, perché appunto CoD intende essere una storia inclusiva e rappresentativa di tutti. È fantastica Farah, ma anche l’attrice che la interpreta, mi ritengo fortunato ad avere lavorato con lei. È sempre interessante parlare con gli attori, vedere da dove arrivano, qual è il loro background. In infinite Warfare avevamo X-O che è di origine libanese, aveva la bandiera libanese sulla divisa, volevamo che trasmettesse l’orgoglio del senso di appartenenza già da questi piccoli dettagli.