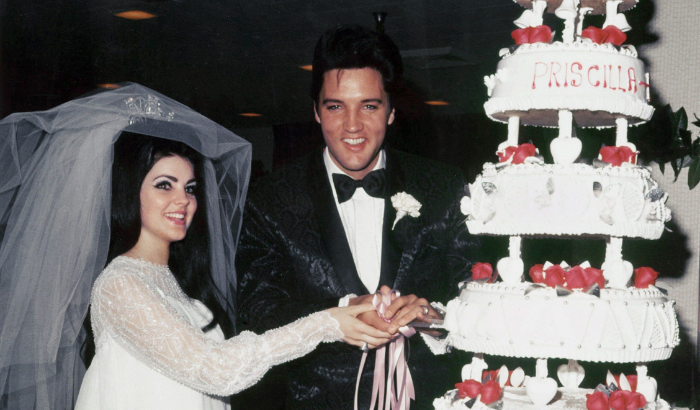Gli italiani, tra di loro, vanno d’accordo su molte poche cose, ma sulla pizza nessuno ha dubbi: la più buona è quella che fanno loro. Ambito in cui a nulla vale la scienza, e dove nemmeno libri e podcast sortiscono effetto alcuno (pensiamo a DOI – Denominazione di origine inventata) quando tentano di andare contro la storia in cui amiamo crogiolarci, identificando gli Stati Uniti come il Paese natale delle pizzerie (o peggio ancora della pizza “come la conosciamo oggi”).
Perché la pizza, dalle nostre parti, è molto più di un semplice piatto. Noi siamo quelli che ordinano una margherita di ritorno da un lungo viaggio, e anche quelli che, di regola, si rifiutano di mangiarla fuori dai confini nazionali. La pizza è uno dei segni distintivi della nostra comunità nazionale. Nello stesso impasto si mischiano scienza e religione, tecnica e magia, convivialità e solitudine, comodità e street food, casa e ristorante, tradizione e avanguardia, rispetto e iconoclastia. La pizza, per noi italiani, non è mai solo una pizza.
Ma il mondo è vasto e i confini gastronomici più dilatati di quanto pensiamo. E infatti, quasi di soppiatto, in Italia cominciano ad arrivare altre voci. Giungono dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, facendo il percorso inverso dei nostri bisnonni emigranti: sono soprattutto la pizza slice newyorkese e la deep dish di Chicago, e hanno allargato gli orizzonti (già piuttosto ampi) sull’estetica, e il gusto, della pizza. Ma se c’è una città in cui l’appartenenza culturale di una comunità si cementifica, proprio come dalle nostre parti, attorno ad acqua, farina, lievito e un forno, questa è Buenos Aires, tanto che da anni girano statistiche che posizionerebbero la capitale argentina sul gradino più alto del podio delle città in cui si consuma più pizza – o con il maggior numero di pizzerie per abitante, a seconda della fonte di seconda o terza mano. Si tratta di dati non facilmente verificabili, probabilmente di parte, quasi sicuramente confutabili. Ma, come vedremo, il rapporto degli abitanti di Buenos Aires con la pizza è puro realismo magico.
La pizza di Buenos Aires ha, com’è prevedibile, origini italiane, e la sua storia si perde nel solco delle tante che parlano dell’immigrazione dall’Europa verso il Sud America: Augustin Banchero è un giovane genovese che, come tanti conterranei, è arrivato in Argentina alla fine dell’Ottocento in cerca di fortuna. Come la stragrande maggioranza dei compaesani si stabilisce nella capitale, nel quartiere della Boca: una zona isolata (e insalubre) della capitale, resa porto naturale dalla presenza del fiume Riachuelo, uno degli affluenti del Rio de La Plata. È qui che, nella seconda metà dell’Ottocento, iniziano a svilupparsi le prime attività legate alla cantieristica e al commercio. Il nome deriva proprio dalla foce del fiume – la boca, per l’appunto – anche se una ricostruzione etimologica più romantica e leggendaria lo fa derivare da Boccadasse, piccolo borgo di pescatori genovesi con uno degli scorci più suggestivi della Città della Lanterna.
La comunità genovese è talmente forte e coesa da fondare nel 1876 un movimento separatista che, sei anni più tardi, arriva addirittura a proclamare la nascita della República Independiente de La Boca, con tanto di atto formale inviato al Re d’Italia Umberto I e bandiera di San Giorgio, emblema di Genova, a sventolare sulle case colorate del circondario. Solo l’intervento diretto del Presidente argentino Roca riesce a far rientrare il caso diplomatico, ma non a recidere il cordone ombelicale che lega il quartiere a Genova. Un esempio su tutti: i tifosi e i calciatori del Boca Junior, l’iconica squadra di calcio locale, sono soprannominati xeneizes – storpiatura argentina di zeneize, genovese – e il legame dei suoi aficionados con le due squadre di Genova, Genoa e Sampdoria, è stato sempre molto stretto.
Ma torniamo ad Augustin Banchero: appena arrivato apre una panetteria, e lì inizia a sfornare la fugazza, pizza bianca con cipolla cotta al forno in teglie di ferro (nello stampo, al molde), diretta derivazione della celebre fugassa – focaccia in dialetto ligure – genovese. Sarà però il figlio Juan ad alzare per la prima volta, il 28 marzo del 1932, la serranda della pizzeria Rancho Banchero, che ancora oggi è un baluardo della cultura gastronomica porteña.
In questa avventura lo accompagnano i figli Tito e Antonio, e Juan si fa subito notare in tutta la città perché aggiunge alla fugazza del padre il formaggio – queso cuartirolo – per renderla meno asciutta. Nasce la fugazza con queso o fugazzeta: una pizza mediamente alta, con le cipolle più o meno sbruciacchiate e il formaggio che cola copioso da ogni lato. A proposito di panificazione e di Liguria, ai più attenti non sarà sfuggita una certa parentela con la focaccia di Recco.
Insomma: a Buenos Aires la pizza è un culto, una religione, e non si limita di certo alle varianti con la cipolla. C’è per esempio la pizza canchera, tonda e sottile, con abbondante salsa di pomodoro, origano e diverse spezie nata come street food da stadio – cancha significa proprio campo da calcio – inventata dal pizzaiolo Oscar Vianini della pizzeria Angelín, che la vendeva in occasione delle partite dell’Atlanta, la squadra del quartiere Villa Crespo. Il must porteño è con la muzza (con la mozzarella), ma si trovano anche le prepizzas, piccole pizze tonde già cotte in versione blanca, che però in città equivale comunque alla presenza di una buona dose di cipolla, o solo con la salsa da condire e scaldare a casa. Ci sono poi varianti con praticamente ogni tipo di ingrediente, con le pizzerie che sembrano essere in una competizione non dichiarata all’immaginare gli abbinamenti più azzardati.
Ma anche se volessimo limitarci alle varianti della sola fugazza avremmo tanto da assaggiare: oltre alla già citata fugazzeta, c’è la variante rellena (“ripiena”), ulteriore variazione sul tema che prevede la chiusura della superficie superiore con un’altra fetta di pizza e che si può trovare anche con l’aggiunta di prosciutto o di pancetta a imbottire la farcia. Nessuno però potrebbe mettere la mano sul fuoco su queste definizioni: anche leggendo o ascoltando i panaderos più famosi della città, le contraddizioni non mancano.
Per molti la fugazzeta è in realtà già rellena – quindi una versione della fugazza con formaggio e chiusa – per cui l’aggettivo “ripiena” sarebbe solo una ripetizione, mentre quella con solo l’aggiunta di formaggio sarebbe semplicemente una fugazza con queso (e cipolle). Per altri, prosciutto e pancetta sono delle aggiunte non codificate, spurie. Alcuni usano il queso in purezza, altri lo tagliano con un misto di formaggi, alcuni aggiungono la mozzarella o un topping di provolone. C’è poi chi si azzarda a mettere il pomodoro e trasforma la fugazzeta in una Portughesa. Alcuni la fanno tonda, ma c’è chi giura che l’originale sia cotta in teglie quadrate.
Se il rapporto di Buenos Aires con la pizza vi sembra talmente mitologico e viscerale da essere addirittura confusionario, sappiate che non finisce qui. Perché la cultura gastronomica porteña ha portato dalla Liguria un altro masterpiece: la farinata di ceci, che a queste latitudini si chiama fainà e si mangia insieme alla fugazza/fugazzeta – ma anche con gli altri tipi di pizza. Anche in questo caso ognuno le accoppia come vuole, c’è chi usa la fainà accanto alla fugazza come se fosse un pane, chi la mette sopra, chi sotto.
Su una cosa però sono tutti d’accordo: fugazza e fugazzeta si mangiano accompagnate da una Quilmes ghiacciata, direttamente in pizzeria, seduti o in piedi – al mostrador – circondati da un pantheon di idoli che va dai Maradona ai Messi, dalle maglie del Boca Junior a quelle dell’Argentina, dalle locandine di vecchi film alle sciarpe delle squadre di calcio di tutto il mondo. Passando per l’angolo con le foto in bianco e nero di chi quella pizzeria l’ha aperta, e poi quelle a colori delle generazioni che si sono avvicendate alla guida o dei VIP che si sono accomodati nel locale.
Nel planisfero delle capitali delle pizze, focacce, schiacciate, teglie, tonde, al taglio, per quanto ad alcuni italiani possa far storcere il naso, non c’è solo il Bel Paese. E una puntina (anche bella grande) va puntata sull’Argentina, perché a Buenos Aires, proprio come da noi, mangiare una pizza non è mai solo mangiare una pizza. Ed è ora di metterci il cuore in pace sul fatto che questa tradizione non appartenga solo a noi.