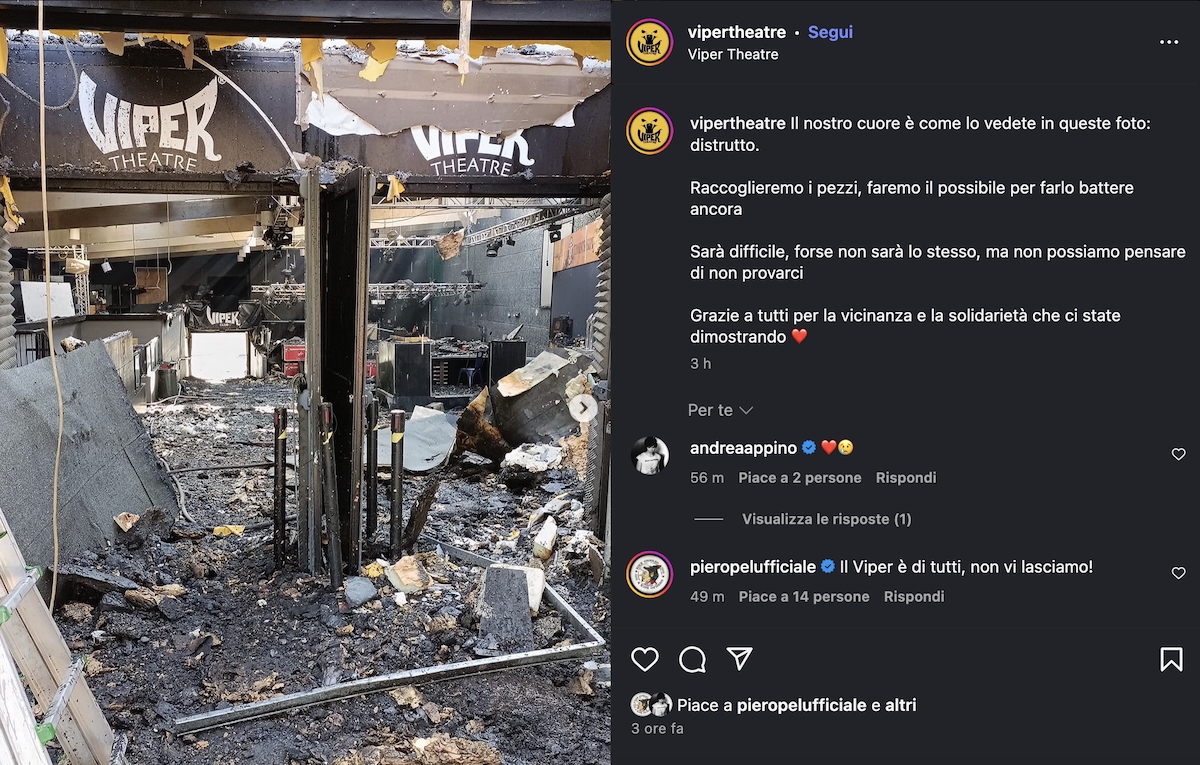Trasformista della musica, rocker, performer, artista, Piero Pelù è tante cose e tutte sono contenute nel road movie Piero Pelù. Rumore dentro, diretto da Francesco Fei. Tutto ha inizio quando, nell’ottobre 2022, uno shock durante una sessione di registrazione ha provocato al cantautore un danno permanente al nervo acustico. Ne sono scaturite non poche implicazioni psicologiche legate al doversi fermare da un tour programmato. A questo si è aggiunta la lotta contro la depressione, e il risultato è stato un lungo sguardo dentro se stesso, e a quei deserti che lo abitano. La decisione finale: fare nuove musica. «Ne sto uscendo con le unghie e con i denti. Ho riversato l’anima, ho scritto brani nuovi, potenti, e riscoperto idee dimenticate nel mio archivio infinito».
Il film – che domani sarà al Festival dei Popoli, il 6 novembre a Milano, il 7 a Roma e poi uscirà in tutta Italia con un evento speciale dal 10 al 12 novembre, distribuito da Nexo Studios – è un’occasione per (ri)scoprire Piero Pelù, i suoi amici, la sua Firenze, il suo mondo, anche alla luce del ritorno dei Litfiba, nel 2026, con il tour celebrativo di 17 Re, l’album considerato punto cardinale della band.
Piero, in questo film fai un viaggio anche spirituale a Saintes-Maries-de-la-Mer, in Camargue, dove vanno in pellegrinaggio i gitani per onorare Santa Sarah la Nera protettrice dei viaggiatori. Proprio lei, Santa Sarah, è anche colei che salvaguarda gli esclusi. Ti sentivi escluso?
È una lunga storia.
Raccontacela.
La mia diversità, già da bambino, era venuta fuori: ero differente dai compagni di scuola, dai cugini, dal resto della mia famiglia. Questa cosa mi ha sempre accompagnato e mi ci sono ritrovato fino in fondo, nonostante le difficoltà e le sofferenze.
Quali sofferenze?
Quando ti viene sempre fatto notare questa tua “tendenza”, finisci per essere etichettato come quello strano: sono cresciuto con questo senso di diversità rispetto al branco. Alla fine, però, è diventata anche una ragione di vita: mettermi a fare musica, scrivere, esprimermi nelle canzoni. È diventata il mio alibi, la mia ancora di salvezza e una forma di raggiungimento e soddisfazione personale.
Tornando a Santa Sarah?
Mi sono sempre sentito parecchio vicino a chi ha sofferto la propria diversità in contesti molto schematici. Santa Sara è la protettrice di tutti i viaggiatori: rom, sinti, manouche, gitani, eccetera. E sentendomi sempre molto a mio agio quando sono per strada – come in questo momento mentre facciamo l’intervista – il collegamento è stato naturale.
La Firenze che racconti nel film era un vulcano creativo. Quella città, in quegli anni, che cosa aveva?
Firenze era un vulcano che affondava radici profonde nel Dopoguerra. È stata una città estremamente accogliente. La prima discoteca gay d’Italia credo fosse il Tabasco – poi magari posso essere smentito – ma Bruno Casini, il mio primo manager e amico fraterno, uno degli agitprop più importanti di Firenze, mi ha sempre detto che era così. Personaggi come Bargellini, La Pira… politici non necessariamente rivoluzionari, ma estremamente preparati e illuminati, hanno gettato basi solidissime. Su quelle sono nate manifestazioni come il Festival dei Popoli. Firenze aveva un DNA aperto verso il mondo.
Anche negli Anni di Piombo o quelli più rivoluzionari?
Gli anni Settanta qui non furono violenti come Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, le grandi città politicizzate. Ci fu l’omicidio del sindaco Lando Conti, sì, ma in generale in quell’epoca Firenze fu quasi un’isola felice, fricchettona. Il centro era un posto vivo.
Cosa è rimasto di quella Firenze?
Niente. Dagli anni Duemila si è puntato tutto sulla Firenze-Dinseyland. È rimasto San Frediano – che è il mio quartiere e dove vivo e vado orgogliosamente per strada. L’ultimo quartiere veramente fiorentino. Un po’ Sant’Ambrogio… ma il resto è Florence, non è più Firenze.
Passiamo da una città all’altra. Nel film parli anche di Londra, della tua fuga lì in cerca di fortuna. Ma poi sei tornato: perché non è andata come immaginavi?
Probabilmente idealizzavo troppo i posti. L’ho fatto anche con canzoni come Istanbul.
Poi quando ci sei andato?
Essendo una roba profondamente mediterranea e contaminata, mi ci sono trovato bene.
Invece Londra niente, ti sei trovato male.
Sì, nella cultura anglosassone non mi ci sento davvero a mio agio, a parte qualche eccezione tipo i Black Sabbath, i Sex Pistols e quella roba lì.
A Parigi invece mi pare che fossi nel tuo posto.
Infatti nel film ci sono immagini del 1983: un viaggio che feci con niente in tasca. Nel 1983 in Italia non ci conosceva nessuno. Anche i miei parenti mi prendevano in giro per quello che facevo. Sempre tornando a quella diversità di cui parlavamo all’inizio. Nei primi anni Ottanta in Italia non ci filava nessuno. E qui torno a Firenze: era una città creativa, sì, ma comunque provinciale.
Sì eh?
Anche tra gruppi.
Cioè?
Avevamo messo in piedi l’etichetta con altri soci, c’erano i Diaframma, c’erano altre band, però non c’era davvero una profonda collaborazione, una vera curiosità. Anzi, era tutto un po’ un calcolo, sempre quelle dinamiche lì che a me ammazzano la fantasia, la gioia di vivere: «Loro hanno fatto questo, allora noi dobbiamo fare quello». Non era una competizione creativa, secondo me. E così ho detto: «Ragazzi, qui bisogna prendere e andare in Francia». Perché io sono abbastanza francofono e francofilo, come impostazione.
Ah sì?
Mia madre aveva studiato un po’ di francese, e poi a Parigi, nel ’72 con la famiglia, avevo scoperto i Black Sabbath e quindi… capisci a me. Sono combinazioni pazzesche che poi ti segnano per il resto della vita.
Insomma, partite.
Firenze–Parigi, wow. Fantastico. Primo disco dei Litfiba, super autoprodotto, Desaparecido. E poi via a suonare in Francia. Non so se posso dirlo, ma la Sony francese disse: “Ok, pubblichiamo questo capolavoro in Francia”. E diventammo più famosi in Francia, per tutti gli anni Ottanta, che in Italia.
C’è una scena del film, in un negozio di dischi in cui Francesco Magnelli, che poi suonò con i Litfiba, andò alla EMI e gli dissero che i Litfiba, per avere successo, avrebbero dovuto cambiare cantante…
Francesco, amico dall’infanzia, giocavamo a pallone insieme. Poi ci siamo ritrovati a suonare nella cantina con i Litfiba negli anni Ottanta, tra tecnologia, ricerche. E lui si sentì dire questa cosa qui da uno della EMI: «No, comunque fate musica che si vende solo per corrispondenza». Cioè, tradotto: “Fate merda, ma non ve lo voglio dire”. E aggiunsero: «Comunque, cambiate cantante». Che meraviglia. Le cose che si sentono… questo dice molto sul livello di preparazione di certi discografici italiani.
Qual è stato il tuo rapporto con la discografia italiana e con i discografici?
Io ho la fortuna di avere ancora oggi un contatto con Sony. Fortuna e anche un po’ di merito. Il presidente, Andrea Rosi, è stato il primo discografico italiano a credere in me e nei Litfiba. Per il secondo album che realizzammo, 17 Re, ci fece distribuire dalla Polydor, dove lavorava all’epoca. Ancora oggi è il mio riferimento discografico e con lui ho un bellissimo rapporto. Quindi devo dire che mi sono ritagliato anche rapporti interessanti.
Restiamo su 17 Re, perché dopo 40 anni tornate a suonare insieme con la formazione originale dei Litfiba. Dimmi la verità: è un’operazione-nostalgia, voglia di riconciliazione o convenienza?
Intanto è un dovere. Un album come 17 Re va festeggiato come si deve. E – mi ricollego a prima – è il frutto di tutte quelle tournée fatte in Francia, dove suonavamo nei festival internazionali con Stranglers, Iggy Pop, Violent Femmes, Tuxedomoon… gente che ha fatto la storia della musica. In Italia questa roba qui niente. 17 Re nasce da quelle esperienze ed è un album pazzesco, come gli altri due di quella trilogia: Desaparecido e Litfiba 3.
17 Re, tra l’altro, è un disco dedicato alle vittime del potere.
Totalmente. Come tutta quella trilogia.
Oggi chi vedi come vittima, e chi riconosci come potere?
Le vittime, oggi, senza ombra di dubbio, sono il popolo palestinese, il popolo del Sud Sudan, quello congolese, il popolo del Myanmar. Faccio solo quattro esempi. Sono massacrate da decenni, impunemente. E credo che, prima di diventare noi stessi vittime al loro posto – perché il potere si autoalimenta, è avido e, eliminate le minoranze scomode, poi tocca agli altri – dobbiamo stare molto attenti.
Spiegati meglio.
Bisogna essere come quei genitori che non hanno paura di farsi mandare a fare in culo dai figli perché vietano il cellulare o di rientrare alle quattro di mattina. Serve coraggio. Veniamo da un’epoca in cui ci siamo adagiati sui privilegi.
E cosa si può fare, secondo te?
Bisogna resettare e ricominciare a lottare per diritti che oggi sono di altri oppressi, ma domani saranno i nostri.
L’ultima volta che ti sei sentito coraggioso e l’ultima in cui non lo sei stato?
La questione del coraggio non mi appartiene molto. Quando ritengo giusto e onesto dire qualcosa, lo dico. Non sto a calcolare cosa succede nei palasport, nelle vendite o nei passaggi radio. Non me ne frega un cazzo. Ho il privilegio di stare dentro la musica da 45 anni. Un privilegio enorme. E lo voglio condividere con chi non ce l’ha. Come gli operai della GKN, licenziati come nell’Ottocento, con una totale privazione di diritti anche solo come individui, non dico come classe operaia. E figurati, guai a dire ormai queste cose: sennò saremmo dei veterocomunisti.
Quindi come ti poni?
Io di fronte a queste cose agisco, mi muovo, cerco di far parlare, di smuovere. Non lo chiamo coraggio: lo ritengo un dovere.
Nel film ti definisci rocker, non rockstar. Dici di aver conosciuto tante rockstar distanti. Chi sono?
No, no, no. Non te lo dico (ride, nda).
Come non me lo dici?
No, no, no. Ognuno fa quello che ritiene giusto. Io preferisco stare con i piedi per terra. Ho avuto un periodo in cui ho pagato il grande successo e ho capito dove ho sbagliato. E non lo rifarò mai più. Ero diventato un po’ più arrogante, un po’ più distaccato, ritirandomi spesso anche dall’ambiente in cui mi ritrovavo. Però poi, sostanzialmente, mi sono ritrovato anche giustamente abbastanza isolato. Quindi: mai più quegli errori. Mai più. Ora mi sento parte di una comunità.
Restiamo su questo tema. Negli anni Ottanta i Litfiba sembravano immortali. Quando hai sentito invece per la prima volta che non lo eri?
Ti dico la verità: in realtà siamo sempre stati molto fragili. Eravamo molto diversi tra di noi. Estremamente differenti, anche con l’età. Io sono il più piccolo, sono il cucciolo della band. Tra me, Gianni, Antonio… Ringo era della mia età, anzi aveva un anno meno di me, il povero Ringo. Però tra noi e Ghigo passano moltissimi anni. Quindi siamo una band un po’ particolare.
E queste differenze si sono fatte sentire un bel po’…
Abbiamo condiviso viaggi, esperienze… poi piano piano sono venute fuori le diversità. In questi casi o c’è un grandissimo manager che tiene tutto come un grande allenatore, oppure ciao.
In pratica così è stato. Per anni tu e Ghigo eravate un po’ come due pianeti che collidono. Ma adesso è vera pace, tregua armata o altro?
Poi ci siamo riallontanati… ma sai, certe diversità non le puoi cancellare. Bisogna accettarle, basta. È giusto che ognuno abbia anche il suo spazio, è fondamentale. Molte cose che abbiamo rifatto insieme non sono nate per calcolo, ma per necessità di sopravvivenza comune. E va bene così, perché quando si suona ci si diverte sempre.
Dimmi una cosa: ma in Italia il rock è morto?
No, è come Dracula, un “non morto”. Anche sul rap si diceva fosse morto. Un certo rock non è morto, io ci credo ancora. Il concerto S.O.S. Palestina fatto a settembre, con tanti amici come Zen Circus, Emma Nolde, Roy Paci e tutti gli altri significa che c’è ancora tanta gente che ci crede. Un rock che abbia anche un certo peso umano c’è.
Se ti dico Sanremo?
Rispondo “scippo”.
Quella cosa dello scippo della borsetta alla signora del pubblico fu indimenticabile. Ti sei pentito di aver partecipato?
No, assolutamente no.
Torneresti in gara?
In quell’occasione ci stava. La canzone Gigante era molto bella, infatti è diventata un classico mio. La suono con grande soddisfazione. Parlava, prima di Mare fuori, dei ragazzi di Nisida, del minorile di Napoli. Anche di questo mi fregio. Ne vado fiero.
Ok, ma ci torneresti?
Mah, non lo so. Come ti dicevo non sono un grande calcolatore, ma se avessi una canzone nella quale credo, come Gigante, che trattava il tema della rinascita, essendo convinto di quello che ho scritto potrei anche tornarci.
Magari con i Litfiba…
Non lo so, non lo so (ride, nda). Guarda, con i Litfiba è sempre complicatissimo prendere decisioni.
Torniamo al film. Il “rumore dentro” del film è anche quello dell’acufene. Giusto?
Soprattutto quello, e tutto il disagio che ne consegue. Il mio acufene, a oggi, novembre 2025, è incurabile: è derivato da un fortissimo shock acustico. La ricerca ha fatto poco, purtroppo. Parliamo di andare su Marte, ma non abbiamo ancora una cura per gli acufeni che colpiscono milioni di persone.
Anche altri tuoi colleghi ne soffrono.
Caparezza ne soffre per motivi diversi dai miei, ma anche lui tanto. Anche Francesco Bianconi dei Baustelle ha avuto un trauma acustico, spero abbia risolto.
Il tuo è ancora molto forte?
Purtroppo sì. L’ho avuto nella situazione peggiore: nel silenzio anecoico di uno studio, con entrambe le cuffie, mi parte un boato in una sola orecchia. Da –40 dB passi a +130 dB in una frazione di secondo: è come un cannone che ti spara. È veramente incredibile che, con la microtecnologia che c’è oggi, non si sia riusciti a elaborare un sistema davvero efficace.
Parlando dell’acufene, tu dici che di giorno i rumori lo attutiscono un po’, ma di notte ritorna come certi fantasmi. Quali sono i fantasmi che tornano sempre da te?
I fantasmi dell’insicurezza, perché quello che vivevo da ragazzo non ho mai smesso di viverlo: questa precarietà, che in fondo è anche quella del nostro lavoro, che è precario per definizione. Non sono solo nomade, ma proprio precario. E poi il fantasma di non essere stato un cittadino abbastanza attento.
Cioè?
Anche io mi sono adagiato sui miei privilegi e ho lasciato correre tante cose. Oggi ci ritroviamo con una situazione italo-europea che bisognava tenere molto più sotto controllo, spingendo per politiche realmente a favore dei cittadini e meno delle lobby. Non serve nemmeno andare fino a Trump, la Cina o Putin.
Tornando alla musica: chi ti piace e chi non ti piace della nuova generazione italiana?
Mi piacciono le band che vengono dal basso. Devo dire che Firenze mi sta stupendo: è nata una generazione di gruppi punk interessanti e lo dico da punkettaro. Ci sono gruppi, in area fiorentina e toscana, veramente ganzi. Tipo gli Spleen hanno l’età di mia figlia Zoe e sono davvero bravi. Me li sono portati in giro nel primo pezzo del tour: hanno aperto loro tutti i concerti e sono piaciuti anche al mio pubblico. Ragazzi di 19-20 anni, ma determinati, punk, grunge. Questo mi fa molto piacere, perché Firenze, dopo la Bandabardò, non aveva più tirato fuori nulla di davvero eccitante. Negli ultimi cinque anni qualcosa si è mosso.
Chi non ti piace?
Chi non mi piace non lo ascolto proprio. Il 90% di quello che sento mi fa esattamente cagare. Però, se poi mi ascolto l’ultimo album degli Zen Circus godo, sto bene. Perché devo ruminare su quello che mi fa cagare?
Hai fatto The Voice of Italy, ma un talent lo rifaresti?
Se è un talent intelligente, perché no? È un po’ impegnativo, perché quando feci The Voice non avevo più tempo per fare musica e suonare in giro. Però ci può stare, se fatto con altre persone “ganze” con cui interagire.
Anche se c’è da dire che The Voice non ha mai lanciato nessuno.
Te lo dico io perché.
Prego.
Personalmente avevo cantanti fortissimi. Giacomo Voli, Timothy Cavicchini erano bravissimi. Scrissi anche canzoni per loro, rimasero in classifica qualche settimana… ma la casa discografica che aveva il contratto in esclusiva con loro – la Universal – non fece niente, tranne che per Suor Cristina. Ormai ex suora. Quindi non ci fu impegno da parte della discografia.
Se ti dovessi descrivere oggi alle nuove generazioni, chi è Piero Pelù?
Il babbo del rock’n’roll.