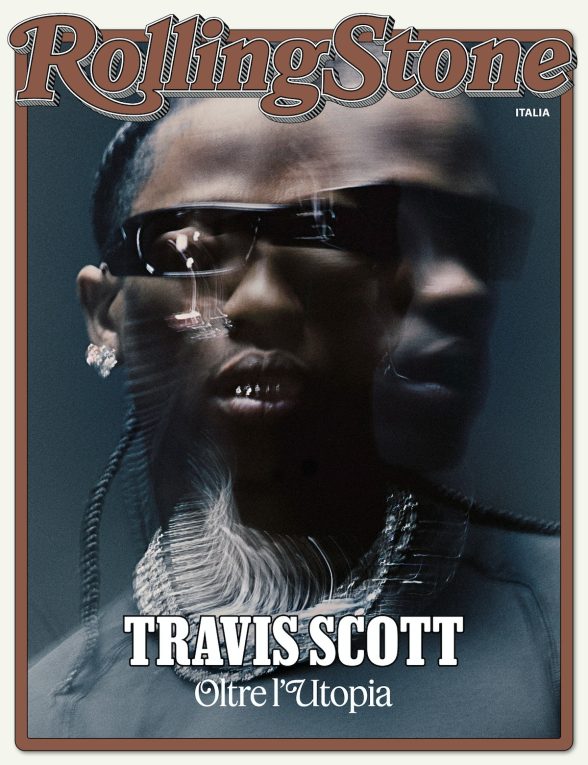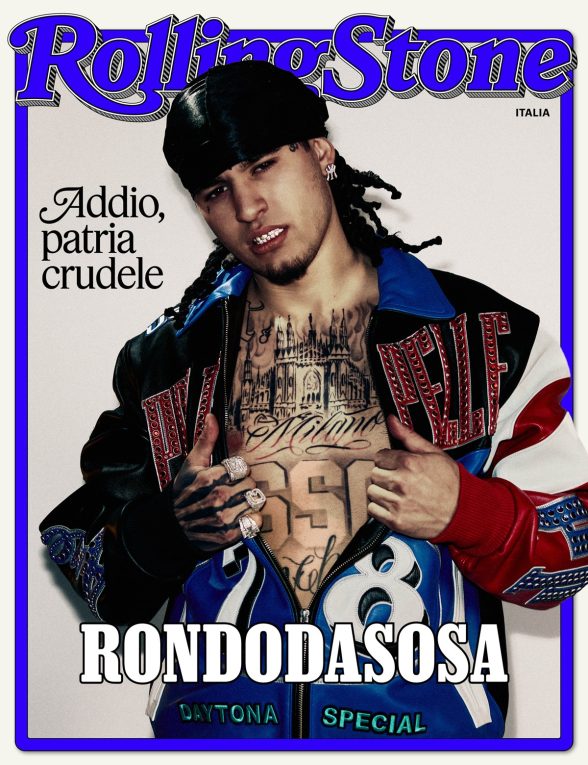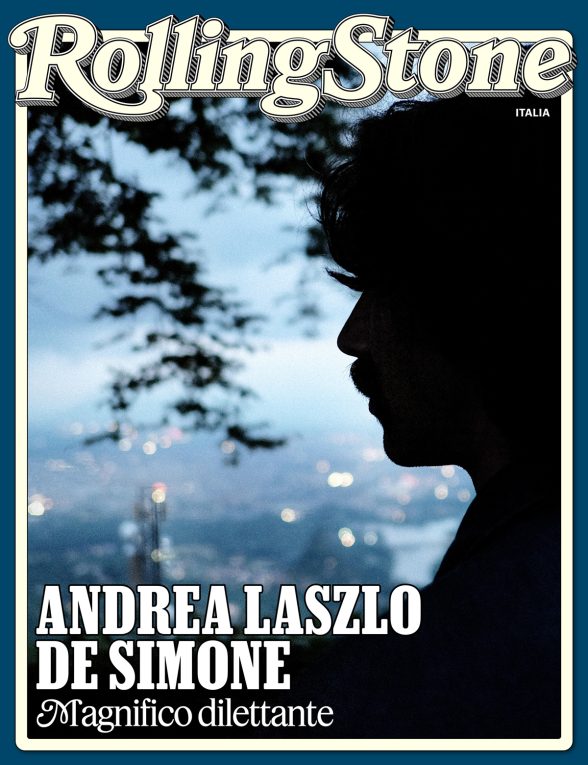Gorillaz, affamati di futuro
La band ha festeggiato il quarto di secolo con una mostra e una serie di concerti in cui ha rifatto tre dischi vecchi e presentato quello nuovo. In questa intervista Damon Albarn e Jamie Hewlett spiegano perché non è un’operazione nostalgica e come mai dopo tanti anni le loro idee e il loro linguaggio sono ancora attuali
I Gorillaz e i loro creatori Jamie Hewlett e Damon Albarn. Foto: Gorillaz
Mica facile arrivare al traguardo dei 25 anni d’attività se sei un creativo che preferisce non «indugiare troppo nella nostalgia», come dice Jamie Hewlett, co-fondatore dei Gorillaz e visual artist. Ma a quanto pare anche chi non ha grande simpatia per i ritorni al passato non può fare a meno di commuoversi un po’.
«Non per autocitarmi, ma la vita moderna è effettivamente una schifezza», dice Damon Albarn a proposito di come vanno le cose per i nuovi artisti e delle sfide che una quarantina d’anni fa forse non esistevano: la mancanza dei piccoli locali, la pressione per produrre contenuti, i colossi dell’industria che assorbono risorse e non ridanno indietro nulla. «Ora sì che sto diventando nostalgico», dice. «Gli anni ’80 sono stati un periodo meraviglioso per i musicisti giovani. C’erano tantissimi posti dove suonare, e potevi frequentare l’art school. È mai stata fatta musica migliore di quella creata dagli outsider delle scuole d’arte?». Il futuro, conclude, non è altro che la somma «leggermente in decomposizione» di tutto ciò che è stato.
È dal principio degli anni 2000, quando hanno lanciato i Gorillaz, che Albarn e Hewlett guardano avanti e mai indietro. Per celebrare i 25 anni della band hanno però inaugurato a Londra una mostra, House of Kong, e fatti una serie speciale di concerti unici in cui hanno suonato integralmente i primi tre album, prima del Mystery Show finale.
Ma è il massimo sguardo al passato che i due vogliono concedersi visto che i Gorillaz hanno sempre incarnato la ricerca incessante del nuovo. Stremato dalle prove dei concerti, Albarn ammette su Zoom che a quanto pare ha sempre tre progetti in ballo contemporaneamente; Hewlett, un’ora avanti essendo in Francia, si concede una chiacchierata veloce e una sigaretta, già calato mentalmente nella sua prossima opera.

I primi Gorillaz, ai tempi del singolo del 2001 ‘Clint Eastwood’. Foto: Gorillaz
Cresciuti negli straordinari anni ’80 di cui parla Albarn, i due hanno avuto successo nel decennio successivo, Albarn coi Blur e Hewlett grazie a Tank Girl. Alla fine del decennio erano entrambi disillusi da quel che era diventato il pop: la lad culture e il Brit pop avevano fatto il loro tempo e avevano lasciato poco spazio alla sperimentazione e si era nel pieno del boom delle boy band di MTV costruite a tavolino.
Dal loro appartamento al primo piano di un edificio di Notting Hill, a ovest di Londra, hanno tirato fuori un’idea: usare il principio dei ghostwriter tipico delle star da MTV per farne qualcosa di trasgressivo e significativo, creare insomma una band priva di presenza fisica immersa in un mondo colorato. Una band che sarebbe esistito quasi esclusivamente sul loro sito, con tanto di interviste inventate di sana pianta. «Era» ricorda Albarn «un modo per fare satira sul pop o comunque la direzione che il pop stava prendendo, cercando al tempo stesso di fare qualcosa di autentico».
«Nel dna dei Gorillaz c’era già un bel pezzo di cultura pop contemporanea»
Damon Albarn
Sono nati così quattro outsider animati, nonché un’idea rivoluzionaria nell’internet musicale dei primi anni 2000: i Gorillaz. C’erano Murdoc Niccals, il bassista sdentato e leader; 2-D, il frontman e tastierista timido; Noodle, chitarrista giapponese prodigio di 10 anni; e Russel Hobbs, batterista corpulento in grado di evocare «i fantasmi dei rapper morti». Il quartetto ha pubblicato l’omonimo album d’esordio il 26 marzo 2001, portando al grande pubblico il singolo Clint Eastwood featuring Del the Funky Homosapien.
«Ai tempi del primo album c’era la sensazione che fosse una specie di scherzo, una cosa per ragazzini che nessuno voleva prendere sul serio», ricorda Hewlett. «Gli appassionati apprezzavano la musica, ma non i cartoni. I ragazzini invece si divertivano con i cartoni e, grazie ad essi, arrivavano alla musica, e poi attraverso la musica scoprivano artisti che altrimenti non avrebbero mai conosciuto tipo Bobby Womack, Ibrahim Ferrer o Beck». L’idea collaborazione è stata sempre al centro del progetto. «È quello che siamo», conferma Albarn.

Ai tempi di ‘Demon Days’. Foto: Gorillaz
Una volta arrivati al secondo album, Demon Days del 2005, il format che avevano ideato era diventato dominante: ogni canzone infatti aveva un ospite, nel bene o nel male. «Probabilmente nel male», dice Albarn ridendo. Non che fosse un’idea inedita, basti pensare ai Massive Attack o all’incontro tra Aerosmith e Run-DMC, ma Demon Days esplorava il concetto in un modo «strano, pop ma bizzarro».
Il successo del disco ha fatto capire quanto quel formato era appetibile. Oggi le collaborazioni tra artisti pop mainstream sembrano fatte per i social o guadagnare titoli. I Gorillaz invece hanno continuato a lavorare puntando sull’empatia, promuovendo scambi con «storie vere dietro». Per Albarn, i Gorillaz sono stati anche la porta d’ingresso a un mondo che conosceva poco, quello dell’hip hop. Da allora ha lavorato con rapper come il compianto MF Doom, i De La Soul e Snoop Dogg.
«Incredibile, davvero», dice. «Ho imparato tantissimo. Quando fai musica assieme ad altri entri nella loro storia personale, è un’esperienza intima. Ti metti a nudo. Per fare musica vera devi essere aperto col prossimo».
È un’idea che avevano affrontato fin nel manifesto originale scritto in occasione del lancio della band, un foglio di carta che purtroppo si è perso. In quel testo, il potere speciale di cui era dotato Russel era l’idea ancora vaga che si potesse collaborare con chiunque. «In un certo senso è lungimirante perché precede gli ologrammi e il resto», dice Albarn. «Suppongo che nel dna dei Gorillaz ci sia un bel pezzo di cultura pop contemporanea. Ma non voglio lodarmi da solo, meglio che lo facciano gli altri».
Lieti di accontentarlo…

L’era di ‘Plastic Beach’. Foto: Gorillaz
Pur essendo stata in principio snobbata perché considerata un prodotto dell’industria musicale, la band ha pubblicato otto album in studio, due documentari, ha organizzato un festival, ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, pubblicato due libri ed è persino entrata nel Guinness dei primati in quando «band virtuale che ha venduto di più nella storia». I Gorillaz sono stati anche pionieri nello sfruttamento dei media digitali, dell’animazione e di internet al fine di costruire una realtà virtuale, conquistando una fanbase fedele nel tempo. E poi c’è la questione del numero sbalorditivo di collaboratori di varie generazioni, con gente che viene dai mondi dell’animazione, del cinema, dalla tv e ovviamente della musica. Hanno coinvolto attori celebri, incluso un cameo del compianto Dennis Hopper in Fire Coming Out of the Monkey’s Head. Nel sesto album The Now Now (2018) hanno persino messo in piedi un crossover con le Superchicche: Murdoc era in prigione ed è stato temporaneamente sostituito da Ace, leader della Banda dei Verdastri.
La comunità si è ampliata ulteriormente dal punto di vista sonoro grazie a leggende e nuove star, da Grace Jones, Elton John, Mavis Staples, Clash e Terry Hall a Little Simz, Kano, Jpegmafia e altri ancora (tutta gente «che a un certo punto ho abbracciato», ride Albarn stupito). La capacità di Hewlett di adattare i disegni allo spirito digitale e virtuale del tempo gli ha permesso di continuare a costruire una narrativa vasta e coinvolgente. E Albarn, con la sua pressoché patologica ossessione di creare, imparare e collaborare, è sempre in cerca di nuovi suoni. Così i Gorillaz appaiono ancora oggi rilevanti e necessari quanto lo erano a inizio millennio.
«Non crediamo più in quel che dicono i politici, cerchiamo ispirazione altrove»
Jamie Hewlett
Un quarto di secolo dopo Albarn, che ora ha 57 anni, ammette che gli riesce difficile accettare di «non essere più un artista al centro del pop» in senso lato. E però i personaggi animati, sempre coerenti e senza età, ci hanno permesso di affrontare le incertezze del mondo senza sottostare agli standard severi che imponiamo agli esseri umani in carne e ossa. È un punto che Hewlett cerca di dimostrare da tempo con le sue creature.
«Sentivo che erano importanti, ci sono cresciuto assieme, sapevo che erano adatti anche agli adulti». Cita Miyazaki e film come Akira, coi loro temi adulti e trame potenti nonostante le connotazioni infantili del disegno animato. È un approccio che i Gorillaz hanno fatto loro affrontando in maniera sottile temi socio-politici: Demon Days evocava le ansie del mondo dopo l’11 settembre, Plastic Beach (2010) parlava d’ambiente, Humanz (2017) catturava l’incertezza del clima politico all’inizio dell’era Trump.

Foto: Gorillaz
«Venticinque anni dopo viviamo in un’epoca in cui personaggi animati e avatar fanno parte eccome delle nostre vite, specialmente per le nuove generazioni che vivono anche attraverso i videogiochi, indossano skin, fanno cosplay», dice Hewlett. È notevole il fascino esercitato da questi mondi virtuali sui giovani, per i quali la vita reale è diventata talmente sgradevole da non volerci avere nulla a che fare. Si sentono decisamente più a loro agio negli spazi virtuali. «Che sia una cosa positiva o meno», scherza, «è comunque meglio che drogarsi». Attraverso i personaggi «puoi coinvolgere i giovani e se ci riesci ci sono grandi cose che puoi insegnare loro attraverso musica, animazione, storie, dichiarazioni politiche». E mentre Hewlett nutre riserve sull’impatto dei social (Albarn figuriamoci, manco possiede un telefono), è la lente che gli permette di notare una qualità sorprendente del pubblico più giovane.
«Quando si appassionano a qualcosa, ci si buttano dentro e si informano su ogni singola cosa. Quando posto qualcosa seguo le conversazioni online e scopro che ne sanno loro più di me su ciò che ho fatto io. Sanno tutto, accidenti. Si immergono negli argomenti in profondità ed è una cosa bellissima. Credo che preferiscano ascoltare quello che ha da dire Cartman di South Park piuttosto che quello che dice Keir Starmer, capisci? Siamo arrivati a questo punto. I politici mentono. Non ci crediamo più, quindi troviamo forza e ispirazione altrove».

I Gorillaz nel mondo reale, a Piccadilly Circus. Foto: Gorillaz
L’8 agosto la Copper Box Arena di Stratford, Londra, ha aperto le porte a House of Kong, «una mostra senza precedenti» secondo Murdoc Niccals. L’impianto sportivo costruito per le Olimpiadi del 2012 è stato in parte adattato per ospitare un’esperienza immersiva e interattiva, e celebrare il quarto di secolo dei Gorillaz. Lì ho incontrato un padre e un figlio che incarnavano bene l’idea del fascino senza tempo esercitata dai personaggi animati.
Bartek Szwejkowsky, 44 anni, ha conosciuto la band lavorando in un club nei primi 2000. Suo figlio Oliver, che di anni ne ha 13, l’ha scoperta grazie al padre. «La cosa straordinaria dei Gorillaz», dice l’uomo, «sono le grafiche. Non si tratta solo di musica, ma anche dell’esperienza che la accompagna». Trova «incredibile» che dopo 25 anni riescano ancora a catturare l’interesse dei più giovani. Quando lo riporto a Hewlett e Albarn, sembrano entrambi sinceramente toccati e si concedono (per un attimo) un po’ di soddisfazione. «Sono cose del genere che danno un senso a quello faccio, lo adoro», dice Hewlett. Quand’è nata la band, entrambi avevano figli piccoli e volevano creare qualcosa che piacesse anche a loro. «Credo che la cosa più bella dei Gorillaz sia che piacciono sia ai genitori che ai bambini, è una cosa di cui vado orgoglioso», aggiunge Albarn.
La mostra è stata ideata dai tipi di Swear (le menti dietro Dismaland di Banksy e il Block9 di Glastonbury) ed è rimasta aperta per quattro settimane. Nei quattro concerti successivi la band ha riproposto i primi tre album con gli spettacoli originali dell’epoca. E per chiudere la residency e i festeggiamenti, c’è stato un ultimo Mystery Show di cui al momento dell’intervista non sono stati rivelati i dettagli.

House of Kong. Foto: @shotbyphox
Per Hewlett e Albarn, è il limite massimo di ciò che considerano accettabile per celebrare il 25° anniversario senza «spremere troppo il tutto», come dice il primo. Fedeli alla loro natura, anche mentre parlano delle celebrazioni pensano più al futuro che al passato. «Fare dal vivo questi dischi, ciascuno nel proprio contesto e praticamente seguendo la scaletta originale, non sembra una cosa nostalgica», dice Albarn. «È una retrospettiva, che è una cosa diversa. È diversa perché non è intrattenimento, ma la presentazione di un’opera». È in questo modo che Albarn si è convinto che fosse accettabile concedersi questa eccezione.
Non ascolta più la sua musica una volta che l’ha completata, anche perché doverla riascoltare ossessivamente fino al mastering ne distrugge il mistero. «Finisci per conoscere ogni minimo ingranaggio che ci sta dietro». Eppure, riascoltando i tre album in vista dei concerti, non ha potuto non notare come il suo sé attuale influenzi il modo in cui stanno suonando il primo disco.
«La cosa bella dei Gorillaz è che piacciono sia ai genitori che ai figli»
Damon Albarn
Il progetto Gorillaz è nato prima che Albarn iniziasse a viaggiare nel mondo, passando molto tempo a fare musica in Africa. È uscito trasformato dagli incontri con quei «musicisti fuori dall’ordinario». «Nel primo disco provavo cose che ora posso fare da solo. Posso suonare quei ritmi, non devo ricrearli con trucchetti o campionamenti. È interessante. Non è drasticamente diverso, ma credo che sia… non so… qualsiasi cosa sia successa non è male».
Altre cose non sono cambiate poi molto, con suo stessa stupore. «Non riesco a credere di poter ancora arrivare al falsetto», scherza a proposito del debutto. «Quel primo disco ne ha una quantità pazzesca». E aggiunge che la cosa era «decisamente legata alle droghe che prendevo. Ero molto più irresponsabile allora. Raggiungevo note che non avrei mai pensato di poter rifare». Con l’età è arrivato il senso di responsabilità e smettere di fumare un anno e mezzo fa gli ha dato «maggiori possibilità» vocali.

House of Kong. Foto: @shotbyphox
Hewlett giustifica la mostra e i concerti nello stesso modo: è un promemoria di quel che è successo in questi 25 anni e non un esercizio nostalgico. «La nostalgia non m’interessa, anche se per alcuni è una droga potente. Non m’importa di quel che hai fatto 25 anni fa». Cita David Hockney come suo guru, un artista che a 85 anni cambia ancora stile e idee, sempre «un passo avanti ogni volta che espone». Eppure facendo un giro alla mostra non ha potuto fare a meno di provare un pizzico di orgoglio, prima di rimangiarsi tutto e dire che «quando inizio un lavoro ho in testa l’immagine di quello che voglio disegnare, ma quello che finisco per mettere su carta non è mai altrettanto buono».
L’artista insegue l’immagine perfetta che ha in testa, ma non riesce mai del tutto a raggiungerla. A ogni tentativo ci si avvicina un po’ di più. «Credo sia per questo che voglio continuare, non sono ancora del tutto soddisfatto. Devo fare di meglio, senza per questo torturarmi». Lui e Albarn hanno una relazione quasi simbiotica quando si tratta di cercare il nuovo e la perfezione. «C’è sempre qualcosa da fare», dice il cantante a proposito della chiusura di un disco. «Ma devi finirlo, non hai scelta, a un certo punto devi andare avanti e affrontare il progetto successivo».
«Se potete esserci, siete i benvenuti, ma dopo si torna alle cose nuove», conclude Hewlett parlando delle celebrazioni del 25° anniversario. Quali cose nuove? «Per me e Damon è tutto divertimento. Possiamo fare quel che vogliamo. Damon può comporre la musica che desidera. Non è più in una band, è libero di sperimentare», dice Hewlett, prima di riassumere il manifesto rivoluzionario dei Gorillaz in una sola frase: «Se hai delle idee, vai avanti».