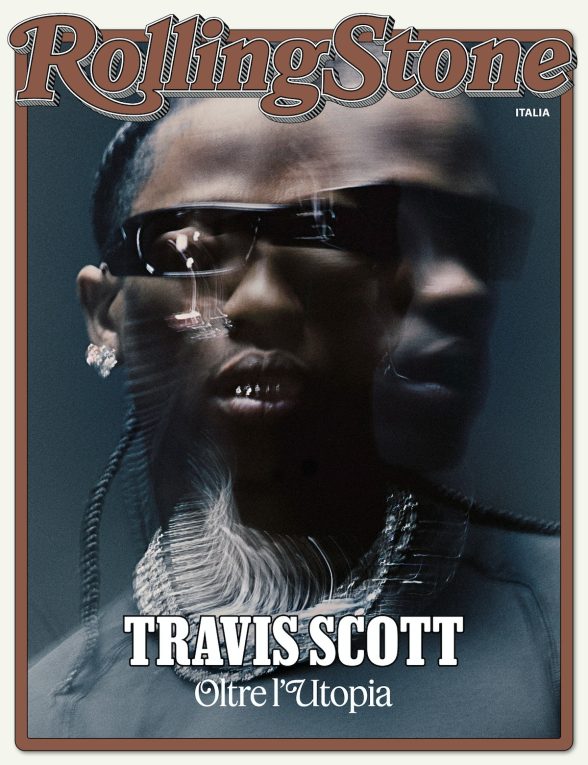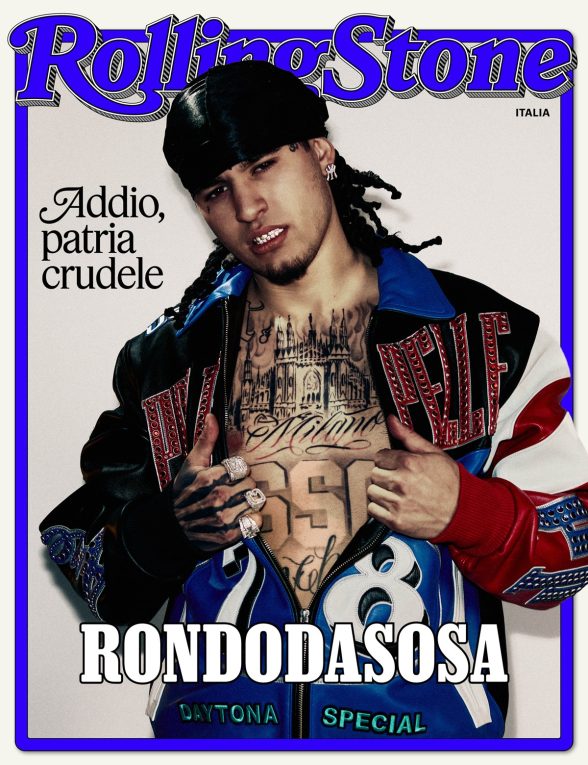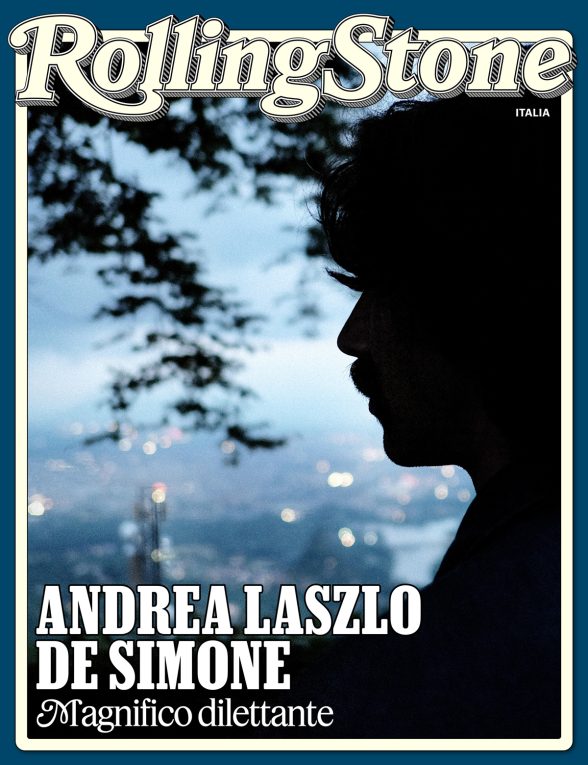Come sta il cinema nel mondo?
Dall’Iran al Brasile, dal Libano alla Spagna: viaggio nelle cinematografie più interessanti di oggi, raccontate da alcuni dei più grandi Autori contemporanei
Jafar Panahi, Rodrigo Sorogoyen, Nadine Labaki e Walter Salles ritratti da Alessandro Ventrella per Rolling Stone
Un estratto dal numero speciale di Rolling Stone, Il Cinema, in edicola dal 25 agosto e disponibile nello store online.
JAFAR PANAHI - IRAN

Jafar Panahi. Illustrazione di Alessandro Ventrella per Rolling Stone
Nato a Mianeh, in Iran, nel 1960, ottiene la fama internazionale già con il suo primo lungometraggio, Il palloncino bianco (1995), vincitore della Caméra d’or a Cannes. Seguono poi Lo specchio (Pardo d’oro a Locarno 1997), Il cerchio (Leone d’oro a Venezia 2000) e Offside (Orso d’argento – Gran Premio della Giuria a Berlino 2006). I suoi film, spesso censurati in patria, sono stati realizzati nonostante numerosi arresti e restrizioni. Nel 2010 è stato condannato a sei anni di prigione (per propaganda contro il governo iraniano) e a un divieto ventennale di fare cinema, lasciare il Paese e concedere interviste. Nel 2011 ha girato clandestinamente This Is Not a Film, una sorta di video-diario contrabbandato fuori dall’Iran nascosto in una torta e presentato a Cannes. Nel 2013 ha vinto l’Orso d’argento per la sceneggiatura con Closed Curtain, nel 2015 l’Orso d’oro per Taxi Teheran e nel 2018 ha presentato sulla Croisette Tre volti (Prix du scénario). Arrestato di nuovo nel luglio 2022, non ha potuto ritirare il Premio speciale della giuria a Venezia 79 per Gli orsi non esistono, ed è stato poi liberato nel febbraio 2023. Il suo nuovo film, Un semplice incidente, ha conquistato la Palma d’oro a Cannes 2025 e arriverà nelle sale italiane a novembre.
Nonostante le restrizioni interne, il cinema iraniano continua a essere una forza artistica, vitale e influente sulla scena mondiale. La critica internazionale ne riconosce e ne elogia spesso l’autenticità e la resilienza. Culturalmente, non viene percepito come un riflesso del governo, ma più come una potente espressione di una società sotto pressione. Una voce per chi non ha spazio per essere ascoltato.
La sua forza sta nel modo in cui affronta senza paura i tabù. I giovani registi di oggi, armati di nuovi linguaggi cinematografici, piccole videocamere e budget ridottissimi – ma dotati di grande coraggio – portano alla luce ciò che troppo spesso resta invisibile. Parlano di lotte umane e bisogni fondamentali attraverso uno storytelling non lineare, strutture narrative frammentate, forme ibride che fondono documentario e finzione e che sono diventate la norma.
Personalmente, ho sempre visto il cinema come un archivio del reale ma anche come un luogo dell’immaginazione. In un contesto in cui tante forme di espressione vengono bloccate, l’unica strada possibile è creare storie radicate nella realtà, ma capaci di oltrepassare la censura. Il mio obiettivo, da sempre, è rendere la macchina da presa un testimone. E fare in modo che le persone che filmo non vengano mai rappresentate semplicemente come buone o cattive.
Malgrado l’immensa pressione a cui è sottoposto, il cinema iraniano ha trovato una voce potente pur all’interno della repressione, diventando una parte vitale della conversazione globale su libertà, verità e resistenza. Questo dialogo è guidato in gran parte dai registi stessi invece che dalle istituzioni. Siamo, in molti sensi, delle isole sparse, impegnate in uno scambio diseguale attraverso film che spesso non sono nemmeno autorizzati a essere proiettati nel nostro Paese. E questo, di per sé, è già un atto di resistenza. Perché censura ufficiale, permessi di produzione, autorizzazioni per le proiezioni, divieti in post-produzione, interferenze della sicurezza, arresti, restrizioni nei viaggi e pressioni su attori e troupe fanno parte della realtà quotidiana dei filmmaker in Iran. Ma la sfida più insidiosa resta l’autocensura, quando è la paura a spegnere la creatività ancora prima che la macchina da presa cominci a girare.
Eppure, negli ultimi anni, molti giovani registi indipendenti si sono silenziosamente e audacemente spinti oltre quei limiti con il cinema underground. Soprattutto dopo la nascita del movimento “Donna Vita Libertà”, la loro presenza è diventata ancora più forte e determinata. Non si limitano a esprimere una speranza di cambiamento: immaginano un futuro diverso. Il nostro cinema continua a sfidare la narrazione ufficiale del governo, tenendo in vita il racconto degli emarginati: le donne, i dimenticati, i manifestanti. Laddove la storia ufficiale cerca di cancellare, il cinema indipendente resiste per farci ricordare.
In tutto questo, ciò che più mi ispira oggi è la resilienza di una generazione che, nonostante la pressione costante, si rifiuta di posare la macchina da presa e crea immagini potenti anche di fronte al pericolo. Non ho dubbi: questa nuova generazione è più coraggiosa e creativa di quanto noi non siamo mai stati.
WALTER SALLES - BRASILE

Walter Salles. Illustrazione di Alessandro Ventrella per Rolling Stone
Nato a Rio de Janeiro nel 1956, si impone sulla scena internazionale con Central do Brasil (1998), che conquista moltissimi premi, fra cui anche l’Orso d’oro a Berlino, il Golden Globe e il BAFTA per il miglior film straniero, oltre a due nomination agli Oscar. Il suo più grande successo di pubblico e critica arriva nel 2004 con I diari della motocicletta (2004), biopic sul giovane Che Guevara (interpretato da Gael García Bernal), premiato anche con l’Oscar per la miglior canzone originale (Al otro lado del río). Nel 2024 firma la sua opera più intima e personale, Io sono ancora qui, che ottiene tre candidature agli Academy Awards – miglior film, miglior attrice (Fernanda Torres) e miglior film internazionale – vincendo l’Oscar in quest’ultima categoria.
Un cinema nazionale diventa forte e rappresentativo solo quando i giovani registi lo ridefiniscono anno dopo anno, mentre autori di altre generazioni continuano a offrire molteplici riflessioni sul Paese. È quello che è accaduto al cinema brasiliano negli ultimi due anni.
I premi ricevuti da Kleber Mendonça Filho per L’agente segreto a Cannes (Miglior regista per Kleber e Miglior attore per Wagner Moura) e da Gabriel Mascaro per Il sentiero azzurro a Berlino (Orso d’argento) si aggiungono al riconoscimento ottenuto da opere prime e seconde a Venezia e Cannes lo scorso anno, come Manas di Mariana Brennand e Baby di Marcelo Caetano. Poi sono arrivati i premi FIPRESCI, così come i premi del pubblico. È ancora troppo presto per definirlo un movimento pienamente formato, com’è successo con il cinema iraniano o sudcoreano negli ultimi decenni, ma possiamo già sognare il bicchiere mezzo pieno…
Per quanto mi riguarda, in sostanza i film che realizzo cercano di rispondere alle domande sollevate per la prima volta dal Cinema Novo, il nostro principale movimento cinematografico degli anni ’60: chi siamo, da dove veniamo, che tipo di futuro vogliamo? Il Cinema Novo era un movimento che proiettava sullo schermo il desiderio di un Paese libero e indipendente, definito dai nostri stessi criteri estetici. Nato dalla confluenza del Neorealismo italiano di Rossellini e del montaggio di Eisenstein, il Cinema Novo fu brutalmente interrotto dal colpo di stato militare del 1964. Durò 21 anni.
Il Brasile ha recentemente attraversato anni traumatici durante il regime di Bolsonaro (2018-2022). È naturale che queste questioni centrali, legate all’identità mutevole del Paese, siano riemerse. Diciamo che cerco di aggiungere a questa equazione qualcosa che ho imparato da Nelson Pereira dos Santos ed Ettore Scola. Ho pensato a C’eravamo tanto amati e a Una giornata particolare prima di girare Io sono ancora qui. E a Vidas secas di Nelson Pereira dos Santos, che ci insegna come raccontare una storia senza usare aggettivi.
(Ho anche provato a fare qualcosa di molto specifico in Io sono ancora qui: cercare, per quanto possibile, di ridurre la distanza tra lo spettatore e i personaggi che palpitano sullo schermo. Proprio come sono stato invitato a far parte della famiglia al centro del film quando ero adolescente, ho cercato di estendere lo stesso invito al pubblico. I momenti silenziosi, non verbali e le interpretazioni misurate degli attori hanno creato veri e propri varchi d’ingresso in modo che lo spettatore non vedesse quella famiglia da lontano, ma si sentisse parte di essa).
Tra i punti di forza e i tratti distintivi del cinema brasiliano attuale forse c’è un desiderio più o meno consapevole di trasgredire le regole, diventate sempre più comuni e stereotipate con l’avvento dello streaming. I film brasiliani che hanno avuto successo nei festival o nelle sale cinematografiche hanno qualcosa in comune: lasciano che il tempo faccia il suo corso, non cercano di accelerare artificialmente la narrazione, accolgono tagli narrativi più bruschi e si astengono da spiegazioni o interpretazioni. Come nella samba o nel jazz, c’è anche il piacere di esercitare la curiosità e di allontanarsi dal tema centrale, rendendo questi film più polifonici e meno prevedibili. Nel cinema brasiliano contemporaneo, avverto un desiderio più o meno consapevole di sfuggire alle forme narrative tradizionali.
E sì, questo porta a film che non parlano di un solo argomento, ma di tanti. Tendono a essere opere polisemiche, che esplorano territori diversi. L’agente segreto, ad esempio, è allo stesso tempo un film sull’assenza di una madre e sulla perdita di un padre, su come una dittatura militare corroda la società, un grande thriller, una lettera d’amore al cinema. E un film brillante sulla geografia umana di una città: Recife. Tutti questi temi sono articolati magistralmente. Il risultato: il film è lungo 2 ore e 40 minuti, ma sembra durare soltanto 1 ora e 40. Quando ho parlato con Kleber, l’ho ringraziato per quello che ha creato, menzionando, tra le altre cose, la generosità che guida la sua narrazione. Questa è un’altra caratteristica di gran parte del cinema brasiliano.
Se dovessi individuare temi particolari, tendenze estetiche o forme narrative che vedo emergere sarebbero una sorta di impurità, di desiderio di articolare diverse possibilità, di evitare di scrivere o girare in modo lineare. Il cinema è indiretto, come disse una volta un maestro brasiliano degli anni ’30, Mário Peixoto, creatore di Limite, un film d’avanguardia restaurato dalla Film Foundation di Martin Scorsese.
La nostra instabilità politica però è la principale sfida che dobbiamo affrontare, perché può bloccare la produzione cinematografica in qualsiasi momento. Ma questo, purtroppo, sta accadendo in sempre più Paesi. Penso a quello che purtroppo sta succedendo al cinema argentino, che ammiro profondamente. Nonostante questo, in Brasile ci sono molte voci uniche: da brillanti giovani registi indigeni come Mozarniel Ɨramari, della Nazione Yanomami, e giovani documentaristi come Carol Benjamin, a movimenti collettivi come quelli del Minas Gerais attorno alla casa di produzione Filmes de Plásico, dove collaborano André Novais Oliveira e Gabriel Martins (tra molti altri), e del Pernambuco attorno a diverse case di produzione indipendenti, tra cui quelle di Kleber Mendonça Filho e Gabriel Mascaro.
Ci sono anche voci di talento come Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, così come i giovani registi dei film recentemente premiati dall’Accademia del Cinema Brasiliano: Pedro Freire per Malu, Luciano Vidigal per Kasa branca, Marcelo Caetano per Baby ed Érico Rassi per Oeste outra vez. Sono film brillanti, interpretati da grandi attori, molti dei quali esordienti. Questa lista potrebbe essere dieci volte più lunga, il che dimostra quanto sia promettente questo momento per il cinema brasiliano.
Il riconoscimento da parte di importanti festival e premi come gli Oscar deriva solitamente dalla capacità di un film di riflettere qualcosa di più grande di sé: la singolarità di una cultura. Qualcosa di collettivo. Uno dei fattori chiave nella traiettoria di Io sono ancora qui è stato il modo in cui il pubblico brasiliano si è visto riflesso sullo schermo, si è sentito rappresentato e ha riempito le sale.
Il film ha avuto successo quando ha smesso di essere nostro ed è diventato di ogni spettatore. Quell’autenticità è stata percepita oltre i confini brasiliani, ha trovato eco a diverse latitudini e ci ha accompagnato nel nostro viaggio. È interessante notare che il fatto che il film rifletta una sensibilità essenzialmente brasiliana – nella sua narrazione e nelle interpretazioni profondamente interiorizzate di Fernanda Torres e Fernanda Montenegro – è ciò che gli ha permesso di esistere a livello globale.
Ho avuto la stessa sensazione guardando L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho: oltre al talento unico di Kleber, quello che conferisce al film la sua forza non comune è il modo in cui riflette qualcosa di così particolare: la città di Recife alla fine degli anni ’70 e la sua affascinante geografia umana. Invita il pubblico a scoprire chi eravamo in quel momento.
Il cinema infatti ha ancora un ruolo essenziale in Brasile. Riflette l’identità di un Paese, qualcosa in continuo movimento, ben più grande di qualsiasi governo o ideologia politica. Si tratta di creare una memoria collettiva, le cui radici risalgono alle pitture rupestri di Lascaux, Altamira o Cueva de las Manos, in Argentina. Qualcosa che gli autocrati non dovrebbero poter stroncare… eppure, a volte succede.
Cosa mi entusiasma di più dell’attuale direzione del nostro cinema? La sua polifonia, la sensazione di essere costantemente sorpresi dall’emergere di giovani registi e attori brillanti provenienti da diverse parti del Brasile. E spero davvero che continui così.
NADINE LABAKI - LIBANO

Nadine Labaki. Illustrazione di Alessandro Ventrella per Rolling Stone
Nata in Libano nel 1974, ha iniziato come attrice e regista di cortometraggi e videoclip. Il suo primo lungometraggio, Caramel (2007), la consacra sulla scena internazionale. Seguono E ora dove andiamo? (2011) e Cafarnao – Caos e miracoli (2018), Premio della giuria a Cannes e candidatura all’Oscar come miglior film internazionale nel 2019.
Ho parlato di molte questioni sociali nei miei film perché questa è la mia vera ossessione, e in questo momento a ossessionarmi più di tutto è la questione femminile, soprattutto in questi tempi folli. Mi sento sempre più incline a esplorare la relazione con i nostri compagni, e come la pressione sociale ha avuto un impatto sul nostro rapporto con noi stessi e sul modo in cui vediamo e interagiamo con il mondo. E naturalmente la follia di ciò che sta accadendo in questo mondo è qualcosa che è sempre nella mia testa, e che ispira molto anche il mio lavoro.
Stiamo vivendo in una sorta di paralisi, tutto sta diventando realmente assurdo. I valori con cui siamo stati cresciuti sono completamente cambiati, e non sappiamo più se sono giusti o sbagliati, se funzionano ancora, se hanno ancora un significato. È difficile per gli artisti esprimersi in generale, perché l’arte ha sempre provocato riflessioni, ha sempre creato dibattiti. Ma in questo tempo folle di correttezza politica imposta e di cancel culture penso che come artisti abbiamo sviluppato una sorta di autocensura, il che è molto pericoloso perché quando si inizia a censurare sé stessi si finisce per assomigliare tutti gli uni agli altri, a fare le stesse cose, a parlare degli stessi argomenti, a smussare gli angoli in modo che sia tutto lucido, o quantomeno accettabile. Succede soprattutto se non si ha la pelle dura per affrontare tutti gli attacchi o le ripercussioni che possono arrivare, perché viviamo in una sorta di tribunale pubblico dove tutti hanno il diritto di giudicare.
Queste sfide tematiche, e anche politiche, diventano ancora maggiori per chi opera in quest’area del mondo. Penso però che i film che arrivano da questa regione, dal Medio Oriente e da tutti i Paesi di lingua araba, siano molto interessanti e illuminanti. Sono voci importanti che si stanno facendo sentire sempre di più. Per molto tempo sono state forse un po’ timide, perché veniamo da parti del mondo in cui l’industria cinematografica non è così sviluppata. Oltre alle sfide politiche, dobbiamo affrontare anche quelle economiche. Non abbiamo istituzioni che ci aiutino, non possiamo forse nemmeno parlare di un’industria vera e propria.
Ma ci sono tanti artisti indipendenti molto validi, che dicono cose molto interessanti, che parlano dei problemi che stanno accadendo qui e ora. Il loro cinema mi ha aperto gli occhi, e oggi mi sento molto ottimista. Penso a Mahdi Fleifel: ho visto da poco il suo film To a Land Unknown, che era alla Quinzaine di Cannes l’anno scorso, e l’ho trovato bellissimo e necessario. O a un’autrice come Kaouther Ben Hania, tunisina, che con il suo ultimo film, Four Daughters, ha fatto un lavoro incredibile.
Ci sono così tante cose di cui parlare oggi. Può essere quello che sta accadendo a Gaza, o ciò che sta accadendo in Siria, o in tutte queste regioni del mondo. Persino quello che sta avvenendo in Arabia Saudita per quanto riguarda l’emancipazione delle donne. Dobbiamo fare luce su questi temi sperando – e soprattutto credendo – che il cinema possa ancora avere un impatto, o anche solo trovare il modo di creare dibattito, di mettere in evidenza un problema. Credo fortemente nel potere del cinema e nella responsabilità che ha sempre di più, soprattutto ora.
È così che, da locali, si diventa globali. Io sono cresciuta pensando che noi libanesi eravamo invisibili, che nessuno avrebbe mai sentito nulla di quello che abbiamo da dire, perché il nostro è un Paese così piccolo che quasi non esiste, sulla mappa del mondo. Ce lo diceva anche la nostra professoressa a scuola. Indicava sul cartellone quella strisciolina di terra e diceva: “Vedete? Il Libano è questo punto piccolissimo”. Inconsciamente, sono cresciuta pensando questo. Ma quando hai questo impulso, o senti di avere questa missione di mettere il tuo Paese sulla mappa, allora trovi il modo per farlo, e io ho usato questo strumento che è il cinema. Ed è sorprendente vedere che si può fare davvero, che si può portare un piccolo Paese là fuori, andare ai grandi festival, rendere visibile l’invisibile.
Non sono l’unica: credo che molti artisti di questa parte del mondo si siano sentiti invisibili per molto tempo. Ci siamo sempre sentiti non visti. Ci siamo sempre sentiti un po’ emarginati, o visti non con gli occhi giusti, sotto la luce giusta. Mettere in piazza tutto ciò che abbiamo da dire, parlare delle nostre culture, della nostra lingua, delle nostre personalità, dei nostri problemi, di ciò che sta accadendo nei nostri Paesi, e farlo davanti al mondo intero, crea una nuova identità locale, una memoria collettiva.
Ecco perché i festival e le piattaforme sono molto importanti, per farci ascoltare e farci vedere con occhi diversi. È così che una piccola storia, una piccola terra, può diventare qualcosa di grande, di universale.
Mi ricordo quando ho portato Caramel in giro per il mondo. Non ricordo in quale luogo fossi, ma ho ancora in mente questa donna che mi si avvicina e mi dice: “Non sapevo che voi libanesi siete così. Che siete così belli, colorati, affettuosi, sensibili”. Non sapevo che l’immaginazione delle persone nei nostri confronti fosse così diversa. E allora le ho detto: “È così che siamo”. E sono stata felice di raccontarglielo, e lì ho capito il potere che ha il cinema.
RODRIGO SOROGOYEN - SPAGNA

Rodrigo Sorogoyen. Illustrazione di Alessandro Ventrella per Rolling Stone
Nato a Madrid nel 1981, è nipote del cineasta Antonio del Amo. Nel 2008 ha esordito con 8 citas e nel 2010 ha fondato la casa di produzione Caballo Films. Ha ottenuto il primo successo internazionale con Stockholm (2013), finanziato con un crowdfunding e girato con soli 60.000 euro. Il thriller Che Dio ci perdoni (2016) lo consacra ai Goya, gli Oscar spagnoli, mentre Il regno (2018) ne vince sette. Il corto Madre arriva agli Academy Awards nel 2019 e diventa poi un lungometraggio (in concorso a Orizzonti a Venezia 76, dove Marta Nieto viene premiata per la miglior interpretazione femminile). Con As bestas – La terra della discordia (2022), dopo il debutto a Cannes, trionfa ai Goya 2023 con nove premi e conquista pubblico e critica. Nel 2024 presenta la serie Dieci Capodanni a Venezia 81.
Il mio Cinema non è il Cinema di un altro, anche se l’altro vive alla porta accanto. Il Cinema spagnolo oggi può essere considerato tale per fabbricazione e origine, ma non credo per tematiche, sensibilità o estetica. Esiste il Cinema italiano tout-court? Sarebbe come dire che esiste una psicologia pubblica italiana o spagnola o francese netta, definita e soprattutto definitiva. Mentre possiamo un po’ caricaturalmente pensare a qualche elemento comune che derivi dal brodo di coltura che tutti giocoforza condividiamo – in maniera avvertita o no, non cambia – è complesso raccogliere o addirittura indicizzare cose molto distanti tra di loro. Il Cinema quando diventa insieme, nota a margine o addirittura catalogo, smette di essere Cinema. È un’altra cosa: un’onda, una moda, un tic.
Qualcuno potrebbe dire che il carattere distintivo del nostro Cinema sia il surreale. Buñuel. Zulueta. Berlanga. Il primo Almodóvar. Tu spettatore, tu osservatore e tu critico hai pochi dubbi. È chiaro. Il DNA del Cinema spagnolo è questo. Ma io ti dico di no, non sono d’accordo. Perché per esempio c’è anche Carlos Saura. La conversazione deve partire da qui. Sì, la Spagna è un Paese plurale. Plurinazionale anche. È il nostro costante dialogo interiore. Autonomie e particolarismi fino al termine della notte: crisi, rotture, addirittura indipendentismi. Si parlano sei lingue diverse, tutte ufficialmente riconosciute dallo Stato. Tutto ciò entra e definisce il nostro Cinema? Sì. Ma anche no. Il ventaglio ampio dà possibilità, accresce le scelte percorribili, allarga il campo da gioco, ma non definisce in modo conclusivo. Un autore può starci dentro oppure no. È una sua scelta o non lo è, se per esempio ha poco da dire o anche se è semplicemente interessato ad altro.
Quello che mi sembra chiaro, ma non è una radiografia, è che il Cinema spagnolo ha avuto un salto di qualità formale negli ultimi anni. C’è una generazione nuova, con tutto il rispetto di chi ci ha preceduto, che ha prodotto un Cinema estremamente interessante. Ma non ci ritrovo un carattere nazionale. Non credo che ci siano tratti univoci nel Cinema spagnolo ma mi piace pensare che non ci siano nemmeno nel cinema italiano, francese o di qualunque altro Paese. Questo tipo di semplificazioni a mio modo di vedere sono utili e confortevoli ma in fondo eccessive e pertanto poco lucide. Voglio dire: Amenábar, Bayona o Álex de la Iglesia fanno cinema strettamente spagnolo? Non potrebbero essere americani per esempio? Carla Simón o Elena Martín fanno un Cinema che mi pare degno di interesse ma hanno qualcosa che le lega – o meglio, che leghi le rispettive opere – in maniera così adamantina?
Quello che sicuramente abbiamo ora in Spagna è un’industria che funziona. Difficile dire se sia stata la nascita e la costanza produttiva di autori rilevanti ad aver determinato una risposta di sistema o se sia piuttosto avvenuto il contrario. Forse non lo sapremo mai, sicuramente non è nemmeno una domanda che ci può togliere il sonno. È così, e va bene. È difficile distribuire pesi e meriti netti. Senza industria gli autori non riescono a portare avanti il proprio Cinema, questo è chiaro. E in più il cinema è una delle discipline più collettive che esistono. Almodóvar non è solo Almodóvar. Senza la musica di Alberto Iglesias qualunque suo film sarebbe un film differente. Quello che ti garantisce un’industria che funziona è un livello eccellente di professionalità nelle varie segmentazioni che compongono questo enorme sforzo collettivo chiamato film.
Dopodiché il flusso scorre su un doppio binario. Senza Almodóvar non sappiamo se Alberto Iglesias avrebbe mai composto quella musica. Io per esempio ho un formidabile gruppo di lavoro a cui chiedo un livello di pensiero ed esecuzione altissimo ma allo stesso tempo devo essere all’altezza del loro lavoro. Oltre a questo c’è senza dubbio un insieme di opere che possiamo considerare facenti parte del nuovo Cinema spagnolo e verso le quali provo soddisfazione o addirittura orgoglio.
Stanno comparendo molti registi e soprattutto molte registe di assoluto valore che non stanno raccontando la stessa storia presa da diverse angolazioni ma stanno proponendo una grande diversità e varietà di temi. Fino a qualche anno fa avevamo quattro o cinque film interessanti – ovviamente a mio modo di vedere – all’anno. Oggi saranno almeno 15, ogni stagione. È un momento felice. Stiamo assistendo a un movimento che si sta via via costruendo e formando a partire da sensibilità particolari e uniche tutte raccolte intorno a un denominatore che vede la personalità come carattere comune alle diverse voci che si alzano.