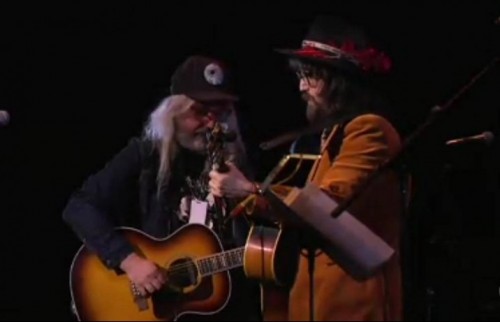Se c’è una cosa che i Flaming Lips hanno sempre adorato fare è giocare ai Pink Floyd. Il primo ricordo della band che i fratelli Coyne conservano (Mark ha ben presto lasciato il gruppo dopo il primo EP dell’84) è di quando “prendevano temporaneamente in prestito” gli strumenti nella loro parrocchia di Oklahoma City per andare in giro a strimpellare Dark Side of the Moon.
Disco che tra l’altro hanno reinterpretato nel 2009 con l’aiuto di altri due come Henry Rollins e Peaches. Col tempo poi questo pallino floydiano si è conservato, sopravvivendo ai periodi di smitragliate garage tipo Stooges e al progressive-pop, per arrivare pressoché intatto a questo nuovo Oczy Mlody. E se i primi approcci sembravano più compilation di vari artisti che veri dischi, tanto erano poco coerenti fra loro le tracce (complici forse anche i troppi viaggi lisergici), con l’avvicinarsi del nuovo millennio i Flaming Lips si sono fatti sempre più precisi con la mira, scegliendo con cura il taglio da dare a ogni singolo album e, soprattutto, perfezionando un’originalissima estetica musicale e visuale.
C’è stato quello concettuale, Zaireeka, opera allucinante divisa in quattro dischi da far suonare contemporaneamente a quattro stereo (ogni volta quindi suona diverso); quello che si crede un concerto per orchestra, The Soft Bulletin; c’è stato At War With the Mystics, un gigantesco passo indietro troppo incentrato sulle chitarre per non risultare datato; e poi c’è Yoshimi Battles the Pink Robots. Il fil rouge che li collega? La psichedelia che tinge di rosa il tessuto sonoro, ora non più spezzato come agli albori, ma fluido, omogeneo, quasi terapeutico. Perché, prima o poi, capita a tutti di dover dimenticare una delusione o una tremenda perdita cercando nella musica una via d’uscita: è solo che a Wayne Coyne è successo più spesso che a noi. Non è tanto per i 13 anni passati a friggere patatine al Long John Silver di Oklahoma City, una catena di fast food. Più che altro, è per i traumi indelebili che ne sono derivati, tra cui il piacevole pomeriggio da ostaggio in una rapina a mano armata dentro al ristorante. Mettici poi anche le varie tossicodipendenze più la morte del padre dopo una lunga malattia e sfido io a non rifugiarsi in un universo parallelo fatto di unicorni, confetti, farfalle, robot rosa e chi più ne ha più ne metta. «Per parlare di morte facciamo finta di essere a un compleanno anziché un funerale», ha detto Coyne in un’intervista, confermando che, nonostante le passate collaborazioni con le varie Miley Cyrus e Ke$ha, questa estetica kitsch non ha nulla da spartire con le frivolezze da teenage popstar. Qui c’è davvero dolore, strumento potentissimo per creare legami o consolidarne di già esistenti. Fra le reminiscenze barrettiane di We A Family, Coyne e i suoi ci invitano a unirci alla grande famiglia dei Flaming Lips, un focolare attorno al quale riunire tutti quelli che non conoscono tutto del mondo, ma di certo sanno cosa lo migliorerebbe. A corredo di questi slanci fra il fantasy e l’utopico, i Lips hanno disegnato paesaggi lisergici presi in prestito non dai Beatles di Sgt. Pepper’s, come molto spesso hanno fatto in passato, ma più volentieri da un Kid A radioheadiano, sempre con un occhio rivolto ai Pink Floyd.
Elettronica, insomma, che all’occorrenza può mostrarsi con le sembianze di un trip hop romantico, The Castle, o di un attualissimo dub, Nigdy Nie (Never No). Roba che, se fossi un alt rocker coetaneo di Coyne, non dico che mi vergognerei del mio set di pedalini vintage, ma sicuramente mi sentirei di colpo vecchio, come se vivendo al di fuori del mondo fatato dei Flaming Lips il tempo fosse trascorso più in fretta per me. Forse è davvero così, merito dei 30 anni trascorsi, fra una tragedia e l’altra, a ripiegare su schitarrate, cartoni giapponesi e pure quelli di LSD. Tanto del futuro non v’è certezza, quindi parafrasando Baudelaire tanto vale inebriarsi in un’orgia di colori, suoni e magari corpi. “E se poi dovessero arrivare i poliziotti”, dice la voce sotto acidi verso la fine di There Should Be Unicorns, “daremo loro così tanti soldi che potranno soltanto andare in pensione dal loro lavoro di merda e vivere l’esistenza più grandiosa di sempre”.