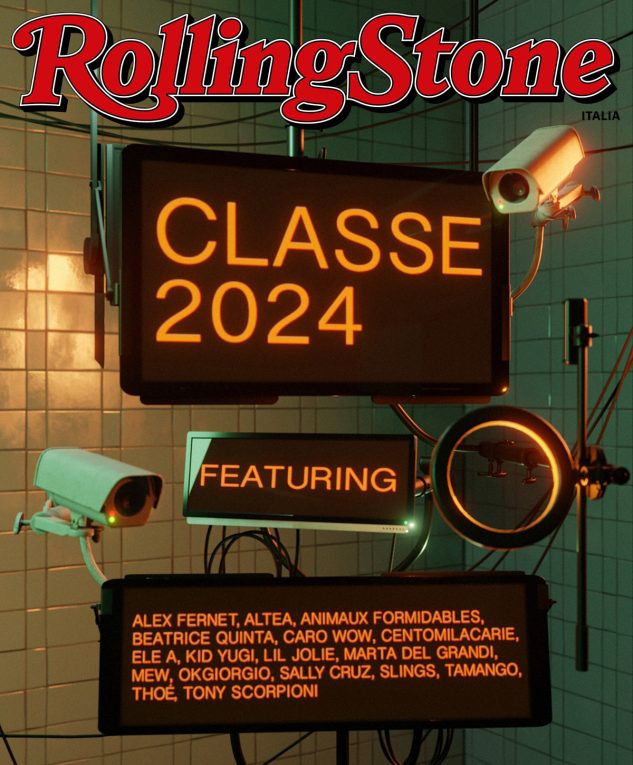Chris Martin non vuole più compiacerti
Dopo 20 anni alla guida dei Coldplay, il cantante si è liberato dell’immagine da popstar della porta accanto e ha scritto il suo disco più politico e personale
Foto: Getty Images
Quando i Coldplay sono apparsi per la prima volta sulle pagine di Rolling Stone USA, nel 2000, la redazione si chiedeva: i ragazzi di questo gruppo brit pop diventeranno i nuovi Radiohead? O i nuovi Verve? Oggi, è chiaro che non erano nessuna di queste cose. Negli ultimi 20 anni, i Coldplay hanno trovato il loro posto nel mondo: sono ottimisti capaci di riempire gli stadi e sfuggire alle definizioni di genere nell’era dell’ironia. Oggi sono probabilmente una delle band più grandi del mondo: il tour di supporto di A Head Full of Dreams, partito con il concerto al Super Bowl al fianco di Beyoncé e Bruno Mars, ha incassato 523 milioni di dollari. Tutto questo successo ha costretto il frontman Chris Martin a fare un passo indietro.
«Sentivo un leggero senso di pace», dice durante il nostro incontro a New York. «Tutto quello che dobbiamo fare, adesso, è inseguire la nostra musa». Everyday Life, l’ottavo disco dei Coldplay, è diverso da quelli che l’hanno preceduto, è un doppio album meditativo che abbraccia gospel, folk e persino l’afrobeat. Martin, da parte sua, affronta temi scottanti come il controllo delle armi, l’incarcerazione di massa, il razzismo (Trouble in Town contiene clip audio in cui gli agenti della polizia di Philadelphia maltrattano afroamericani innocenti) e la paternità (ha avuto due figli dall’ex moglie Gwyneth Paltrow). Martin è orgoglioso dell’album, anche se non è certo della sua solidità commerciale. L’appagamento che sente, però, è il risultato di un lavoro che va avanti da quando ha iniziato a scrivere. Ecco come ci è arrivato.
Che cosa ti ha portato verso la musica? Come hai iniziato?
Quando avevo 11 anni, andavo in una scuola vecchio stampo, e a un certo punto è arrivato un insegnante un po’ anticonformista. Mi avevano già detto che non ero portato per la musica perché non cantavo nel coro o cose del genere. Poi è arrivato questo tizio e ha detto: “No, tutti sono portati per la musica”. C’erano parecchie tastiere in aula, e ha aggiunto: “Prendetele e divertitevi un po’”. È stato come se dentro di me si fosse aperta una porta. Alla fine della lezione gli ho detto: “Ehi, guarda che cosa ho scritto!”. Mi ha incoraggiato molto. È così che si è acceso un piccolo fuoco.
In quel momento?
In quel momento. Per qualche anno non ho saputo cosa farci. Ho vissuto qualche momento difficile a 13, 14 anni, ed è allora che ho pensato: “Devo fare qualcosa di mio. Divertirmi e giocare a calcio non è abbastanza”.
Non ti sentivi a tuo agio con gli altri ragazzi?
Un po’, ma all’epoca pensavo molto a religione e sessualità, ero confuso come molti ragazzi della mia età. Pensavo: “Che cosa mi sta succedendo?”. Può essere brutale. Ma è quello che ha riacceso il fuoco. “Ok, devo solo mettermi al lavoro”.
Che cosa ascoltavi?
Ho avuto un’educazione doppia, molto strana. Da un lato ascoltavo molta musica da chiesa, perché ogni giorno andavo lì a cantare queste canzoni grandi e meravigliose. Dall’altro, ero fissato con una band, i James, e tutto lo shoegaze che girava in Inghilterra negli anni ’90. Poi i Cure, gli U2 e i R.E.M. C’era un tizio, un anno più grande di me, che era ossessionato dal soul e dall’r&b.
Il nuovo album si apre con un’invocazione da chiesa e ospita un coro gospel. In tutto il disco ci sono molti suoni da chiesa. Crescendo, com’era il tuo rapporto con dio e la chiesa?
Ero un bambino fortunato, perché mia mamma è dello Zimbabwe. Andavo lì e vedevo un lato diverso della vita. Quell’esperienza mi ha fatto capire che nel mondo ci sono cose più grandi di me. La mia relazione con dio, all’epoca, era quella di un bambino che pensava a un tizio barbuto nel cielo, un uomo piuttosto gentile ma altrettanto punitivo. Se facevi qualcosa di sbagliato, rischiavi di bruciare all’inferno, il che è piuttosto terrificante per un bambino. Nel mezzo di tutto questo, però, c’era anche il calore che arrivava dai profeti, incluso Gesù. Ricevevo un sacco di ottimi insegnamenti. Insomma, per un po’ ho pensato: “Metà di questa cosa mi sembra molto giusta, il resto mi fa paura”.
Condividi lo stesso background degli U2. Questo rapporto con la religione è al centro della loro identità, almeno agli inizi. Ma ancora oggi continuano a predicare…
È andata così: ai tempi del collegio avevo tante cose per la testa. Ero anche un po’ omofobo, perché pensavo: “Se fossi gay sarei fottuto per l’eternità”. Ero anche un ragazzino alla scoperta della sua sessualità. “Forse sono gay, ma non posso”. Ero terrorizzato. Studiavo in un collegio pieno di ragazzi difficili e per molto tempo mi hanno detto: “Sì, sei sicuramente gay”. Lo facevano alla vecchia maniera, in modo aggressivo. Sono stati anni molto strani, per me.
Pensavi davvero di essere gay?
Non lo so. Pensavo: “Se anche lo fossi non potrei esserlo, perché è sbagliato”. L’idea mi tormentava molto.
Ti avevano convinto loro?
Ho iniziato a preoccuparmene, certo. A 15 anni e mezzo ho smesso nel giro di una notte. Mi sono detto: “E anche se fossi gay? Che importa?”.
Che cosa è cambiato?
Ho smesso di preoccuparmi di chi mi provocava. Forse era perché leggevo molto Elton John, avevo capito che molti dei miei eroi erano gay, ho capito che non era importante. Mi sono liberato di un peso enorme. Ho iniziato a pensare: “Ehi, forse alcune delle cose che studio sulla religione… non sono sicuro di sentirle mie”. Oggi per me dio è in tutti e in ogni cosa, è amore, è il miracolo in ogni cellula di ogni cosa.
Scrivi musica commerciale da quasi 20 anni, ma in tutto questo tempo hai registrato solo otto album. Perché impieghi così tanto tempo?
È un’ottima domanda. Credo che avrei potuto farne 50, ma sarebbero stati dischi peggiori.
Stai facendo il modesto?
No, affatto. Ma i Coldplay e Rolling Stone hanno dei precedenti, quindi non so cosa avreste scritto. Abbiamo un rapporto travagliato con la stampa e ci va bene così, ma non voglio arrivare a pensare: “Abbiamo scritto otto capolavori”. Ricordo quando abbiamo suonato per la prima volta in America, a SNL, e ho letto una recensione di Rolling Stone del nostro singolo. Non era buona.
Che singolo?
Il primo, Yellow. Ho pensato: “Ok, dobbiamo fare meglio di così”.
È interessante che ricordi questo particolare, invece delle altre 30 cose positive che abbiamo scritto sui Coldplay. Nel 2005 vi abbiamo definito la band dell’anno.
Sì, grazie. Ma insomma, perché siamo così lenti? C’è qualcosa, dentro di me, che mi dice quando un disco è finito. Ed è successo solo otto volte. Anzi, sette volte negli ultimi 19 anni. Una volta non è successo e abbiamo pubblicato lo stesso l’album: era il terzo, X&Y.
Ma è andato benissimo, no?
Sì, ma non è importante.
Come funziona il momento in cui pensi: “Abbiamo finito, il disco è pronto”?
Perdonami se suona pretenzioso: se nelle nostre teste sappiamo già il titolo dell’album, è come la cornice di un quadro. E sappiamo bene che cosa dovrà contenere. Quindi, anche se abbiamo 15 belle canzoni, se non stanno bene in quella cornice le scartiamo. Per questo abbiamo tanti brani persi per strada. Non tanti quanto Bruce Springsteen, che ha pubblicato 72 canzoni in Tracks…
Che cosa c’è di diverso in Everyday Life?
Beh, è un mondo a parte. Per fare un disco così abbiamo dovuto tirare fuori un po’ di palle. È la prima volta che abbiamo detto davvero cosa pensiamo di alcune tematiche. Cerchiamo di essere empatici. È un disco completamente senza filtri. Grezzo e puro.
In un certo senso, sembra un concept album. Perché un concept, o anche un doppio, in un’epoca in cui tutti sono concentrati sui singoli?
Perché ci siamo fatti del male? Perché è quello che mi hanno insegnato. Le ultime cose che abbiamo fatto sono state divertenti, abbiamo suonato di fronte a tanta gente e in molti posti diversi. Poi siamo andati al Super Bowl, ed è stato grandioso. Tutto quello che ci resta da fare, adesso, è inseguire la nostra musa. Volevo solo cantare degli altri, di altre persone, e di come mi sento di fronte al mondo e a quello che sta succedendo. Non c’è un concept, ci siamo solo chiesti: “Com’è vivere un giorno qualunque per me e il resto del mondo?”

Chris Martin e Beyoncé durante l’halftime show del Super Bowl. Foto: Getty Images
Alla fine dici: “Got to keep dancing when the lights go out”. È questo il messaggio che vuoi lasciare alla fine dell’album?
Sì. Quello che penso, onestamente, è che questo album è il nostro modo per dire: “Vaffanculo, non ci interessa cosa pensano gli altri. Facciamo quel che vogliamo”. Dobbiamo trattare la vita come se fosse una cosa preziosa, accoglierla e accogliere tutti, e fare del nostro meglio per aiutare gli altri, perché quando lo fai ti prendi cura di te stesso. Siamo sempre in giro per il mondo e sono convinto che facciamo tutti parte della stessa famiglia. Non credo nel tribalismo. Non credo nel nazionalismo. Credo che siamo stati messi qui da qualcosa di più grande di noi, ne sono ammirato e sono grato di esserci, anche se fossi l’unico a fare quello che faccio.
Ci sono un paio di canzoni a proposito dei figli, come Daddy.
Daddy parla di alcune persone che conosco, tutte abbandonate dai loro padri. Parla anche di me, di quando penso: “Sto abbastanza tempo con i miei figli?”. E anche del problema delle incarcerazioni di massa in America. Sono tantissimi i padri allontanati dalle famiglie, e succede in maniera sistematica e istituzionalizzata, è sbagliato. Tutte queste emozioni si mescolano insieme e viene fuori un brano così.
Non sembra nemmeno una canzone rock…
Non siamo una rock band. Mettiamo le cose in chiaro!
Poi c’è Guns (“The judgment of the court is we need more guns…”) che è un pezzo atipico per i Coldplay. Sembra una canzone di protesta.
Ovviamente, visto che ora abito a Los Angeles, sono molto più consapevole delle questioni legate al Secondo Emendamento. Suono musica tutto il tempo, e all’improvviso una piccola canzone è piovuta dal cielo, e quando succede di solito sono le migliori. Molte canzoni di quest’album sono arrivate così.
Sembra un po’ Paul Simon, nella voce e nelle ritmiche.
La risposta onesta è che è un brano figlio dei miei ascolti, Paul Simon e i Rammstein, uno strano matrimonio. Ho chiesto a uno dei nostri produttori, Bill Rahko, un metallaro, di insegnarmi a suonare quel tipo di riff. Pensavo sarebbe stato interessante provare cose del genere in un pezzo acustico.
Quando hai scoperto il tuo falsetto?
Quando sono esplosi i Radiohead. Ero un teenager e loro avevano un background simile al mio. Mi hanno aperto un mondo, mi hanno fatto pensare che avrei potuto fare qualcosa del genere anch’io. Il disco era The Bends e Thom Yorke aveva ascoltato Jeff Buckley cantare in falsetto. Sono arrivato io e mi sono detto che riuscivo ad arrivare così in alto anch’io. A 17 o 18 anni, Jeff Buckley e i Radiohead mi hanno aperto un mondo nuovo.
Hai collaborato con Brian Eno per un paio di album. Gli U2 sono stati un’influenza importante per te?
Nel nostro terzo album puoi sicuramente sentire un po’ di U2. Quella è l’unica volta, se vuoi una risposta onesta, in cui abbiamo detto: “Proviamo a fare gli stessi passi”. Gli U2 e i Radiohead ci hanno influenzato soprattutto nel metodo di lavoro: i rapporti interni alla band, la suddivisione del denaro e dei diritti, e il fatto che non si vergognassero di diventare grandi. È divertente parlare di queste cose proprio dopo aver pubblicato un disco piccolo e discreto.
Restate comunque una band che suona negli stadi…
Chi lo sa? Non andremo in tour per questo album. Faremo eventi strani, piccoli show, perché è tutto più intimo. Il concetto di “band da stadio” ha a che fare con la coscienza collettiva. Ci sarà un momento in cui un intero palazzetto canta all’unisono? Non sono loro che guardano noi, o noi a suonare per loro – c’è un noi, che crea un’energia. Ed è una grande energia.
Cosa pensi quando sei sul palco?
Adoriamo il momento in cui i braccialetti si illuminano. Li ha inventati un tizio che prima costruiva sex toys. Doveva venire a un concerto, 10 anni fa, ma non ci è riuscito, e ha scritto una mail a Phil, il mio migliore amico e direttore creativo, che gli ha detto: “Ci inventeremo qualcosa”. Per ricambiare, il tizio ha detto: “Comunque, ho inventato questo braccialetto che si illumina. Lo volete provare?”. Phil ha risposto: “Stai scherzando? Sì, cazzo!”. Ci abbiamo investito e l’abbiamo prodotto. Quello è un momento che aspetto sempre, perché è lì che penso: “Ok, amo suonare per così tanta gente”. Lo amo.
Quando vai a un concerto di Bruce Springsteen succede la stessa cosa. È come se volesse sollevarci tutti…
Quando Bruce Springsteen è entrato nella mia vita, è stato come quando è arrivato Rumi, il poeta. Ha cambiato tutto, cazzo. Perché Bruce ha raggiunto il successo e si è chiesto: “Ok, cosa posso fare da questa posizione?”, invece di dire: “Ce l’ho fatta, posso ritirarmi e comprare un ranch”. Ha pensato: “Cosa posso fare con il mio dono?”. E si dà completamente ogni volta, per migliaia di volte. Dà tutto se stesso. Vedendo Bruce ho capito che il mio lavoro è essere totalmente e senza alcuna vergogna al servizio di chi ascolta. Devo essere al 100% usato come strumento dalle forze che mi hanno dato questo dono.
Hai imparato qualcos’altro da Bruce, qualcosa di più specifico?
Amo la sua musica. L’ho conosciuto ascoltando la cover di Highway Patrolman di Johnny Cash, che mi ha portato a Nebraska. Ho pensato: “Oh, questo non è quello che mi aspettavo da Bruce Springsteen”. Poi sono passato a Greetings From Asbury Park e Born to Run. Ho cominciato a nutrirmene, e notare la sua attenzione ai dettagli…
È determinato. È un pensatore rigoroso. Noi due ci siamo incontrati nel backstage di un suo concerto…
Sì, in una stanza piena di gente. Mi hai detto: “Mi prendi un drink, per favore?”. E io ho risposto: “No, sono una rockstar”.
Sapevo che eri una rockstar. Eri sospettoso perché avevi visto un tizio della stampa seduto di fronte a te in un camerino.
Sicuramente. All’epoca pensavo, “quello è il tizio che ha Us Weekly, i paparazzi e roba del genere. Non sono sicuro che mi piaccia”. Ora ho idee diverse, sei una persona adorabile.
Fammi dire due cose. Ho letto da qualche parte che sei considerato il vegetariano più sexy del mondo.
Sì, credo sia sbagliato da almeno tre punti di vista.
Altre notizie per me?
Sono il pescetariano più stacanovista di North London, e mangio il tacchino. Un titolo molto meno glamourous.
Che cosa succede nella tua testa quando senti che sei considerato un sex symbol, una star che suona negli stadi?
Devi chiederlo a qualcun altro. Non mi sento così adesso, Jann. Quando suono negli stadi, invece sì.
Sei quasi un’anti-rockstar, sei incredibilmente riservato.
Non capisco cosa vuoi dire.
Che nascondi bene le tue carte.
Sì, è vero.
E stai alla larga dalla stampa.
Ci provo.
Perché?
Tutte le nostre canzoni sono molto personali. Tutto quello che ho da dire è lì, gli amori, le sconfitte e tutto il resto. È tutto lì. Preferisco fare come Bob Dylan, non spiegare nulla, perché non voglio rovinare l’interpretazione degli altri. Tutte le nostre canzoni sono personali, devono essere filtrate dalle nostre esperienze.
Una volta hai dichiarato che volevi che i Coldplay diventassero la band più grande del mondo…
Sì.
Ci siete riusciti?
Non lo dirò mai.
Ma è già successo. I Beatles l’hanno detto. Gli U2 l’hanno detto. Perché tu no?
Non mi importa più così tanto. Credo che il nostro lavoro sia essere la versione migliore di noi stessi. I Coldplay esistono perché amiamo suonare, lo amiamo davvero, e vogliamo raggiungere più persone possibile registrando dischi e andando in tour. Siamo i migliori Coldplay di sempre.